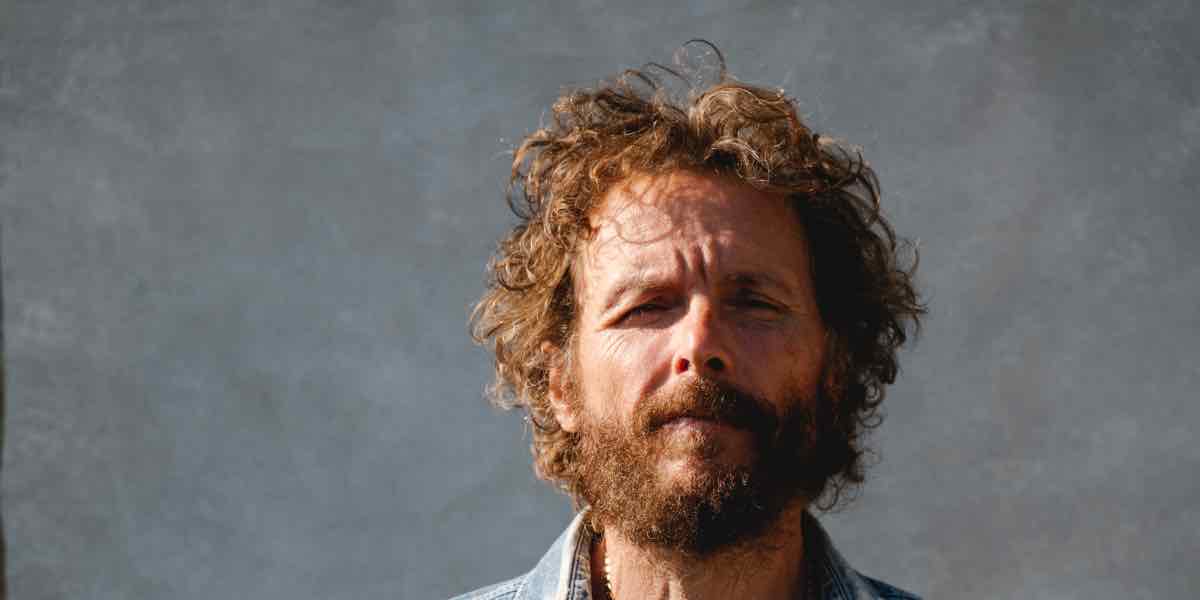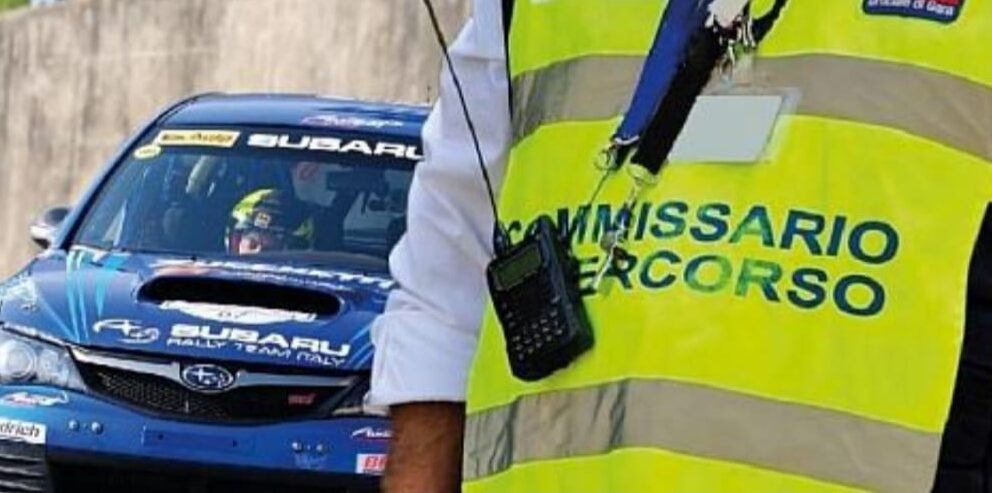La commodity nella tazzina
Dopo il petrolio, il caffè è la materia prima più commercializzata... nonché oggetto di manovre di natura squisitamente finanziaria, senza legame diretto con l’andamento dei raccolti e dei consumi L'articolo La commodity nella tazzina proviene da Economy Magazine.

Lo sanno tutti ma è bene ripeterlo. Nei Paesi sviluppati, il caffè è, in valore, la seconda commodity più commercializzata, dopo il petrolio. Più del grano e del riso! Ma la vera notizia oggi è un’altra: per il secondo anno consecutivo (2022 e 2023) si è bevuto più caffè di quanto se ne produca. Parlano i numeri: a una produzione relativamente stabile – 170,8 milioni di sacchi nel 2021, circa 168 milioni nel biennio successivo – ha fatto riscontro un aumento dei consumi, che sono passati dai 169,9 milioni di sacchi del 2021 ai 173,1 milioni del 2023.
Ed è una tendenza destinata a consolidarsi negli anni a venire. «Per quanto riguarda il 2024», spiega Michele Monzini, vicepresidente di Caffè Mokito e presidente del Consorzio Promozione Caffè (che riunisce i principali operatori della filiera, dall’importazione del caffè crudo, alla torrefazione oltre che i produttori di macchine del caffè e impianti industriali di torrefazione), «il giro d’affari è stimato in 132,13 miliardi di dollari, con la previsione di raggiungere i 166,39 miliardi di dollari entro il 2029. Questo incremento si traduce in un tasso di crescita annuale composto del 4,72%, sottolineando l’espansione di questo settore, trainata sia dalla domanda internazionale sia dalle nuove tendenze di consumo».
«Le dinamiche di consumo e produzione di caffè a livello globale», aggiunge Marco Simonetti, amministratore delegato di Caffè Toraldo, «sono soggette a molte variabili: eventi climatici, oscillazioni dei prezzi e cambiamenti nelle abitudini di consumo. Ciò che è certo è che, negli ultimi anni, abbiamo assistito a una riduzione delle scorte mondiali. L’Italia soddisfa la domanda grazie al numero elevato di torrefazioni e all’evoluzione delle modalità di consumo, che hanno portato a una diversificazione dei formati. La nostra strategia si concentra sull’adattamento a questo scenario attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, l’ottimizzazione dei processi produttivi, una presenza capillare in tutti i canali distributivi. Questo ci consente di reagire prontamente alle fluttuazioni del mercato, cercando di trasformarle in opportunità di innovazione e crescita. Inoltre, investiamo risorse significative nella comunicazione per trasmettere con trasparenza i nostri valori e mantenere la fiducia dei consumatori».
«In Italia», prosegue Monzini, «il settore della torrefazione continua a essere un pilastro dell’economia legata al caffè, con oltre 800 aziende attive sul territorio nazionale e circa settemila lavoratori impiegati direttamente nel comparto. Peraltro, sebbene il numero di torrefazioni sia relativamente stabile nel tempo, si registra un aumento di micro-torrefazioni artigianali che puntano su nuove nicchie di mercato, spostando l’attenzione verso innovazione e qualità».
Ma anche se le aziende del settore fronteggiano questo esubero della domanda attingendo a scorte prudentemente accantonate negli anni passati, a tutto c’è un limite: è evidente che questa situazione non potrà durare a lungo senza riflettersi sui prezzi, che sono quanto mai irrequieti.
Volatilità e insicurezza del mercato peraltro non sono determinate solo da elementi oggettivi. Il caffè, infatti, è una commodity che è da sempre oggetto di manovre e interessi di natura squisitamente finanziaria, senza legame diretto con l’andamento dei raccolti e dei consumi: proprio nel corso del 2024, si è registrata una dinamica emblematica dei condizionamenti esercitati dalla finanza sul mondo del caffè. «Come si sa», racconta David Brussa, Chief Quality & Sustainability Officer di Illycaffè, «le due specie (su oltre 130 esistenti) che vengono utilizzate per il consumo di caffè sono la Coffea Arabica e la Coffea Canephora, detta Robusta, più ricca di caffeina (quasi il doppio) ma meno aromatica e pregiata. Tanto è vero che il valore dell’Arabica sul mercato fino a dieci mesi fa era triplo rispetto a quello della Robusta, della quale uno dei principali produttori mondiali è il Vietnam. A causa della siccità che ha colpito quel paese e delle malattie che hanno attaccato le piante, la produzione di Robusta quest’anno è drasticamente diminuita e, come prima conseguenza, il suo prezzo è aumentato, avvicinandosi di molto a quello dell’Arabica, i cui volumi di produzione sono rimasti invece stabili. Per mantenere le differenze di prezzo tra le due qualità di caffè, si è scatenato quindi un perverso meccanismo di mercato, che ha portato anche il prezzo dell’Arabica a crescere a sua volta fino a raddoppiare, facendo così saltare tutti i budget e le pianificazioni dei produttori».
«Per i produttori», spiega ancora Monzini, «affrontare gli sbalzi di prezzo significa impegnarsi costantemente per ottimizzare i processi, tutelare le relazioni con i coltivatori e valorizzare l’immagine del caffè come ambasciatore del Made in Italy. È necessario, infatti, considerare che un prezzo più alto non è solo una conseguenza delle dinamiche globali, ma anche il riflesso del lavoro etico e della qualità che il consumatore si aspetta da un prodotto di eccellenza. Il caffè che beviamo ogni mattina è il risultato di un processo che coinvolge ogni anello della filiera, dai coltivatori alle torrefazioni, fino ai baristi. Ed è anche il frutto di una catena globale, in cui fattori economici, climatici e logistici hanno un impatto diretto sui prezzi. Ma poiché il caffè in Italia è un simbolo culturale e un rito quotidiano irrinunciabile, i consumatori italiani mostrano una forte propensione a sostenere la qualità, accettando eventualmente un costo più elevato per garantire un prodotto che rispecchi i valori di eccellenza, sostenibilità e rispetto della filiera».
Secondo una ricerca promossa dal Consorzio Promozione Caffè, il 91,3% degli italiani apprezza il caffè proprio per la sua capacità di unire tradizione e innovazione. Ed è proprio questo approccio ad ampliare le occasioni di consumo e soprattutto a contribuire a rafforzare il legame culturale ed emozionale tra il caffè e le nuove generazioni. «Tra i giovani», commenta Simonetti, «l’interesse verso il caffè è alimentato dalla moda: un fenomeno di stile che trova terreno fertile soprattutto nei social media, dove il caffè diventa protagonista di creazioni originali, come il frappuccino, che spopola tra i giovani ed è entrato stabilmente a fare parte delle loro abitudini di consumo. In parallelo, si osserva una crescente attenzione di questa fascia di consumatori verso i valori etici, con una predilezione per prodotti biologici e un forte interesse per temi come il riciclo del packaging, il risparmio energetico e le pratiche agricole responsabili».
«Pur mantenendo un profondo legame con la tradizione», conferma Monzini, «il caffè non è più solo espresso o cappuccino, ma un prodotto che si apre a modalità di consumo in grado di attirare le nuove generazioni. Un esempio di questa evoluzione è la coffee mixology, tendenza sempre più diffusa anche in Italia, dove il caffè diventa ingrediente di drink alcolici e analcolici, i cosiddetti coffetail, ossia cocktail a base di caffè, posizionati in momenti della giornata diversi da quelli abituali, come l’aperitivo o il dopocena».
L'articolo La commodity nella tazzina proviene da Economy Magazine.