Dungeons&Dragons elimina le ‘razze’: che senso ha se la diversità fa da base al conflitto?
La recente decisione di modificare la terminologia relativa al concetto di “razza” nel contesto di Dungeons & Dragons (D&D) merita un’attenta analisi. Sebbene il termine “razza” non abbia alcuna consistenza scientifica se riferito a Homo sapiens, esso continua tuttavia ad esercitare una notevole influenza culturale e psicologica di cui occorre tener conto. Tale aspetto sottolinea […] L'articolo Dungeons&Dragons elimina le ‘razze’: che senso ha se la diversità fa da base al conflitto? proviene da Il Fatto Quotidiano.
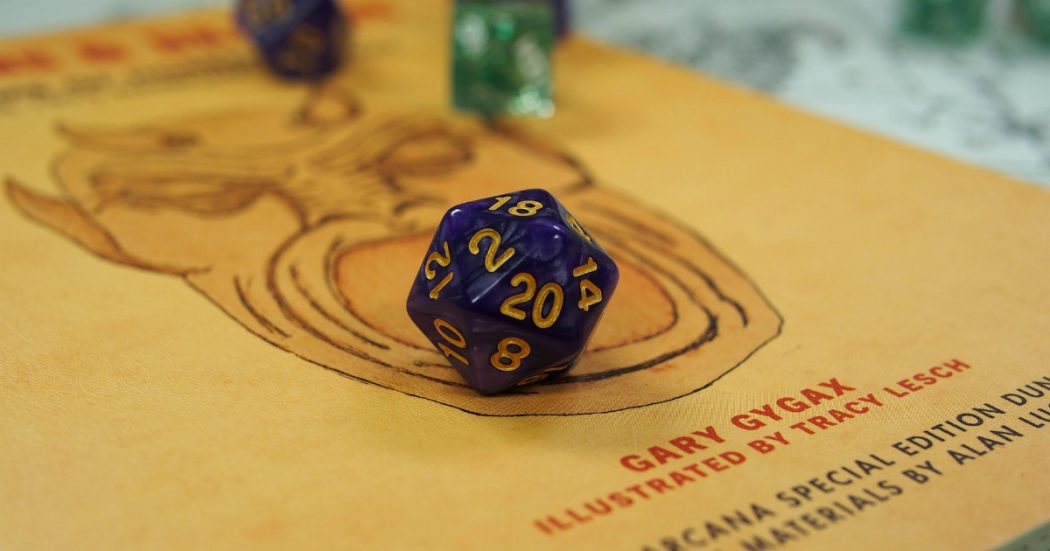
La recente decisione di modificare la terminologia relativa al concetto di “razza” nel contesto di Dungeons & Dragons (D&D) merita un’attenta analisi. Sebbene il termine “razza” non abbia alcuna consistenza scientifica se riferito a Homo sapiens, esso continua tuttavia ad esercitare una notevole influenza culturale e psicologica di cui occorre tener conto. Tale aspetto sottolinea ancor più l’importanza di un approccio consapevole alla divulgazione di concetti e scoperte controintuitive che, discostandosi dalle evidenze sensibili, necessitano a maggior ragione di strategie comunicative adeguate. Modificare un prodotto del 1974, pur con l’intento di promuovere diversità e inclusività, solleva non solo interrogativi legati alla specificità del gioco, ma anche dubbi di carattere più generale.
Il termine “razza” è utilizzato in D&D per differenziare tra loro creature immaginarie quali elfi, nani, orchi, in base ad aspetto, peculiarità intellettuali e caratteristiche culturali. Il termine “classe” è invece necessario per definirne il ruolo, ovvero le abilità alle quali possono accedere divenendo guerrieri, maghi, chierici e quant’altro. Comunque si vogliano rinominare queste differenze, sta di fatto che, in D&D, la diversità rappresenta da sempre il fulcro stesso del gioco. Ma qui bisogna ben intendersi. Nel gioco di Gary Gygax e Dave Arneson la diversità è alla base della conflittualità che caratterizza il fantasy tutto.
D&D è un mondo in cui guerrieri senza scrupoli decapitano serpenti ancestrali, seducenti elfi oscuri avvelenano gli amanti, nani ubriachi si pestano imprecando in fumose locande. È un universo in cui coesistono schiavitù, pena di morte, prostituzione, elementi che contribuiscono strutturalmente a creare un’atmosfera drammatica e immersiva in cui poter sperimentare anche i propri lati oscuri, senza tuttavia far del male a nessuno. Capisco che Stranger Things, The Big Bang Theory o Freaks and Geeks abbiano trasformato un gioco per pochi in un fenomeno di massa e che Hasbro voglia cavalcare la moda woke per conquistare nuovi mercati. Ma che vuol dire promuovere la diversità, come precondizione all’inclusività, in un contesto in cui le differenze sono alla base di un conflitto radicale senza il quale il gioco non avrebbe senso? Si vuole intervenire sul termine “razza”, o sulla conflittualità che ne deriva? Perché non abolire il consumo di alcol, il sangue, il sesso e tutti gli altri “elementi disturbanti” che non piacciono a certe élite radical, dal sapore vagamente orwelliano? Ve li immaginate elfi e nani che si recano amabilmente alla capanna dell’halfling gender fluid per fare shopping? E che dire di mamma orco che accompagna il suo piccolo nella classe inclusiva dove creaturine diverse coesistono in dolce armonia? Tanto varrebbe chiamarlo Daisies&Donuts.
Esiste poi una questione più generale, ovvero la tendenza a revisionare prodotti culturali del passato per allinearli alle sensibilità del presente. Piuttosto che alterare arbitrariamente film, libri, giochi e opere d’arte esistenti, non sarebbe più sensato creare nuovi contenuti che riflettano i valori attuali? Questa pratica, che in alcuni casi può apparire come una mera operazione di marketing, in altri assume i contorni di una vera e propria riscrittura culturale, reinterpretando il passato alla luce delle esigenze del presente. Se si accetta il principio secondo cui qualsiasi opera deve essere riformulata per rispecchiare la sensibilità contemporanea, si rischia di cadere in una deriva revisionista con precedenti storici inquietanti.
Alcune di queste iniziative, peraltro, rischiano paradossalmente di acuire il vizio da cui vorrebbero liberarci. Le categorie, ad esempio, lungi dall’essere strumenti neutrali, agiscono come costrutti sociali che non solo descrivono, ma prescrivono modi di pensare, agire e relazionarsi, creando e rafforzando confini artificiali. Quando tale approccio diventa pervasivo di ogni ambito dello scibile umano (sesso, cibo, età) finisce col comprimere la complessità della realtà all’interno di schemi e griglie nelle quali imprigionare cose, persone, finanche creature immaginarie.
Emerge infine una contraddizione di fondo: si afferma di voler promuovere la diversità come valore, eppure si cerca di farlo eliminando o attenuando proprio ciò che rende le cose diverse. L’antropologo Claude Lévi-Strauss osservava che “l’umanità si trova divisa in segmenti che tendono a distinguersi gli uni dagli altri non per isolarsi, ma per affermare la loro esistenza” (Razza e storia, 1952). Le differenze non sono barriere da abbattere, ma elementi costitutivi dell’identità, senza i quali la stessa idea di pluralismo perde significato. Questo concetto è stato ripreso anche dal sociologo Zygmunt Bauman, il quale evidenziava come “l’inclusione autentica non si realizza con l’assimilazione forzata, ma con la capacità di accogliere l’altro nella sua irriducibile alterità” (Modernità liquida, 2000).
Realizzare un paradigma di inclusione attraverso l’erezione di nuove barriere o la tracciatura di nuovi confini è un’operazione che può avere solo due matrici: l’ignoranza o la malafede. In una società inclusiva, le differenze saranno semplicemente irrilevanti: a tali aspetti nessuno farà più caso, esattamente come avviene oggi per il colore dei capelli, la lateralità manuale o il tono della voce.
L'articolo Dungeons&Dragons elimina le ‘razze’: che senso ha se la diversità fa da base al conflitto? proviene da Il Fatto Quotidiano.


















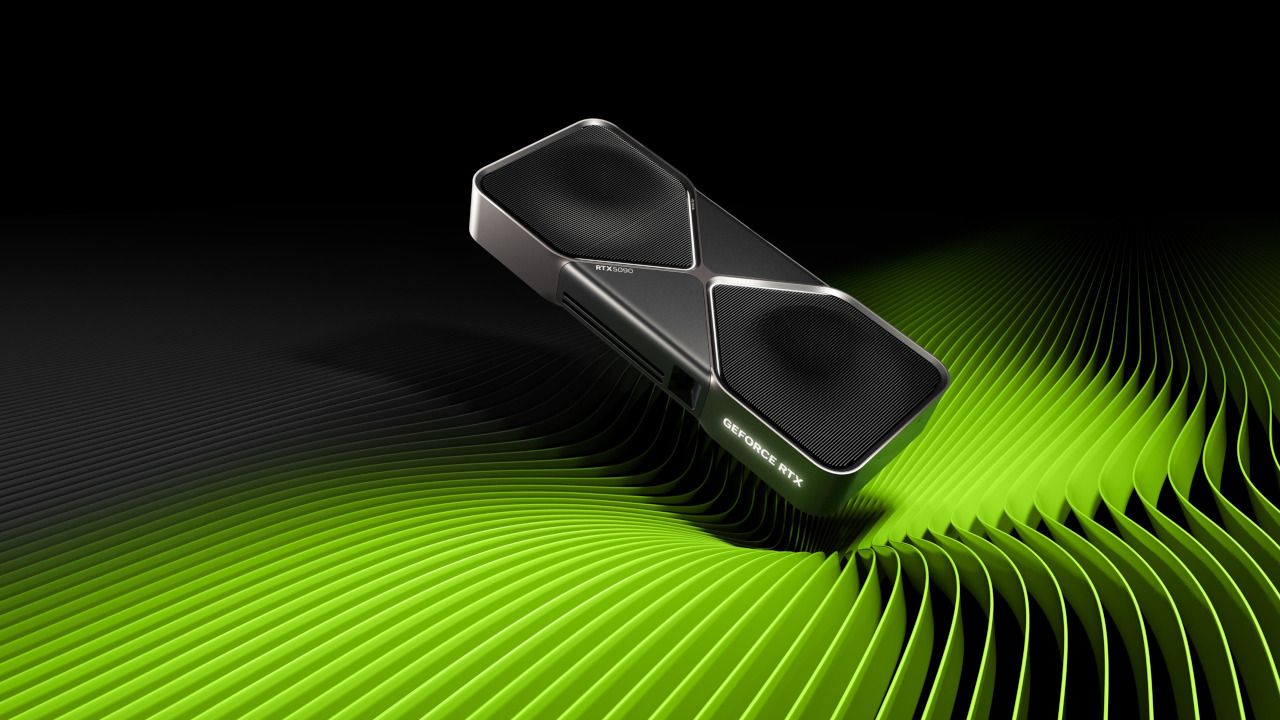






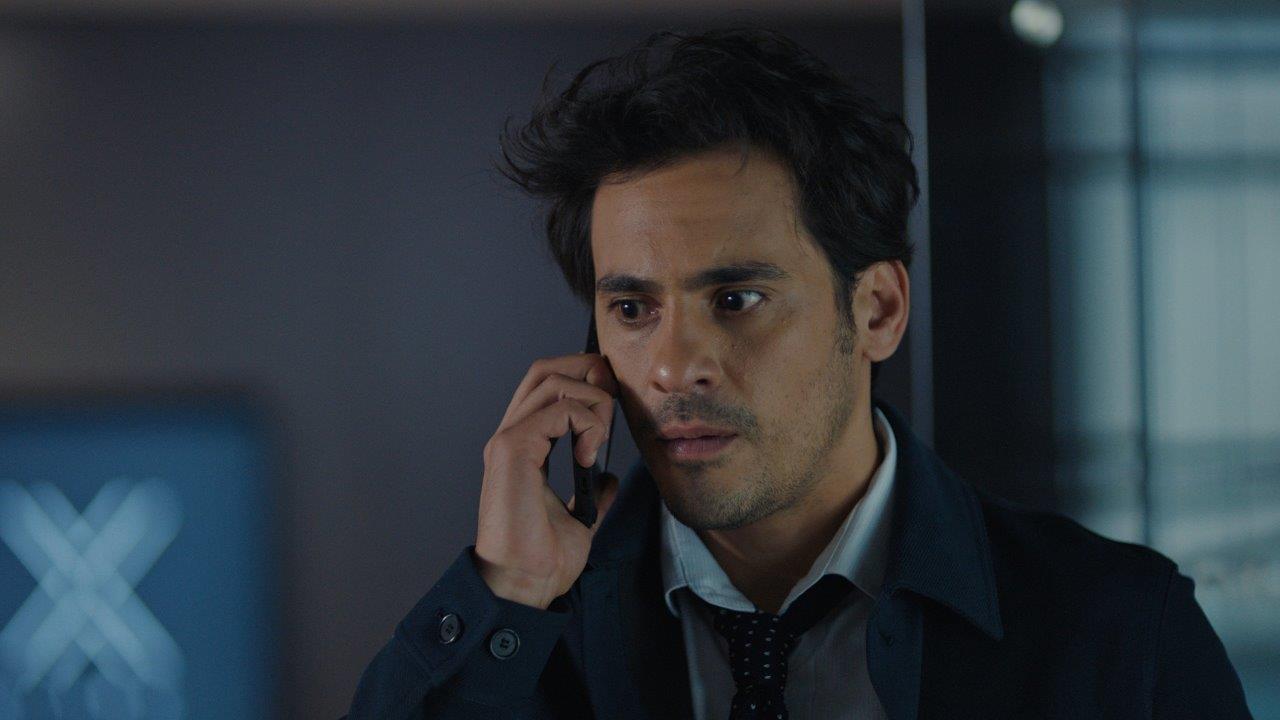









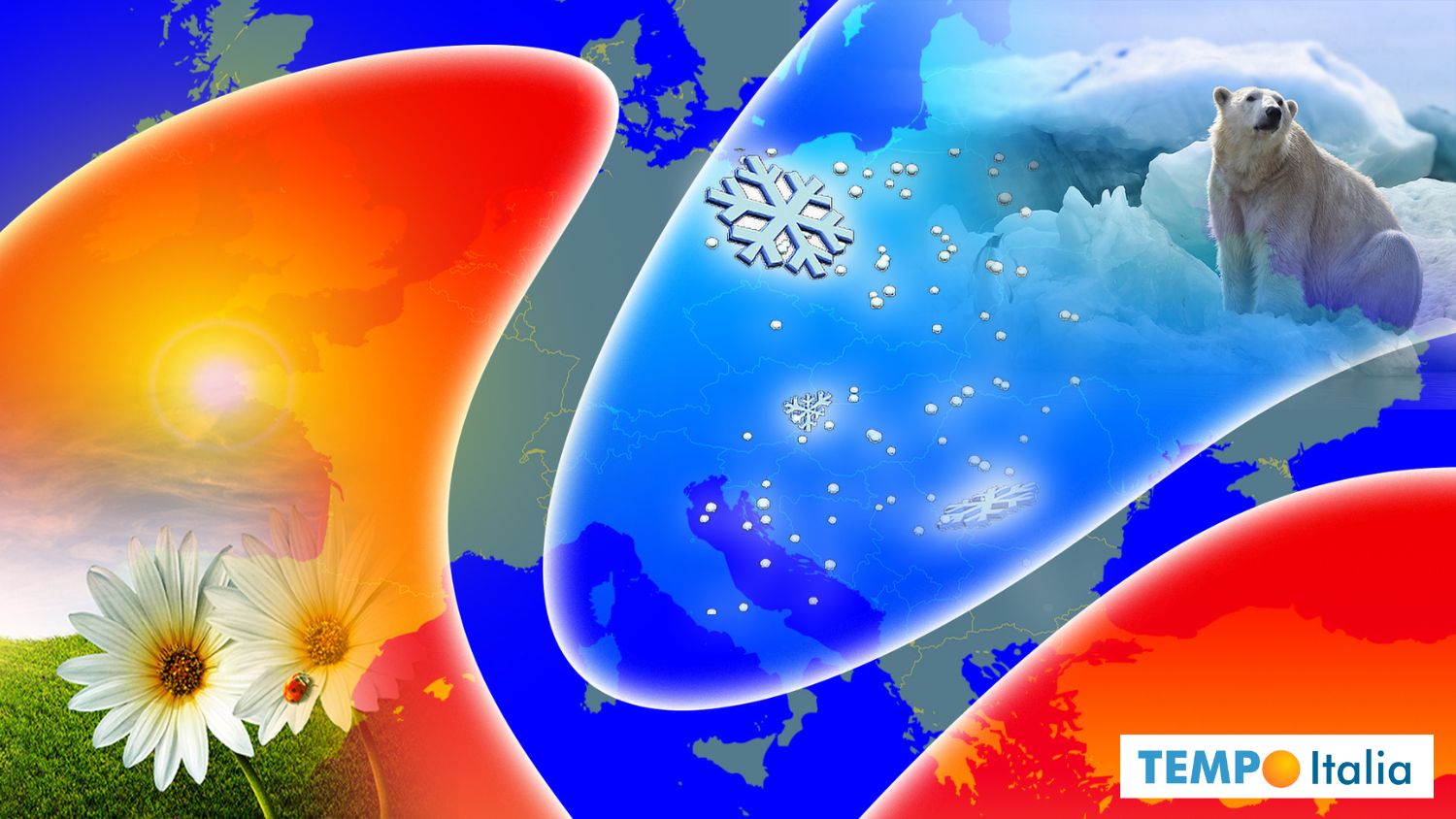











/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/06/4094722-83032104-310-310.png)
/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/06/4094694-83031544-310-310.jpg)
/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/06/4094732-83032304-310-310.png)
/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/06/4094714-83031944-310-310.jpg)




