La pacifica Europa sceglie le armi come motore del Pil | L’analisi di Fulvio Lorefice, political risk analyst di FB&Associati
In attesa del Libro Bianco sulla difesa, ferve il dibattito europeo sulle modalità di finanziamento per questo settore strategico. Il governo italiano spinge per scorporare queste spese dal Patto di Stabilità, un’ipotesi di recente esclusa dal commissario Valdis Dombrovskis. Non volendo dare mano libera agli esecutivi nazionali, si fanno strada due soluzioni: il ricorso agli eurobond, prospettati anche da […] L'articolo La pacifica Europa sceglie le armi come motore del Pil | L’analisi di Fulvio Lorefice, political risk analyst di FB&Associati proviene da Osservatorio Riparte l'Italia.

In attesa del Libro Bianco sulla difesa, ferve il dibattito europeo sulle modalità di finanziamento per questo settore strategico. Il governo italiano spinge per scorporare queste spese dal Patto di Stabilità, un’ipotesi di recente esclusa dal commissario Valdis Dombrovskis.
Non volendo dare mano libera agli esecutivi nazionali, si fanno strada due soluzioni: il ricorso agli eurobond, prospettati anche da una “frugale” d’eccellenza come la premier danese Mette Frederiksen, o la costituzione di un fondo intergovernativo a partecipazione volontaria e facoltativa.
Una soluzione comunitaria rappresenterebbe un cambio di passo per l’Unione Europea e il relativo processo di integrazione, mentre quella intergovernativa sposerebbe la naturale inclinazione politica delle destre europee imperanti. Il punto di caduta sulle modalità di finanziamento può peraltro condizionare i propositi comunitari di razionalizzazione ed efficientamento delle spese.
Nel Rapporto Letta si ricorda che: nel 2022 gli europei hanno stanziato circa 240 miliardi di euro per la difesa, tre volte tanto la Russia e poco meno della Cina (275 miliardi); i costi derivanti dalla frammentazione dei mercati della difesa in Europa risultano superiori a 100 miliardi di euro all’anno.
Nell’aumentarne quindi l’efficacia del 41,6%, il coordinamento europeo in questo comparto, in astratto, potrebbe comportare anche una riduzione della spesa militare.
Il terzo risvolto di interesse attiene all’accento politico che verrà impresso a questo processo: tanto maggiore risulterà la quota di prodotti e/o dei relativi componenti riservata ai Paesi membri rispetto a quelli extra-Ue, tanto maggiore sarà lo slancio verso l’autonomia strategica europea.
Tra la metà del 2022 e la metà del 2023, secondo il Rapporto Draghi, “il 78% della spesa totale per gli acquisti è stata destinata a fornitori extra-Ue, di cui il 63% agli Stati Uniti”.
Di fronte all’intangibilità del rigore finanziario dell’Eurozona, riaffermato secondo i desiderata di Berlino nel nuovo Patto di Stabilità, si individua quindi nel comparto della sicurezza il volano dell’agognata crescita economica: è questo, del resto, uno dei perni dello stesso Piano Draghi. Gli investimenti pubblici nella difesa, trainando anche le nuove tecnologie, specie digitali, produrrebbero un effetto moltiplicatore per l’intero sistema.
Tali argomenti – è interessante notare – ricalcano una delle più note teorizzazioni di keynesismo militare, elaborata da Leon Keyserling, capo del Council of Economic Advisers dell’Amministrazione Truman, nel celeberrimo NSC-68. Anche allora, del resto, la necessità di superare il conservatorismo fiscale veniva affermata sulla base di una narrativa pubblica secondo la quale in gioco era “la nostra stessa indipendenza come nazione”.
Ma fu proprio la repentina crescita della spesa militare, in danno – tra le altre cose – dei “conti in ordine”, a porre le basi per l’altrettanto celebre invettiva sul complesso militare-industriale da parte del presidente Dwight Eisenhower nel discorso di commiato del 1961.
Per l’Europa, che si autorappresenta quale potenza di pace, indulgendo ieri sulle proprie responsabilità nei Balcani occidentali e abdicando oggi a ogni ruolo in Ucraina, si tratta di una nemesi storica che si inscrive però nella cosiddetta militarizzazione delle relazioni internazionali.
Un contesto, cioè, dove minacce e avvertimenti reciproci, nel concorrere al tentativo di suscitare movimenti d’opinione favorevoli alla guerra, stravolgono le agende politiche nazionali, imponendo l’allineamento degli interessi economici a quelli di sicurezza, con l’effetto di policy di alterare, quindi, la composizione della spesa pubblica a favore della difesa.
Una tendenza che si compie a discapito della specializzazione produttiva e quindi dell’efficienza e di minori costi: le virtù cioè del libero scambio.
L'articolo La pacifica Europa sceglie le armi come motore del Pil | L’analisi di Fulvio Lorefice, political risk analyst di FB&Associati proviene da Osservatorio Riparte l'Italia.
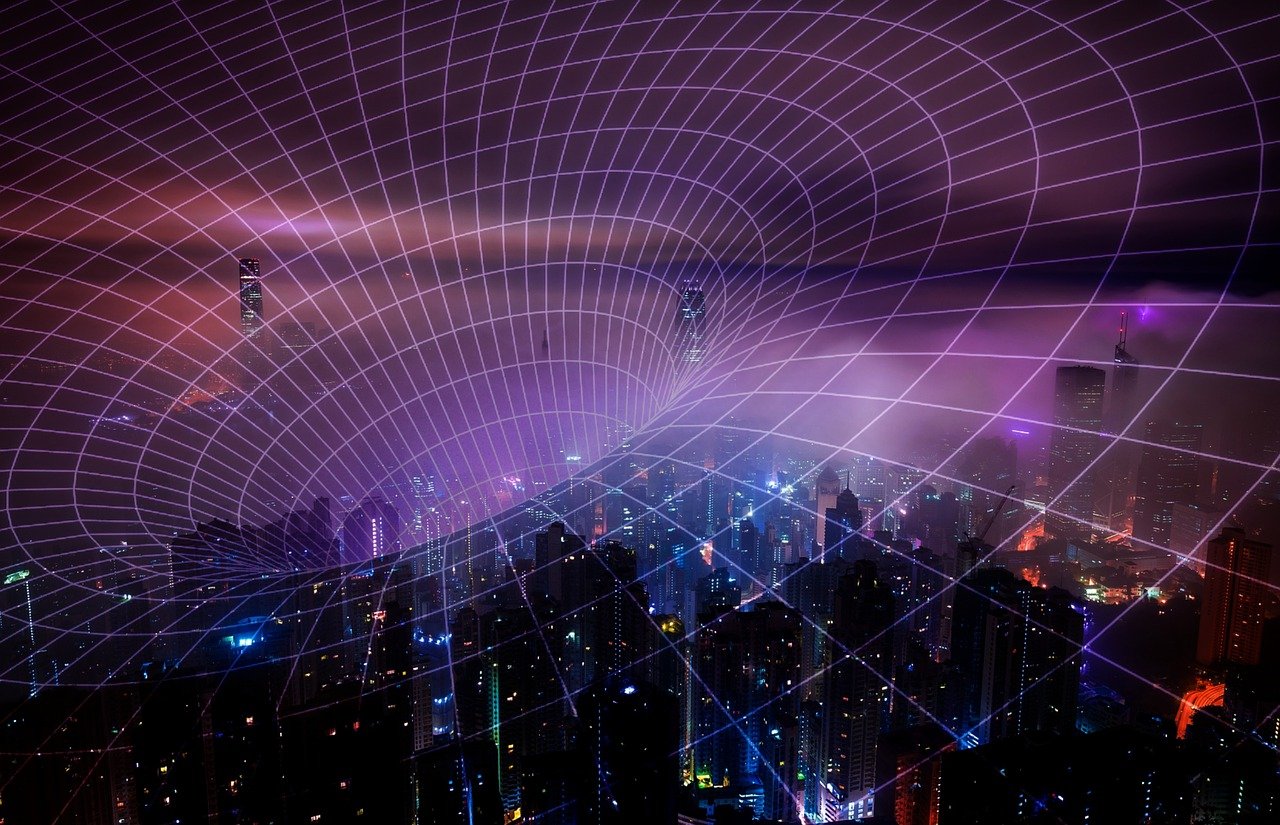








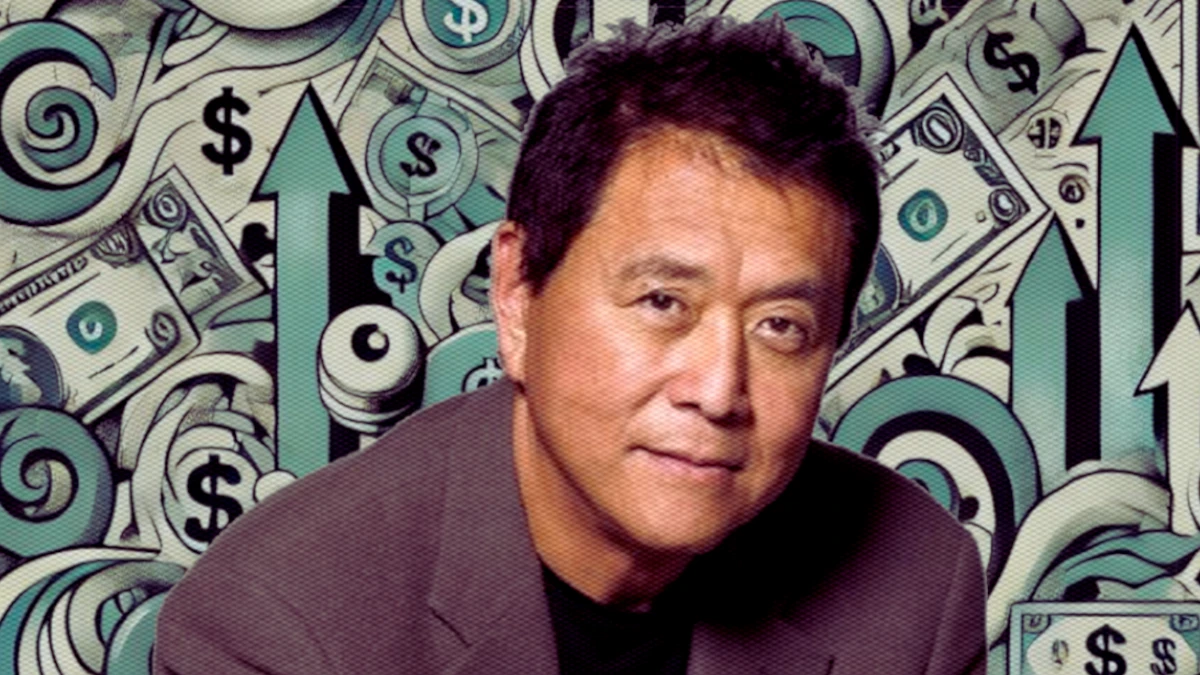

































![La guida allo sport in tv oggi [sabato 1 febbraio] | Il Teleco-Slalom](https://www.loslalom.it/wp-content/uploads/2024/05/w3.jpg)
/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/01/31/4092599-82989644-310-310.jpg)
/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/01/31/4092630-82990264-310-310.jpg)
/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/01/31/4092602-82989704-310-310.jpg)




