Confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo: il parere del TAR
lentepubblica.it L’Avvocato Maurizio Lucca approfondisce, attraverso l’analisi di una recente sentenza del TAR Sicilia, i confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo. L’agire pubblico, ossia l’azione amministrativa, costituisce una regola generale della PA a fronte di richieste da parte del privato, tale che l’eventuale inerzia (colposa) può dare corso al risarcimento del danno da ritardo, rilevando, […] The post Confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo: il parere del TAR appeared first on lentepubblica.it.

lentepubblica.it
L’Avvocato Maurizio Lucca approfondisce, attraverso l’analisi di una recente sentenza del TAR Sicilia, i confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo.
L’agire pubblico, ossia l’azione amministrativa, costituisce una regola generale della PA a fronte di richieste da parte del privato, tale che l’eventuale inerzia (colposa) può dare corso al risarcimento del danno da ritardo, rilevando, in ogni caso, che il silenzio assume differenti effetti giuridici, da una parte, può essere delineato con un inadempimento di fronte all’obbligo (positivizzato) di agire, dall’altra parte, quale sistema di semplificazione/accelerazione, può dar corso ad un provvedimento (una fictio iuris) tacito di assenso [1], ovvero, il silenzio risulta significativo, potendo (in relazione alle norma di riferimento) essere equiparato ad assenso oppure a diniego (una semplificazione/deregolamentazione), non escludendo il silenzio devolutivo che determina in trasferimento di competenza (ex art. 17, comma 1, della legge 241/1990).
L’inerzia
La sez. I Catania, del TAR Sicilia con la sentenza 4 febbraio 2025, n. 474, interviene per delineare i presupposti giuridici per la formazione del silenzio – inadempimento dell’Amministrazione, rilevando che il mero ritardo non costituisce di per sé inadempimento se non sussiste un obbligo di provvedere [2], non solo nei casi normativamente codificati, ma anche per ragioni di giustizia e di equità, che possono disvelarsi in quel dovere di collaborazione e buona fede (ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241, indi art. 97 Cost.) che animano l’azione amministrativa, facendo sorgere nel privato una legittima aspettativa alla conclusione del provvedimento con un atto espresso, che potrà essere impugnato in sede giurisdizionale qualora non satisfattivo del bene della vita [3].
L’interesse ad agire
L’obbligo di provvedere violato comporta un inadempimento censurabile dal giudice purché perduri l’inerzia sino al momento della decisione, diversamente viene meno il relativo interesse ad agire, con la conseguenza, che l’adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso:
- inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire, se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso;
- improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all’uopo instaurato;
- se permane la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire, ex 117 del d.lgs. n. 104/2010, quando l’Amministrazione non conclude il procedimento, quale ne sia il contenuto, nel termine di riferimento, ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere, ma un rinvio sine die [4].
Fatto
Nello specifico, il silenzio di una Commissione tecnica al rilascio di un parere (valutazione dell’impatto ambientale) finalizzato all’approvazione di un impianto fotovoltaico con associato impianto agricolo: conclusa la fase di consultazione pubblica (30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico) il termine massimo di conclusione dell’istruttoria tecnica (130 giorni dalla data di pubblicazione online dell’avviso al pubblico) la Commissione non si è espressa.
Donde il ricorso, preceduto inutilmente apposito sollecito: si lamenta la violazione dell’obbligo di provvedere in maniera esplicita sull’istanza presentata, atteso che il Ministero (ergo, la Commissione deputata all’istruttoria) non si è ancora pronunciato, risultando inadempienti agli obblighi di provvedere nei termini normativamente definiti di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990 e – in maniera espressa e imperativa – anche con il rimando dell’art. 25, Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, «Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241» (in questo senso, l’intento del legislatore oltre alla semplificazione e certezza dei tempi in funzione dell’esigenza di dar corso all’intervento sotteso al parere, l’interesse pubblico alla tutela del territorio, ex lettera c), dell’art. 5, del d.lgs. n. 152 cit. (Norme in materia ambientale), nonché art. 9 Cost., e dell’iniziativa economica, ex art. 41 Cost.), anche mediante un commissario ad acta. [5]
Il Ministero resistente sulla base dell’elevato numero di richiesta, evidenzia di aver adottato dei criteri di priorità di uso della “capacità amministrativa”, giustificando l’apparente ritardo.
Il silenzio inadempimento
Il ricorso viene accolto con l’accertamento dell’illegittimità del silenzio (inadempimento ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato), con ordine di provvedere (terminare il procedimento), con nomina di un Commissario ad acta (per l’ottemperanza) e condanna alle spese.
Il GA precisa che nel rito (ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.) la presenza del “silenzio” è integrato – non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì – dal comportamento inerte che si estrinseca:
- nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato;
- alternativamente, nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo;
- nella fattispecie, il termine di conclusione veniva normativamente stabilito (anche dalla norma speciale, che rinvia a quella generale).
In effetti, osservando il secondo periodo, del comma 1, dell’art. 2 della legge 241/1990, impone che in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: risponderà con una motivazione contenuta che dia conto delle cause della sua determinazione.
In termini diversi, se la fonte impone di dare riscontro ad una istanza non vi sono margini per l’Amministrazione di rimanere silente, il silenzio viola il dovere (un comando) di agire, impedendo al privato di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici: anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’Amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato [6].
La mancata espressione dei previsti pareri nei termini, ovvero l’espressione di pareri negativi, non elidono l’obbligo di una pronunzia espressa da parte della PA: l’introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell’impianto non legittima il mancato rispetto del termine di conclusione dei procedimenti previsto dalla norma, posto che pure i progetti relativi a impianti di minore potenza sono tesi a soddisfare interessi di natura imprenditoriale rilevanti ai fini strategici, oltre che obiettivi di protezione ambientale dall’elevato valore costituzionale, ragion per cui, in assenza di un atto generale o normativo che abbia declinato in chiave attuativa il generico criterio di “priorità”, deve escludersi ogni elusione dei termini.
Termine perentorio
In definitiva, il dovere di correttezza postula la diligenza nel rispondere alle richieste del privato, quando la fonte individua il carattere perentorio del termine non è revocabile in dubbio l’obbligo di concludere il procedimento, senza anteporre eccezioni o ragioni aggiuntive non presenti nella fonte primaria, soprattutto in coerenza con il particolare favor riconosciuto dall’ordinamento (nazionale e comunitario) alle fonti energetiche rinnovabili.
Le fonti, non ultima il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ha individuato norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente [7].
Appare evidente (quanto suggestivo) che ammettere la presenza di una norma interna che armonizzi i termini di conclusione in relazione alle priorità della potenza degli impianti, in ragione di una organizzazione non in grado di assolvere al “carico di lavoro” (quando l’organizzazione è funzionale al risultato, «in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione»), significa estromettere dall’ordinamento la forza del diritto, attraverso una linea interpretativa (ricostruzione ermeneutica, ratione legis cessat et ipsa lex) di sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore, producendo una riduzione totale del significato legislativo [8].
Ingiustificate giustificazioni
Invero, per non lasciare alcun dubbio alla “stranezza” di una prassi elusiva di un precetto di legge, il Tribunale:
- esprime una considerazione di logica giuridica: in presenza di un termine ordinamentale rivolto a scandire le fasi del procedimento, rispondendo alla ratio legis preordinata ad «assicurare certezza dei tempi di amministrazione delle incombenze delle Autorità titolari dei procedimenti e del conseguente potere di provvedere, che ha natura doverosa e che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere» [9];
- il gran numero di procedimenti in corso, costituendo di una mera questione organizzativa interna alle Amministrazioni coinvolte, «non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno “sforamento” dei tempi normativamente imposti. In definitiva, le difficoltà organizzative rappresentate dall’Amministrazione non possono legittimare una deroga generalizzata ai predetti termini, definiti dalla legge perentori» [10].
Un ragionamento che appare, anche ai semplici cultori del diritto, cangiante nel travisare i canoni interpretativi, una palese svista, confondendo regole di change management con condotte contrarie al diritto, non potendo riscrivere i termini procedimentali a fronte di una organizzazione incapace di rispondere alle istanze del privato (elevato numero di domande in un breve lasso di tempo), semmai si dovrebbe fronteggiare la mole delle richieste con idonee misure di natura organizzativa, magari reingegnerizzando i processi, affidandosi ai modelli di project management, in grado di garantire la “tenuta del sistema”, non certamente attribuendo portata recessiva alla previsione normativa di cui all’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006.
I termini di legge perentori – di scansione del procedimento amministrativo – non possono consentire un risultato ermeneutico di una sostanziale disapplicazione delle norme, le quali presidiano a valori sistematici fondamentali, quali la certezza dei tempi di definizione delle vicende amministrative [11].
Volendo trarre una prima conclusione, l’inerzia dell’Amministrazione, scaduti i termini di conclusione del procedimento, viene accertata dal GA con l’imposizione di un obbligo di adempiere: procedere con l’esercizio del potere discrezionale, impregiudicato nel merito delle decisioni da adottare, con nomina di un Commissario ad acta, ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., per assicurare il buon esito del diktat, qualora persista lo stato di inoperosità.
A questo punto, il Giudice fa riserva, in caso di intervento del Commissario ad acta, di liquidare il relativo compenso a carico dell’Amministrazione resistente e con segnalazione del conseguente danno all’erario, impregiudicata la responsabilità dirigenziale (comma 9, dell’art. 2 della legge 241/1990, «La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente»).
Il Legislatore, con l’inserimento di questa norma all’interno della legge, ha recepito quell’orientamento giurisprudenziale prevalente che, partendo dal principio generale della doverosità dell’azione amministrativa, ed integrandolo con le regole di ragionevolezza e buona fede, tendeva ad ampliare l’ambito delle situazioni in cui vi è obbligo di provvedere, al di là di quelle espressamente riconosciute dalla legge: detto dovere si configura anche nelle ipotesi in cui l’atteggiamento omissivo delle Pubbliche Amministrazioni, interferendo con posizioni legittimanti dei privati, reca di per sé stesso una lesione giuridicamente apprezzabile e, dunque, radica un interesse concreto ed attuale all’instaurazione di un giudizio cognitivo [12].
Potere sostitutivo
Allo stesso tempo, qualora la Commissione Tecnica non predisponga lo schema di provvedimento di VIA entro i termini normativi, configurandosi un’inadempienza dell’Amministrazione, si poteva azionare l’adozione del potere sostitutivo a opera del Ministero [13].
Siamo in presenza del c.d. potere sostitutivo, di cui alla regola generale del comma 9 ter, dell’art. 2, della legge 241/1990: «Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9 – bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario»).
Il silenzio tra le PA
A margine, viene indicato per l’esito favorevole del procedimento (la sua conclusione), richiedendo il concerto di più Amministrazioni pubbliche, può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 bis, Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, della legge n. 241/1990: il meccanismo del silenzio assenso (per silentium un atto di assenso) opera solo in senso orizzontale, ossia tra Amministrazioni, in relazione a procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata, in cui la decisione finale necessita di una condivisione tra Enti (in genere preposti alla tutela di interessi pubblici differenziati) [14], sulla base di uno schema di provvedimento elaborato dall’Amministrazione procedente [15].
Silenzio significativo
La sez. VI del Cons. Stato, con la sentenza del 30 dicembre 2024, n. 10468, in occasione di un contenzioso sul procedimento di installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, si sofferma sul sistema del silenzio -assenso previsto dalla disciplina speciale che esclude l’applicazione della normativa di carattere generale di cui al DPR n. 380/2001, e che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo, esprimendo la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l’evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (la fonte disponeva che le richieste «si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso…, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare in controlli», l’abrogato art. 87, del d.lgs. n. 259/2003) [16].
In modo analogo, rispetto al precedente caso, la volontà di raggiugere gli obiettivi di garantire la rete di comunicazione, è stata disposta una disciplina derogatoria alla regola generale, dando al silenzio dell’Amministrazione un effetto inverso rispetto all’inadempimento, quanto l’equivalenza di un provvedimento tacito di assenso, purché il privato abbia presentato una richiesta completa di tutti i requisiti di legge (con le precisazioni che seguono) [17].
Il Legislatore con finalità di rendere certo il termine di conclusione, una linea di chiara demarcazione della volontà di giungere alle conseguenze volute, ossia l’incentivazione della realizzazione delle infrastrutture di comunicazione, il silenzio risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia “equivale” a provvedimento di accoglimento: tale equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo.
Si deve, altresì, argomentare che ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio – assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge, avendo l’Amministrazione rinunciato, con il silenzio, ad agire inibendo la possibilità di formarsi il silenzio assenso.
Non è ragionevole affermare che la fattispecie rimane produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, con ciò significherebbe sottrarre i titoli così formatisi alla disciplina della annullabilità: tale trattamento differenziato, per l’altro, neppure discenderebbe da una scelta legislativa oggettiva, aprioristicamente legata al tipo di materia o di procedimento, bensì opererebbe (in modo del tutto eventuale) in dipendenza del comportamento attivo o inerte della PA.
Inoltre, l’impostazione di “convertire” i requisiti di validità della fattispecie “silenziosa” in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento, vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell’istituto: l’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore viene, infatti, realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando (sempre) successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi “silenziosamente” [18].
Quando l’istanza per il rilascio del provvedimento contiene tutta la documentazione istruttoria prevista dalla legge, l’inerzia della PA viene assecondata da un esito favorevole per il privato: la giurisprudenza, infatti, ha chiarito che la formazione tacita del silenzio assenso presuppone, quale condizione imprescindibile non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dall’Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista (con le riserve appena descritte) [19].
Danno da ritardo
In questo quadro, pare giusto soffermarsi sulla responsabilità civile dell’Amministrazione in tema di danni cagionati dall’illegittima attività amministrativa derivanti dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, tale responsabilità va ricondotta al paradigma generale della responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c. [20].
Tuttavia, non è sufficiente dedurre il mero superamento del termine procedimentale, ma occorre anche dare la prova, che incombe sul danneggiato, della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, di natura oggettiva (danno-evento, danno-conseguenza e relativo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) e di natura soggettiva [21].
Indi, il riconoscimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non è avulso da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita e, dunque, dalla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito favorevole, posto che l’ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell’adozione del provvedimento [22].
Il comma 1, dell’art. 2 bis, Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento della legge 241/1990, prevede, quindi, la possibilità di risarcimento del danno da ritardo (nonché da inerzia dell’Amministrazione) nella conclusione del procedimento amministrativo non già come effetto del ritardo in sé e per sé, bensì per il fatto che la condotta inerte o tardiva dell’Amministrazione sia stata causa di un danno altrimenti prodottosi nella sfera giuridica del privato che, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento amministrativo: il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale quest’ultimo deve fornire la prova.
La prova (le allegazioni probatorie) deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte, ovvero all’adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell’Amministrazione, ma sempre che la legge non preveda, alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, un’ipotesi di silenzio significativo, nel qual caso non vi è alcunché da risarcire, avendo l’interessato conseguito il provvedimento: una netta distinzione tra silenzio inadempimento e silenzio assenso.
Si aggiunga che (mentre) l’accertamento del c.d. danno da mero ritardo porta ad una condanna della PA al pagamento dell’indennizzo (ex comma 1 bis, dell’art. 2 bis della legge 241/1990), indennizzo che esige che il privato attivi (abbia attivato) il potere sostitutivo [23].
La disposizione da ultimo citata sancisce, infatti, che al fine di ottenere l’indennizzo l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo, previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento: nel caso di procedimenti in cui intervengono più Amministrazioni, l’interessato presenta istanza all’Amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’Amministrazione responsabile del ritardo (indennizzo dall’osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge per il riconoscimento) [24].
Note
[1] Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15/2011, ove si qualifica il silenzio come provvedimento tacito, onerando il terzo portatore dell’interesse pretensivo leso al rispetto del termine decadenziale di impugnazione, soddisfando l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici ed il principio comunitario di tutela dell’affidamento legittimo del denunciante consolidatosi a seguito del decorso del tempo.
[2] Si può configurare un silenzio inadempimento tutte le volte in cui l’Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento, Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703.
[3] TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 3 settembre 2024, n. 2499; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; TAR Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342.
[4] TAR Campania, Salerno, sez. II, 25 settembre 2024, n. 1717.
[5] La VIA si sostanzia non già in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera programmata, bensì in un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio-economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero. Essa non è un mero atto (tecnico) di gestione, ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati, Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2024, n. 3204; idem 16 novembre 2023, n. 9852.
[6] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666.
[7] Cfr. TAR Sardegna, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 745; TAR Sicilia, Palermo, sez. V, 25 settembre 2024, n. 2625; TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 giugno 2024, n. 12670.
[8] Cfr., TAR Marche, sez. I, 27 settembre 2024, n. 762; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 16 luglio 2024, n. 932; TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 giugno 2024, n. 12670; TAR Sardegna, sez. II, 3 giugno 2024, n. 436.
[9] Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, 4 aprile 2024, n. 2024.
[10] Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 giugno 2024, n. 12670.
[11] TAR Sardegna, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 745 e n. 517/2024.
[12] TAR Puglia, Lecce, sez. I, 5 luglio 2018, n. 1105.
[13] TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 22 novembre 2024, n. 830.
[14] Il silenzio delle Autorità statali preposte alla tutela del vincolo paesaggistico, chiamate ad esprimere il proprio parere in ordine alla compatibilità paesaggistica di opere abusive, anche nell’ambito di apposita conferenza di servizi, non ha valore di assenso, TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 12 aprile 2024, n. 304. Vedi, anche, TAR Campania, Salerno, sez. II, 2 novembre 2022, n. 2896; Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610.
[15] TAR Sardegna, sez. I, 6 novembre 2024, n. 763. La formulazione testuale del comma 3, dell’art. 17 bis, della legge n. 241/1990, consente di estendere il meccanismo del silenzio assenso anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali di modo che, scaduto il termine fissato dalla normativa di settore, vale la regola generale del silenzio assenso, Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610.
[16] Cons. Stato, sez. VI, 22 gennaio 2021, n. 666; idem 1° marzo 2024, n. 2031. Cfr. il comma 8, dell’art. 20, Procedimento per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001, dove il silenzio assenso non si può ritenere perfezionato non solo nei casi di diniego ma anche di preavviso di rigetto, ed anche qualora vi fosse stato un superamento del termine di conclusione del procedimento, appare in contrasto con i principi di collaborazione e di buona fede (richiamati, in materia, anche da Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2022, n. 11034 ed oggi codificati come principio generale dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione dall’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990) invocare la formazione del silenzio assenso in ipotesi in cui siano stati tempestivamente sollevati dagli uffici rilievi oggettivamente problematici e non pretestuosi, seguiti da interlocuzioni finalizzate a cercare soluzioni idonee a superarli e sfociati, da ultimo, in una proposta di decisione contraria, chiaramente espressa nel preavviso di diniego, Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2024, n. 7768.
[17] Ai fini della operatività del dispositivo del silenzio assenso occorre che la domanda sia quantomeno aderente al ‘modello normativo astratto’ prefigurato dal legislatore pena la “inconfigurabilità giuridica” della stessa, il che significa che la domanda deve essere completa degli elementi essenziali (“minimali” secondo Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11217), a pena di inconfigurabilità della stessa, Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203: ove l’istanza non sia stata corredata da tutta la documentazione necessaria, ovvero si presenti imprecisa o foriera di possibili equivoci, in modo tale che l’Amministrazione destinataria sia stata impossibilitata per il comportamento dell’istante a svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene, il silenzio assenso non può formarsi, per cui si avrà un’ipotesi di inesistenza dello stesso e non di sua illegittimità.
[18] Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2024, n. 8582, punto 7.4 e 8 luglio 2022, n. 5746. Una volta decorso il termine, il potere primario di provvedere si consuma e non vi è più spazio per l’adozione di un diniego tardivo, oggi espressamente considerato “inefficace” a mente dell’art. 2, comma 8 bis, della legge n. 241 del 1990, residuando in capo alla PA la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi silenziosamente, Cons. Stato, sez. VI, del 13 marzo 2024, n. 2459.
[19] Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 2020, n. 506.
[20] Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7. Vedi, anche, Cons. Stato, sez. VII, 18 dicembre 2024, n. 9318; sez. V, 24 ottobre 2024, n. 876. Ai fini della liquidazione del danno da ritardo – che va liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di chance – occorre che l’interessato provi sia il lucro cessante, ossia il mancato guadagno, sia il danno emergente, TAR Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 11 dicembre 2024, n. 22397.
[21] Cons. Stato, sez. IV, 20 marzo 2024, n. 2705.
[22] Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2960. L’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono in linea di principio presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell’adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2679 c.c.., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante), Cons. Stato, sez. II, 17 settembre 2024, n. 7621.
[23] L’unica disposizione normativa in materia si rinviene nell’art. 28 del DL n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, il quale prevede al comma 2 che «al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990», richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato, Cons. Stato, sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7787. Vedi, MPFS, Direttiva 9 gennaio 2014, Linee guida sull’applicazione dell’art. 28 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 – Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.
[24] Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2024, n. 7789.
The post Confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo: il parere del TAR appeared first on lentepubblica.it.













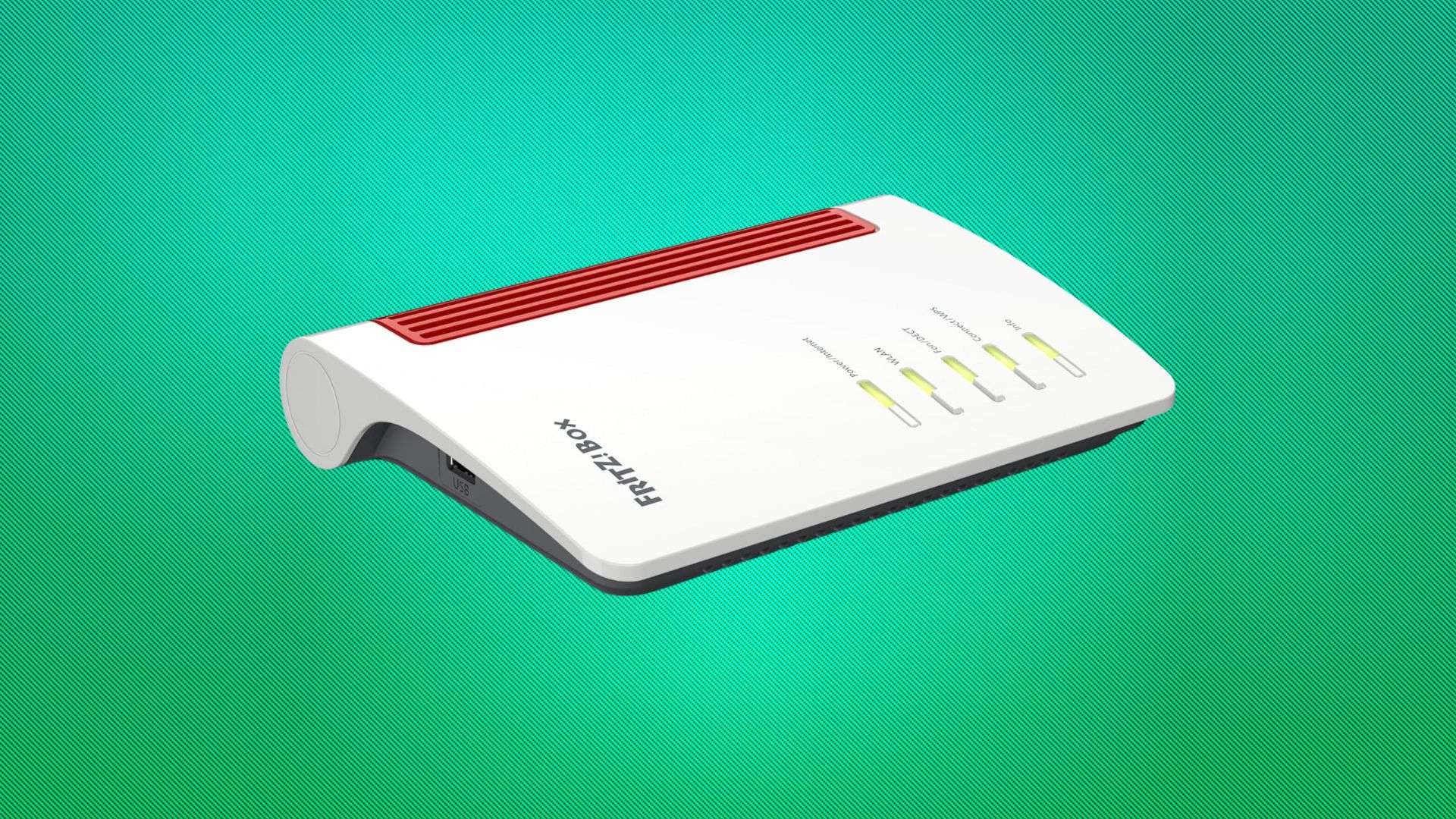





























/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/07/4095275-83043164-310-310.png)







