Nessun limite di spesa per l’assistenza scolastica al disabile
lentepubblica.it L’Avvocato Maurizio Lucca approfondisce un argomento molto importante per genitori e studenti: il TAR afferma che non vige alcun limite di spesa per l’assistenza scolastica al disabile. In una dimensione giuridica dell’individuazione delle fragilità umane la definizione della disabilità può condurre a diversi parametri di formulazione e di intensità, andando oltre al processo classificatorio, l’ordinamento […] The post Nessun limite di spesa per l’assistenza scolastica al disabile appeared first on lentepubblica.it.

lentepubblica.it
L’Avvocato Maurizio Lucca approfondisce un argomento molto importante per genitori e studenti: il TAR afferma che non vige alcun limite di spesa per l’assistenza scolastica al disabile.
In una dimensione giuridica dell’individuazione delle fragilità umane la definizione della disabilità può condurre a diversi parametri di formulazione e di intensità, andando oltre al processo classificatorio, l’ordinamento giuridico e il suo legislatore hanno approntato diverse tutele, disseminate in Costituzione e in altre fonti di rango primario [1].
Pretendere con atti amministrativi di spesa di giustificare una violazione a tali precetti valoriali, limitando il diritto allo studio del disabile significa introdurre elementi ed azioni discriminatorie [2], che non reggono al vaglio del Giudice, e prima ancora della coscienza (collettiva), quel sentire comune di libertà e di solidarietà, dove non ogni cosa ha un prezzo e/o deve essere produttiva di utilità (reddito): non in pane solo vivet homo [3].
Il pronunciamento
La sez. I del TAR Emilia Romagna, con la sentenza del 10 dicembre 2024, n. 925, interviene per censurare la condotta di un Comune nel privare un alunno disabile dell’assistenza, ritenendo (errando) che i vincoli di spesa (ossia, le risorse necessarie per l’intervento) precludano l’erogazione del pagamento della dovuta prestazione [4]: non è legittima l’omissione di assistenza, giustificando la mancata copertura della spesa, quando gli stanziamenti a bilancio possono essere impiegati per l’assolvimento di un fine primario verso le categorie fragili, espressione etica, prima che costituzionale, del diritto allo studio e ai vincoli di solidarietà.
Fatto
Il ricorso parte contro una determinazione dell’Amministrazione locale (attraverso un Tavolo di lavoro composto anche dall’Amministrazione scolastica e sanitaria) di riconoscimento di un numero limitato di ore settimanali di assistenza (competenze in Lingua dei Segni Italiana, LIS), anziché la copertura completa dell’orario scolastico settimanale di didattica (quindici ore coperte su ventisette settimanali), come previsto dalla disciplina di riferimento e dai Piani Educativi Individualizzati, relativi ai minori con disabilità ricorrenti e come richiesto dall’Autorità scolastica.
Il ricorso, nella sua essenzialità, intende contestare le ore di sostegno, che – pur non essendo obbligatorie nella loro totalità – la loro ridotta messa a disposizione dell’assistente traduttore non può trovare giustificazione nelle limitate risorse finanziarie del Comune (mancano i soldi, un ritornello noto, privo di contesto): la condotta assunta comporta una diretta lesione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica, in violazione degli artt. 3, 32, 34 e 38 della Costituzione, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 3, 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, degli artt. 3, 5, 7, 9 e 10 del d.lgs. n. 66 del 2017, dei decreti interministeriali nn. 182 del 2020 e 153 del 2023 e dell’art. 139, comma 1 del d.lgs. n. 112 del 1998: un comportamento del Comune che avrebbe leso (ha leso) il nucleo essenziale del diritto all’istruzione.
L’Amministrazione convenuta riconferma la posizione (anche in sede di appello, di accoglimento della sospensiva), ribadendo lo sforzo profuso e l’autonomia finanziaria del Comune [5].
Merito
Il giudice di prime cure, richiama la fonte di riferimento che disciplina gli interventi per l’integrazione dei soggetti in situazione di handicap dove i Comuni sono tenuti, «nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l’Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali – agli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione».
Dunque, il soggetto obbligato non è il Tavolo di lavoro (a cui sono affidati compiti di certificazione, consulenza, assistenza, partecipazione alla definizione del Piano educativo individualizzato e verifiche) ma esclusivamente l’Amministrazione locale, la quale deve assicurare l’accesso e la frequenza del sistema scolastico e formativo, mettendo a disposizione le risorse economiche «proprio in ragione di quell’autonomia finanziaria che esso stesso rivendica».
Fatta questa premessa, vengono citale le ulteriori fonti normative (ex comma 3, dell’art. 13 della legge n. 104 del 1992) [6] che impongono agli Enti locali l’obbligo di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, garantendone le attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati (figura centrale per l’integrazione scolastica, da affiancare a quella dell’“assistente” che ha, invece, compiti di affiancamento alla struttura scolastica, durante la frequenza dell’alunno disabile non autonomo, al fine di sostenerlo e di aiutarlo).
La presenza di tali figure e del monte ore individuato risulta indispensabile per l’apprendimento scolastico: ne discende che gli oneri connessi alla realizzazione di tale progetto non possono che essere posta a carico dell’Amministrazione comunale, secondo il riparto e in conformità al disposto dell’art. 13, Integrazione scolastica, della legge n. 104 del 1992, non potendo esimersi dalle determinazioni assunte, impegnando solo parte della spesa.
Vengono rigettate, quindi, le posizioni dell’Amministrazione civica:
- piena illegittimità dei provvedimenti impugnati nella misura in cui contravvengono ai principi individuati dalla giurisprudenza sugli obblighi di assistenza (viene respinta quella citata dal Comune, poiché riferita ad un caso diverso);
- vi è un’esigenza rafforzata in questi casi, proprio al fine di rendere il “sostegno” (le figure ausiliarie) idonea a superare le difficoltà di apprendimento conseguenti alla patologia di cui sono affetti;
- il punto di equilibrio tra promozione dell’integrazione dei minori disabili e limitatezza delle risorse finanziarie che è ritenuto essenziale sia dall’ordinamento internazionale che da quello interno: devono sempre essere garantite le prestazioni quando se non assicurate sia integralmente preclusa la possibilità di accedere alla formazione scolastica a causa della sola impossibilità di udire le parole degli insegnanti, degli altri operatori e finanche dei compagni;
- al Comune non è, dunque, richiesta un’inammissibile disapplicazione della norma, ma un’interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dei principi affermati, nella già citata sentenza n. 80/2010, da quella stessa Corte Costituzionale che ha più volte riconosciuto l’autonomia finanziaria dei Comuni.
Massima
L’orientamento porta a concludere che «il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale», per cui deve essere assicurato attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione» che tengano conto che «i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario … individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona».
In termini diversi, si dovrà valutare caso per caso, affermando da una parte, il potere discrezionale del Comune nell’allocazione delle risorse (con conseguente esclusione della natura vincolante del PEI nei confronti del Comune), dall’altra parte, l’esercizio del potere deve essere coniugato con l’aspetto finanziario con la necessità del rispetto dell’obbligo di garantire quel “nucleo invalicabile di garanzia minime” [7] che rende effettivo il diritto tutelato, ovvero il diritto sociale all’integrazione scolastica che non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, ma deve tenere conto che il diritto al supporto scolastico non si estende in egual modo a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità degli stessi.
Quello che viene indicato come metodologia corretta è un bilanciamento degli interessi, assicurando un minimo non eludibile in relazione al caso concreto: l’ente deve garantire quell’assistenza che consente l’accesso allo studio, in assenza della quale la possibilità di fruire dell’istruzione scolastica sarebbe completamente preclusa.
La riduzione oltre il limite, incidendo negativamente sul nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione costituzionalmente garantito, non può essere limitato o comunque ridotto, neppure per motivi di ristrettezze di bilancio [8].
La sentenza entra, altresì, sul quantum del contendere, cifre che «appaiano comunque minusvalenti rispetto al bisogno di sostegno, occorrendo, come emerge dagli atti, somme complessivamente contenute (inferiori a ventimila euro), tenendo altresì conto del fatto che non sussistono allo stato analoghe richieste degli altri genitori, attesa la particolarità della situazione dei ricorrenti che li differenzia da tutti gli altri»: ne deriva l’illegittimità dell’azione del Comune che ha compresso il diritto costituzionalmente garantito “all’accesso” all’istruzione del disabile.
Proiezioni
La questione affrontata, apprendendo l’ammontare delle risorse necessarie, espone in chiaro tutti i limiti dell’Amministrare dove i bisogni, quelli primari, non vengono assicurati, preferendo (probabilmente) investire in altri bisogni, sicuramente di tenore (spessore) diverso rispetto ai diritti costituzionali all’istruzione (quasi un bilanciamento di diritti di pari rango), violando non in apparenza i doveri di uguaglianza e solidarietà [9], preferendo giustificare i propri (dis)interessi (quelli pubblici) con questioni matematiche, di fogli di calcolo, di neutre operazione di entrata e spesa che mandano in disequilibrio il bilancio: i tagli possono sempre essere fatti con un livello di gradazione rispetto ai valori protetti dall’ordinamento [10].
Invero, la questione sottende una percezione assopita del bene comune, confinando i bisogni in prodotti, disumanizzando le persone e le loro fragilità, attenendosi a linee guida, protocolli e direttive, in nome di un dovere di assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, dove l’allocazione delle risorse, pagati i costi di gestione della struttura, dovrebbero assolvere l’interesse generale, che non può prescindere da un minimo di tutela dei bisogni, specie dei figli – all’istruzione – senza discriminazioni (si preferisce, invece, altro).
Accorerebbe difendere le posizioni raggiunte, presidi di legalità, non dimenticare che l’integrazione scolastica dei disabili persegue un obiettivo alto ma complesso: garantire non solo l’accesso a conoscenze ma anche alle competenze necessarie per l’acquisizione di capacità idonee all’inserimento sociale del disabile.
L’apprendimento e l’integrazione scolastica delle persone con disabilità costituiscono, infatti, una premessa fondamentale della integrazione lavorativa e di quella sociale, che sono alla base di società informate ai principii di solidarietà ed uguaglianza [11]: la disciplina costituzionale dell’istruzione dei soggetti portatori di handicap ha avuto la sua concretizzazione nella legislazione ordinaria che definisce il diritto all’integrazione scolastica delle persone con disabilità.
Il diritto del disabile all’integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, gli istituti scolastici sono tenuti ad assicurare l’integrazione, configurando percorsi educativi individualizzati e le Amministrazioni locali a prevedere la spesa, mediante l’adozione delle doverose misure di integrazione e sostegno [12], atte a rendere possibile ai disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento, ovvero il miglioramento della condizione di disabilità e anche la coerente acquisizione di competenze scolastiche [13].
La mancata copertura della spesa lede i diritti fondamentali di partecipazione effettiva di tutti alla vita economica, politica e sociale del Paese, posto che alla base dello sviluppo del singolo, e di una società, è il diritto all’istruzione, che esprime si esprime nei principi personalistico, pluralistico e solidaristico (ex art. 2 Cost.), la cui effettiva realizzazione non può non essere associata con il principio di eguaglianza sostanziale accolto dal comma 2 dell’art. 3 Cost.: togliere risorse finalizzate a rimuovere le diseguaglianze di fatto e le condizioni di subalternità sociale significherebbe negare una parte del tutto: una democrazia incompiuta, assente dal modello pluralistico (pur) riconosciuto dalla Costituzione.
Un diritto non ritraibile
L’approdo porta a stabilire che si tratta di un diritto non ritraibile il diritto all’istruzione dei disabili, ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, che passa necessariamente attraverso l’attivazione dell’Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante l’adozione delle doverose misure di integrazione e sostegno, atte a rendere possibile ai disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento, ovvero il miglioramento della condizione di disabilità a ricondotto il servizio a favore della persona disabile.
La fruizione dei servizi garantiti dalla legge n. 104/1992 assume la consistenza di diritto soggettivo per la persona disabile, rientrando in quel nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla PA di escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione [14].
In questo focus, l’istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell’individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno [15].
Danno ristorabile
A margine, in questo contesto di misurazione dell’etica pubblica, si può legittimamente disquisire che la mancata attuazione di un progetto finalizzato alla piena integrazione delle persone disabili, di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito dei percorsi dell’istruzione scolastica che ciascun Comune di riferimento deve predisporre, nell’ambito delle risorse rese disponibili, su richiesta dell’interessato, potrebbe comportare un danno ristorabile (nel caso di specie, il TAR non accoglie l’istanza volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione all’assegnazione delle ore di assistenza individuate dal PEI, non tutelabile mediante un’autonoma azione di condanna che, di fatto, si risolverebbe in una indebita sostituzione del Giudice amministrativo all’Amministrazione nell’esercizio di valutazioni discrezionali ad essa riservate).
Invero, la mancata predisposizione del progetto individuale, la cui predisposizione rientra nella sfera di competenza dei Comuni, può essere oggetto di risarcimento vertendosi in tema di danno per ritardo nel provvedere e nelle relative conseguenze afflittive (del minore e dei genitori): il relativo risarcimento può essere riconosciuto a condizione che venga dimostrata la spettanza del bene della vita, ovvero che si dimostri che, con ragionevole probabilità, l’Amministrazione dovrà accogliere l’istanza del privato, sulla quale non ha provveduto, accordandogli così il bene della vita con essa richiesto [16].
Potendo dimostrare il diritto, con allegazioni probatorie, la mancata evasione da parte del Comune del più ampio “progetto di vita individuale” [17] in ambito scolastico costituisce fonte tangibile danno ristorabile (danno da ritardo ed esistenziale, secondo il rito dell’art. 31 e 117 cpa, «con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria»): l’inerzia colposa accertata con il rito silenzio, può comportare anche la nomina di un Commissario ad acta, oltre la richiesta dei danni patiti.
Nel caso di violazione dei diritti del minore disabile, costituzionalmente garantiti e protetti, può farsi luogo al risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione di gravità, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”, compreso il senso di frustrazione dei genitori.
Più in generale, il danno di tipo esistenziale è inteso come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Il comportamento ritenuto lesivo non è, quindi, meramente limitativo ed impeditivo di una pur meritevole aspirazione di vita, ma è un comportamento negligente che omette di rimuovere – in una situazione che per di più per il soggetto è anche di assolvimento di un obbligo (nella specie, quello scolastico) – quei limiti incolpevoli da cui il destinatario, soggetto particolarmente debole in quanto disabile e pure minore d’età, è gravato [18].
Note
[1] MASCI, La tutela costituzionale della persona disabile, federalismi.it, 8 gennaio 2020, dove si affronta compiutamente il tema della tutela costituzionale dei disabili «che muove dalla garanzia dei diritti inviolabili e dalla promozione della dignità umana13 – tende all’inclusione del singolo ed è preordinata alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona». Con l’articolo 14 della legge n. 328/2000 ai comuni è stata affidata anche la realizzazione di progetti individuali per le persone disabili per la realizzazione della piena integrazione nell’ambito familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica, professionale o del lavoro ed analoghe previsioni sono state dettate dall’art. 13 del d.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità.
[2] Gli interessi del minore portatore di handicap risultano chiaramente sacrificati in forza di una ritenuta, automatica prevalenza di ragioni di contenimento della spesa pubblica, con conseguente violazione del diritto fondamentale all’istruzione, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, ord. 23 marzo 2023, n. 138.
[3] MATTEO 4, 4. LUCA 4, 4.
[4] Per dimostrare di non disporre delle risorse necessarie per sostenere l’intervento (caso di specie, retta di ricovero del disabile) l’Amministrazione locale non avrebbe potuto invocare un preteso divieto di disporre stanziamenti di bilancio ad hoc, ma avrebbe dovuto dimostrare specificamente di non disporre in assoluto di risorse che potessero essere “appostate” per tale finalità (aspetto indimostrabile), Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2024, n. 5493.
[5] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089, richiamata dall’Amministrazione civica, ove si ammette un prudente contemperamento dell’indefettibile diritto fondamentale del disabile alle necessarie misure di inclusione scolastica con i vincoli di finanza pubblica: aspetto che si atteggia a paradigmatica concretizzazione di tale nozione di matrice convenzionale, non potendo mai esigersi in capo all’Autorità pubblica che l’apprestamento di tali misure solidaristiche comportino oneri insopportabilmente sproporzionati o eccessivi, tali da mettere a rischio la copertura finanziaria di queste politiche nel medio-lungo periodo, concludendo che il corpus normativo nazionale che disattende l’invocato principio di prevalenza incondizionata del diritto all’inclusione scolastica rispetto alle esigenze finanziarie delle Amministrazioni pubbliche non si pone in insanabile tensione con le disposizioni della Convenzione ONU, anzi si inscrive coerentemente nella figura dell’accomodamento ragionevole.
[6] Va per completezza individuato il quadro normativo che disciplina la materia, dato dall’art. 13, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, dall’art. 139, comma primo, lett. c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dagli artt. 42 – 45 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dall’art. 3 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sul piano delle fonti esterne il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (ex artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost.
[7] Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 62/2020.
[8] Corte Costituzionale, sentenza n. 275/2016, dove si ricorda come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicap confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall’interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela, non potendo limitare gli interventi limitando gli stanziamenti in bilancio.
[9] Sono i principi costituzionali di cui all’art. 2 (sulla tutela dei «diritti inviolabili dell’uomo» e sui «doveri inderogabili di solidarietà … sociale»), all’art. 3 (secondo cui «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»), all’art. 34, primo comma (sulla apertura della scuola «a tutti») e all’art. 38, terzo comma (sul «diritto all’educazione» anche quando vi sia una disabilità), Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 2023/2017. In particolare, il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, di cui il diritto all’integrazione scolastica costituisce parte integrante, ha il suo fondamento nell’art. 34 della Costituzione, al pari di quello delle persone normo-dotate; esso è intrinsecamente connesso allo sviluppo della personalità per il legame esistente tra il principio di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., ed il diritto all’istruzione, di cui all’art. 34 Cost., Cons. Stato, sez. I,15 luglio 2020, n. 1331.
[10] Cfr. Corte cost., 29 ottobre 2024, n. 195, dove si chiarisce che in un contesto di risorse scarse, «per fare fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro unitari, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il “fondamentale” diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce più deboli della popolazione, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta out of pocket».
[11] Principii enunciati già dalla Corte Costituzionale sentenza n. 215/1987 e ribaditi nella sentenza n. 83/2019.
[12] Ad esempio, in una selezione pubblica, la mancata attivazione della prova integrativa dell’orale ha una sua decisiva incidenza nella verifica della legittimità o meno dei lavori: la mancanza della modalità orale è in contrasto con la ratio che anima l’attivazione di misure compensative e dispensative previste in favore di un alunno affetto da disturbo dell’apprendimento e cioè evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, cfr. Cons Stato, sez. VI, 9 luglio 2019, n. 4817. In modo similare, siamo in presenza di un licenziamento discriminatorio (discriminazione diretta) quando il datore di lavoro non tiene in considerazione la situazione di svantaggio del lavoratore disabile, adottando “soluzioni ragionevoli” idonee ad evitare una discriminazione che produca l’effetto di estromettere il dipendente dal contesto lavorativo, Tribunale Roma, sez. lav. IV, sentenza 26 novembre 2024, Est. Casoli.
[13] Cons. Stato, sez. I, Adunanza sez., 7 ottobre 2020, Numero Affare 01004/2020 (Numero 00403/2021 e data 15 marzo 2021 Spedizione).
[14] Corte conti, sez. contr. Lombardia, 11 ottobre 2021, n. 235.
[15] Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5317. Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 14 ottobre 2016, n. 10313.
[16] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 marzo 2021, n. 1923; TAR Lazio, Roma, sez. III, 11 maggio 2022, n. 5892; sez. II, 23 marzo 2021, n. 3530.
[17] Cfr. LUCCA, Piena tutela del minore con disabilità alla richiesta di un progetto individuale di miglioramento della qualità di vita: un dovere di in capo alla P.A., segretaricomunalivighenzi.it, 17 gennaio 2019, a commento della sentenza del TAR Valle D’Aosta, del 14 gennaio 2019, n. 2, ove si accoglie il ricorso contro il diniego di adozione di un progetto individuale di vita rivolto ad un minore, condannando la Regione ad attivare ad un facere: l’adozione degli atti necessario per garantire i diritti del minore disabile.
[18] TAR Calabria, Reggio Calabria, 5 ottobre 2023, n. 748.
The post Nessun limite di spesa per l’assistenza scolastica al disabile appeared first on lentepubblica.it.






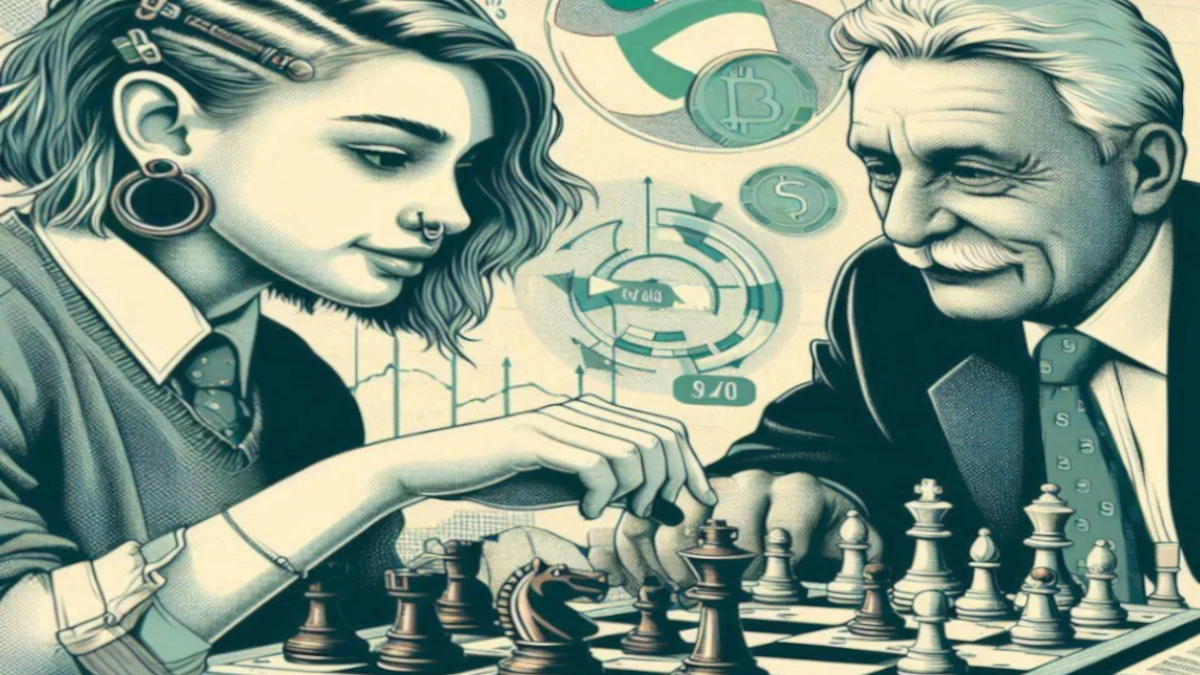
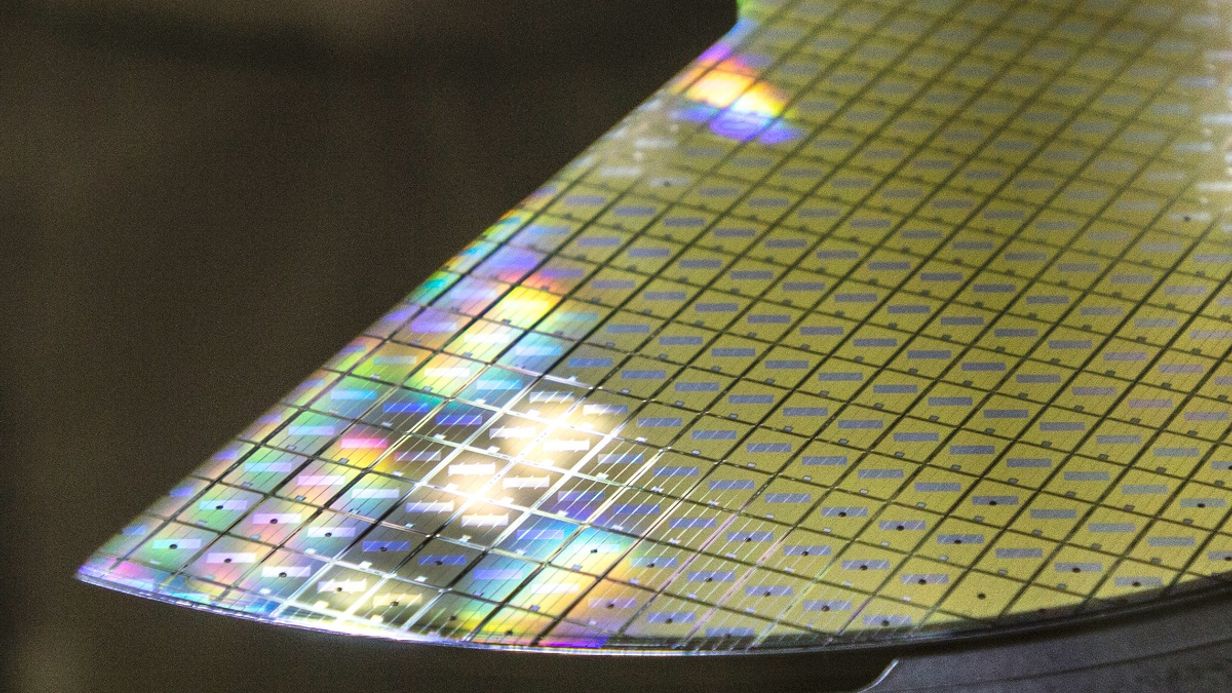

























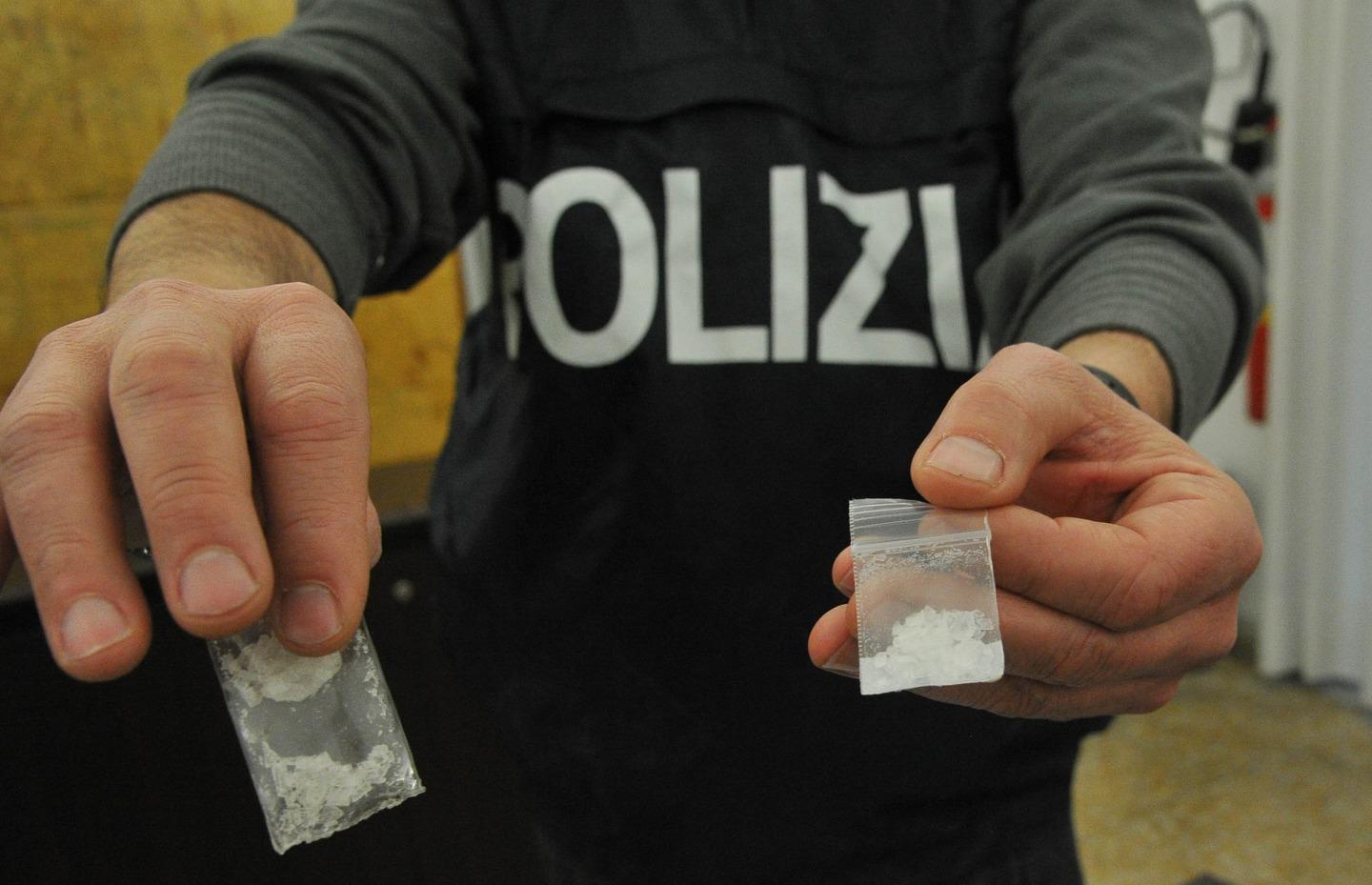







![La guida allo sport in tv oggi [lunedì 3 febbraio] | Il Teleco-Slalom](http://www.loslalom.it/wp-content/uploads/2024/04/tv.jpg)





