L’età neoliberista è finita?
Di recente sono “inciampato” in tre libri molto diversi tra loro, pubblicati negli ultimi tre anni, e tutti e tre incentrati sui problemi creati dall’ordine neoliberista, che ha vissuto il […]

Di recente sono “inciampato” in tre libri molto diversi tra loro, pubblicati negli ultimi tre anni, e tutti e tre incentrati sui problemi creati dall’ordine neoliberista, che ha vissuto il suo periodo di maggior splendore dalla fine degli anni ’70 ma che, ultimamente, è sostanzialmente entrato in crisi (o, perlomeno, ha pericolosamente vacillato). Le soluzioni che gli autori offrono per questo stato di crisi sono, rispettivamente (e sinteticamente): evoluzione, ritocchi e/o rivoluzione.
Cosa ha portato al punto in cui siamo?
La bella versione inglese del best-seller del 2014 del libro dell’economista francese Thomas Piketty, Capitalism in the Twenty-First Century, ha contribuito a portare un punto di vista su questi problemi all’attenzione del grande pubblico. In particolare, due grafici nel libro di Piketty hanno presentato un aspetto dell’andamento economico che ha caratterizzato il secolo scorso e che non era diffusamente noto all’epoca, ma che da allora è diventato di dominio pubblico:

I grafici precedenti ci mostrano che c’è stato un periodo di circa 35 anni, intorno al 1945-1980, di bassa disuguaglianza di reddito. In questo periodo, inoltre, le aliquote fiscali per la fascia di reddito più alta erano le più alte di sempre. A ciò si aggiunge che, durante quegli anni, gli Stati Uniti hanno sperimentato una crescita economica più elevata rispetto a quella registrata successivamente, negli anni di elevata disuguaglianza e bassa tassazione del 1980-2010. Vediamo alcuni numeri: la crescita del PIL è stata in media del 3,9% dal 1950 al 1980, ma solo del 2,7% dal 1980 al 2010. Da allora la crescita è stata ancora più bassa: del 2,4% dal 2000 al 2023, un periodo di disuguaglianza eccezionalmente elevata e basse aliquote di tassazione.
Questo però non quadra con la narrazione neoliberista. Tutt’altro!! Teoricamente le tasse basse dovrebbero stimolare l’innovazione e la crescita economica. La cosa rischia, certo, di causare disuguaglianze di reddito e di ricchezza perché una parte sproporzionata dei guadagni va agli innovatori e ai loro finanziatori, che sono una piccola percentuale della popolazione. La narrazione neoliberista però, purtroppo, non è stata confermata da quanto successo: la tesi non è verificata dai numeri! Il tasso di crescita economica è risultato invece più alto quando le tasse erano alte e, nonostante un alto tasso di innovazione durante la medesima epoca, che comunque si è realizzato senza la concessione di particolari benefici fiscali (o certamente non nella misura postulata – perché ritenuta necessaria – dai neo-liberisti), la disuguaglianza di reddito risultava bassa.
Una spiegazione può essere trovata con il punto di visita espresso nel libro di David Leonhardt, Ours Was the Shining Future: The Story of the American Dream. Verso la fine della seconda guerra mondiale c’era preoccupazione che i milioni di soldati di ritorno dal fronte sarebbero rimasti disoccupati, e questo avrebbe potuto scatenare un’altra depressione.
Un “consorzio” di proprietari e dirigenti aziendali apicali, guidato dal magnate dell’automobile Paul Hoffman, credeva però che l’economia potesse essere fatta nuovamente decollare, anche pagando salari elevati ai dipendenti. La cosa aveva senso – e molto! – perché i dipendenti ricevendo salari elevati sarebbero divenuti dei consumatori “entusiasti” dei nuovi prodotti che sarebbero contemporaneamente stati realizzati. In effetti, questa formula concepita per stimolare e rivitalizzare l’economia si è rivelata (possiamo dire) “magica”, determinando l’elevata crescita e la bassa disuguaglianza che ha poi caratterizzato per un lungo periodo il dopoguerra. Perché? Perché risolveva il problema centrale di una vera economia industriale: dotare i dipendenti di un potere di acquisto – che vada ben oltre i livelli di sussistenza – tale da permettergli di acquistare l’enorme produzione di un’economia industriale. A margine, mi raccomando di non equivocare come potrebbero fare molti “sprovveduti”: anche i direttori generali sono dipendenti, non siamo necessariamente qui, indipendentemente dalle convinzioni politiche, a tessere le lodi di dottrine socialiste!
La fine dell’era del New Deal
Verso la fine degli anni ’70, quell’era che Gary Gerstle – professore emerito di storia americana all’Università di Cambridge – chiama l’era del New Deal (che era risultata “nuova” solo a partire dai primi anni ’30) iniziò però, come egli osserva, ad essere sostituita da un’altra “nuova era”. Gerstle chiama questa nuova era “l’era neoliberista”, nel suo libro, The Rise and Fall of the Neoliberal Order: America and the World in the Free Market Era.
Gerstle ritiene di dover spiegare il suo uso del termine “neoliberista”: a partire dall’era Roosevelt, il significato del termine “liberale” ha iniziato a divergere tra Regno Unito e Stati Uniti. Nel Regno Unito, soprattutto tra gli intellettuali, “liberale” di solito significa ” liberale classico “, qualcuno che crede in un’economia laissez-faire, governo limitato e libero scambio, più vicino all’uso statunitense del termine “libertario”, mentre negli Stati Uniti, “liberale” significa qualcosa di più vicino a ” liberale sociale “, che denota una filosofia più di natura socialista, insomma si potrebbe dire, usando una categoria discutibile ma molto palatabile per il pubblico della strada, “di sinistra”. Gerstle usa il termine “neoliberista” non per distinguerlo da “liberale classico”, ma per far rivivere il significato originale di liberalismo.
Il libro di Gerstle in realtà non riguarda una, ma due nuove ere, apparse in successione una dopo l’altra. Dice infatti: “Negli ultimi cento anni, l’America ha avuto due ordini politici: l’ordine del New Deal che è sorto negli anni ’30 e ’40, raggiungendo l’apice negli anni ’50 e ’60 ed è crollato negli anni ’70. L’ordine neoliberista, che è sorto negli anni ’70 e ’80, raggiungendo l’apice tra gli anni ’90 e 2000, ed è crollato negli anni 2010”.
Le due ere (o “ordini mondiali”) sono quasi in contraddizione diretta tra di loro. “L’ordine del New Deal”, dice Gerstle, “era fondato sulla convinzione che il capitalismo lasciato a se stesso conducesse al disastro economico: doveva essere gestito da uno stato centrale, forte in grado di governare il sistema economico nell’interesse pubblico”. L’ordine neoliberista, al contrario, “era fondato sulla convinzione che le forze di mercato dovessero essere liberate dai controlli normativi e governativi, che stavano ostacolando la crescita, l’innovazione e la libertà”.
Prima dell’ordine mondiale del New Deal, c’era un ordine antecedente che era molto più un ordine liberale classico, caratterizzato da libero scambio, poca regolamentazione governativa dell’industria e alti livelli di immigrazione. Inoltre, come mostrano i grafici di Piketty, coincideva con un periodo caratterizzato da alti livelli di disuguaglianza. Il New Deal, l’ordine economico successivo, prese nei fatti il via a causa dell’evidente fallimento dell’ordine globale precedente, che aveva condotto il mondo alla Grande Depressione.
L’ordine neoliberista, al contrario, è stato avviato quando è maturata la percezione/sensazione – quindi in assenza di specifici tratti/eventi traumatici – che l’intervento regolamentare del Governo nell’economia fosse andata troppo oltre. Viene spesso citata l’affermazione del Presidente Reagan nel corso del suo discorso inaugurale del 1981: “il governo non è la soluzione al nostro problema, il governo è il problema”. Il punto è che questa citazione viene – erroneamente – estrapolata dal contesto.
Ciò che egli disse, in realtà, fu: “In questa crisi attuale, il governo non è la soluzione al nostro problema, il governo è il problema”. (con una certa enfasi aggiunta). La nazione aveva da poco vissuto una profonda crisi energetica, che rappresento la causa più prossima e diretta del crollo del mercato azionario del 1973-74 e dell’aumento dell’inflazione, successivamente aggravata dai controlli governativi sui prezzi del petrolio e del gas naturale.
È interessante come l’inizio di ogni nuova era sia stato preceduto da un calo del 50 percento del mercato azionario, sia nel 1929-1932 sia nel 1973-1974. E la (nuova) era successiva, quella che potremmo avere già iniziato, la cui natura Gerstle non prevede (perché è uno storico, non un previsore), sia stata preceduta da un altro calo del 50 percento, nel 2008-2009.
Secondo Gerstle, stiamo in fase di transizione evolutiva dall’era neoliberista a un altro nuovo ordine. Le reazioni negative contro molti dei principi del neoliberismo, in aree tematiche come l’opposizione al libero scambio e all’immigrazione da un lato, e una regolamentazione finanziaria troppo leggera dall’altro, stanno diventando più forti e probabilmente porteranno a un crollo accelerato dell’ordine neoliberista.
È poi interessante che, quando Gerstle parla delle personalità politiche emergenti negli Stati Uniti nell’alveo di questa tendenza, parli quasi allo stesso modo di Donald Trump e Bernie Sanders: da questo punto di vista, si potrebbe persino supporre (azzardando un po’) che siano in realtà collocate nello stesso campo: entrambi – i due candidati politici – hanno guadagnato popolarità a causa della reazione contro l’ordine neoliberista.
Modifiche e rivoluzione
Gli altri due libri dei tre che ho menzionato all’inizio non riguardano l’evoluzione del sistema – che da concretezza all’ordine globale – come quello di Gerstle. Piuttosto, riguardano rispettivamente il graduale modificarsi del sistema per alleviarne i problemi e le contraddizioni e, all’estremo opposto, l’eventuale alternativa di capovolgimento del sistema (detto più comunemente “rivoluzione”). Non ho però trovato nessuno di questi libri interessante quanto quello di Gerstle.
Uno dei due succitati, The Crisis of Democratic Capitalism , è scritto dal noto “pilastro del capitalismo”, Martin Wolf, il principale commentatore economico del Financial Times. L’altro, Invisible Doctrine: The Secret History of Neoliberalism, è scritto dall’anticapitalista (“viscerale”) George Monbiot, un attivista ambientale e politico, e dal regista Peter Hutchinson.
Wolf non usa la parola neoliberismo, ma parla di capitalismo democratico, termine che non è la stessa cosa ma che è stato “catturato” e fatto proprio dal neoliberismo nella sua recente versione. Wolf ritiene che democrazia e capitalismo siano necessariamente “in tensione” e che la loro difficile sintesi è ciò che lui chiama “capitalismo democratico”. Più precisamente: la democrazia è nazionale mentre il capitalismo è globale e “la politica democratica si basa sull’idea egualitaria di una persona, un voto, mentre l’economia di mercato si fonda sull’idea “ineguale” che i concorrenti di successo raccolgono i frutti” (gli altri si arrangiano). Quindi, integrare i due è un compito delicato ed egli afferma che questa sintesi è oggi in crisi.
La soluzione proposta da Wolf è quella di modificare per passi e gradualmente il sistema. Egli afferma infatti: “Dobbiamo agire in modo radicale e tuttavia incrementale, imparando dall’esperienza man mano che procediamo”. Wolf ovviamente legge molto ed è estremamente competente. Ecco perché è deludente che il suo libro non sia particolarmente coinvolgente ed illuminante. Una vera delusione!
Tuttavia, fornisce una delle più complete smentite che abbia mai visto dell’affermazione di Milton Friedman in un famoso articolo di opinione del 1970 sul New York Times , secondo cui l’unica responsabilità di un’azienda è quella di massimizzare i profitti dei propri azionisti. Questo offre l’opportunità di sottolineare la formulazione ambigua che è intrinseca all’articolo di Friedman e che ne costituisce anche il difetto fondamentale. Nel 1970, come dice Wolf, Friedman dichiarò che “c’è una e una sola responsabilità sociale delle aziende: usare le proprie risorse e impegnarsi in attività volte ad aumentare i propri profitti, purché rimangano entro le regole del gioco, ovvero si impegnino in una concorrenza aperta e libera senza inganni o frodi”. (mi scuso per l’enfasi aggiunta alle parole testuali).
Cosa però è considerato “inganno” da Friedman? Ad esempio, supponiamo che un consulente finanziario o un gestore di investimenti, parlando con un potenziale cliente, tiri fuori un’esposizione matematica dall’aspetto complicato, sottintendendo che, utilizzando la teoria vincitrice del premio Nobel “incarnata” nell’esposizione, il consulente o il gestore consentirà al cliente di superare il mercato? Non è inganno questo? Oppure supponiamo che un venditore di auto usate dica a un potenziale acquirente che un’auto è in perfette condizioni di funzionamento e non ha mai avuto problemi, mentre così non è! Non è inganno questo? Come hanno spiegato George Akerlof e Robert Shiller nel loro libro perspicace e piacevole, Phishing for Phools , l’inganno è parte integrante di un’economia capitalista, e probabilmente anche di qualsiasi altro tipo di economia. Quindi l’ammonimento di Friedman in realtà si applica a ben poca parte della realtà economica di tutti i giorni.
Conclusioni
Ho aggiunto il libro di Monbiot e Hutchinson, Invisible Doctrine, alle letture sul neoliberismo perché, a differenza di quello di Wolf, che evita la parola neoliberale o neoliberismo, quello di Monbiot la usa 266 volte. Mentre il libro contiene alcune caratterizzazioni accurate del neoliberismo, gran parte di esso è una polemica che a volte è decisamente banale e stucchevole. Ad esempio, l’autore afferma: “Il neoliberismo non è né inevitabile né immutabile. Al contrario, è stato concepito e promosso come un mezzo deliberato per cambiare la natura del potere”. Cosa significhi esattamente non è chiaro, almeno a me, e se qualcun altro lo capisce/decritta è pregato di farmelo sapere. Vi sono anche altre visioni negative del capitalismo. Di seguito, alcune citazioni:
- “…il capitalismo, secondo la nostra definizione, ‘trasforma le risorse condivise in proprietà esclusiva’…”
- “Invariabilmente, i servizi pubblici venivano venduti (in alcuni casi regalati) a proprietari privati a un prezzo molto inferiore al loro valore reale…”
- “Di norma, la privatizzazione è un furto legalizzato della sfera pubblica…”
È altamente discutibile se il capitalismo trasformi le risorse condivise in proprietà esclusiva attraverso il furto legalizzato.
Ma si afferma anche che:
- In nessun momento, per quanto liberali siano le sue pretese, la condizione fondamentale del capitalismo è stata alterata: è, ed è sempre stato, “un sistema economico fondato sul saccheggio coloniale”.
Presumibilmente, il “saccheggio coloniale” di cui si parla è riferito alla violenza inflitta alle popolazioni native nell’era dei conquistatori europei, la maggior parte della quale si è verificata prima che il capitalismo fosse una cosa compiuta. Interpretandoli generosamente, gli autori sembrano confondere il capitalismo con le conquiste coloniali. Buffo, no?
La cosa che risulta più assurda, almeno per me, è la loro discussione strampalata sulle origini del capitalismo. Dicono: “Quando le origini del capitalismo sono contestate, crediamo che ci sia la possibilità di rintracciarle nell’isola di Madeira”. Gli esploratori portoghesi sbarcarono a Madeira, un’isola incontaminata senza abitanti umani o mammiferi, nel 1420. Poi, secondo il racconto di Monbiot e Hutchinson, procedettero a “violentarla” sfruttando la sua principale risorsa, il legno (“madeira” significa legno in portoghese), quindi se ne andarono e andarono sull’isola di Sao Tomé per “violentare” anche quella. “Lì si è ripetuto lo schema che era stato stabilito a Madeira: Boom, Crollo, Abbandono”. Quindi essi concludono: “Alla fine, tutto il mondo è Madeira. Il capitalismo non è l’unico sistema economico ad aver bruciato e avvelenato il pianeta”. Beh, a detta di molte persone che conoscono bene l’isola di Madeira, essa non appare né bruciata né avvelenata. Viene quindi naturale chiedersi se Monbiot e/o Hutchinson ci siano mai stati.
Quanto alla soluzione a quella che percepiscono come la maledizione del capitalismo, gli stessi affermano: “una società giusta, prospera e sostenibile non può materializzarsi nelle condizioni attuali. Abbiamo bisogno di una trasformazione radicale”. Inutile dire che questa affermazione non è di grande aiuto per risolvere “operativamente” i problemi del neoliberismo.
Consiglio quindi, per concludere, di leggere il libro del professor Gerstle (e quello di Leonhardt), saltando senza indugio gli altri due: ha molto più senso, nella mia umile opinione, un approccio storico che vede ed interpreta la transizione “fuori” dal neoliberismo, come un “normale” – se così possiamo dire – processo storico-sociale, riguardante un’epoca ed un ordine che ha ormai fatto il suo tempo e non è più in grado di mantenere il sistema in equilibrio… al di là di moralismi e tesi vagamente e genericamente “egalitarie”! Per i più “pruriginosi”, vale la pena notare che un approccio di questo tipo, quello di Gerstle (e quello di Leonhardt) è molto più vicino al “materialismo storico” – ed alla teoria dei cicli secolari sotto un altro, differente ma collegato, aspetto – di quanto lo siano gli approcci dei due libri che sconsigliamo di leggere. Un consiglio accorato visto che simili evoluzioni sono sempre accompagnate da eventi traumatici sia dal lato dell’economia reale – vedi ad esempio le politiche commerciali ed i dazi – oltre che dal lato dell’economia finanziaria che interessa gli equilibri (o disequilibri) dei mercati.




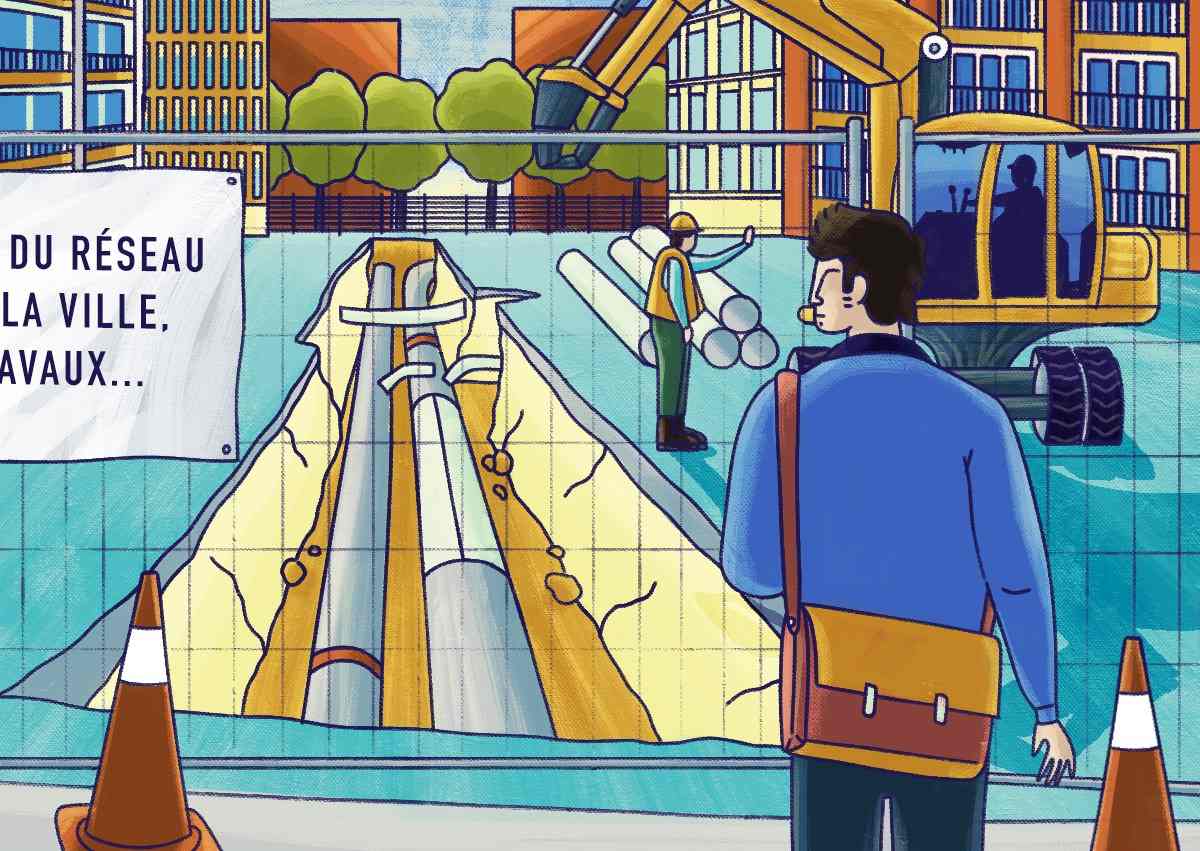


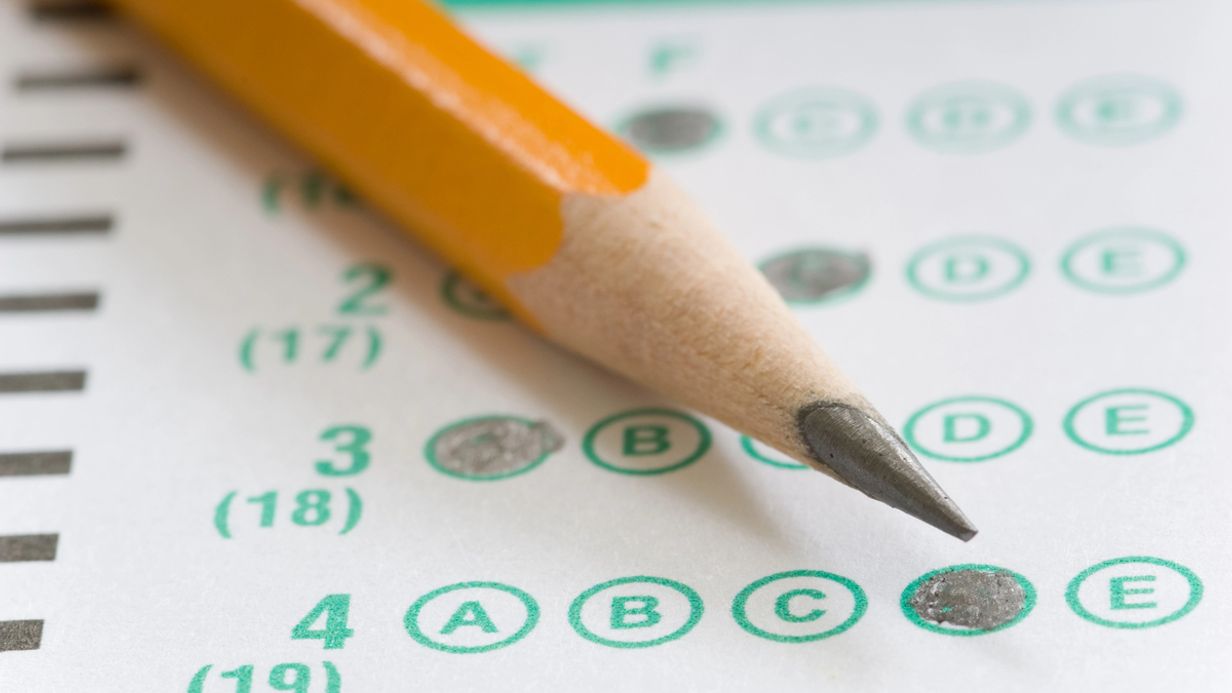








































/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/04/4094142-83020504-310-310.png)




