Le pecche della politica, i peccati della magistratura
Politica e giustizia? Facciamo valutare a un alieno... Il corsivo di Battista Falconi

Politica e giustizia? Facciamo valutare a un alieno… Il corsivo di Battista Falconi
Sarebbe utile mostrare la diatriba tra politica e giustizia a un alieno, per averne una valutazione imparziale e panoramica. Forse andrebbe bene anche l’uso di un buon programma di intelligenza artificiale, ma resterebbe il dubbio che l’algoritmo sia stato programmato in modo tendenzioso: di solito ci preoccupiamo delle macchine che potrebbero “pensare” autonomamente, quando in realtà il rischio maggiore è quello che somiglino troppo a noi umani.
L’extraterrestre potrebbe innanzitutto valutare l’estensione spaziale del problema, fortemente sentito qui in Italia ma che investe molti altri paesi di varie latitudini – dagli Usa alla Corea del Sud, dall’Est europeo al Sudamerica – ancorché in forme diverse. E poi collocherebbe temporalmente la questione rispetto alla storia delle democrazie liberali parlamentari, tre termini spesso affiancati sinonimicamente ma che intendono cose parecchio diverse: il mandato elettivo top down degli incarichi di rappresentanza, la tutela dei diritti individuali e collettivi affidata alle istituzioni, la prevalenza del potere legislativo nei processi normativi.
Il principio democratico porta a scelte molto diverse, negli Usa per esempio viene applicato anche al potere giudiziario, cosa da noi giudicata impensabile, come pure l’ipotesi di nominare alcune figure giudiziarie a sorteggio; il sorteggio, anzi, viene in Italia malvisto per qualunque ruolo apicale e decisionale, mentre è un sistema che consentirebbe di azzerare le polemiche sulla faziosità delle scelte in modo più efficace di altri. L’istanza liberale richiederebbe una drastica riduzione dei processi normativi ex ante ed ex post, in sostanza quindi poche leggi e pochi giudizi, così da aumentare le possibilità espressive e imprenditoriali del singolo e da ripristinare i valori fondamentali del diritto, ovviamente eroso dal proliferare normativo e giudiziario: più leggi e più sentenze sono sinonimo di una necessità, reale o percepita, di compressione dell’agire per timore di conseguenze dannose, si converrà che è un atteggiamento molto negativo anche quando sia motivato da buone intenzioni, per esempio con le aggravanti di pena per alcune tipologie di omicidi e atti violenti. Il parlamentarismo, infine, è rimasto incagliato in un partitismo ideologico che non ha più molta ragion d’essere, finendo per diventare soprattutto un intralcio ai processi decisionali, in forma di ostacolo o comunque di freno, che contribuisce inoltre all’aggrovigliarsi degli scontri tra poteri.
Infine, l’Et potrebbe darci una corretta valutazione concettuale, culturale e lessicale dello scontro risalendo ai significati originari ed etimologici di politica e giustizia, rispettivamente arte del governare, preoccupazione per la cosa pubblica e possesso di una qualità di rettitudine ed equilibrio. Un coacervo tra greco e latino che ci ricorda come, in questi due termini, si mescolinol’astrazione filosofica del pensiero astratto e la preoccupazione pratica di far stare bene le persone: cose ottime entrambe ma non sempre facilmente collimanti.
Soltanto a questo punto, l’extraterrestre si impelagherebbe nelle quisquilie quotidiane che affollano le cronache e stimolano le chiacchiere: riforma della magistratura, separazione delle carriere, dimissioni di esponenti governativi oggetto di indagini e processi, avvisi recapitati ai vertici dell’esecutivo aventi per oggetto azioni politiche, etc. E probabilmente, a valle dei molti elementi da considerare, direbbe che ben difficilmente si può risolvere il problema in modo deontologico, cioè regolando le attività di politici e magistrati per farli andare più d’accordo, quando il nodo è ontologico, riguarda quindi l’uomo politico e giudice in sé.
Da un lato, abbiamo una classe parlamentare e governativa che non ha dato mediamente buona prova di sé, palesando limiti di capacità ma anche etici, una disinvoltura che consente di trovare numerosi appigli discutibili nell’operato politico. Dall’altro abbiamo una magistratura che vive nella convinzione della propria perfezione e rifiuta non solo di ricevere la pur minima critica ma anche di riconoscere ciò che è innegabile, cioè di svolgere un’attività eminentemente soggettiva, che pertanto necessita di un rigoroso controllo esterno.












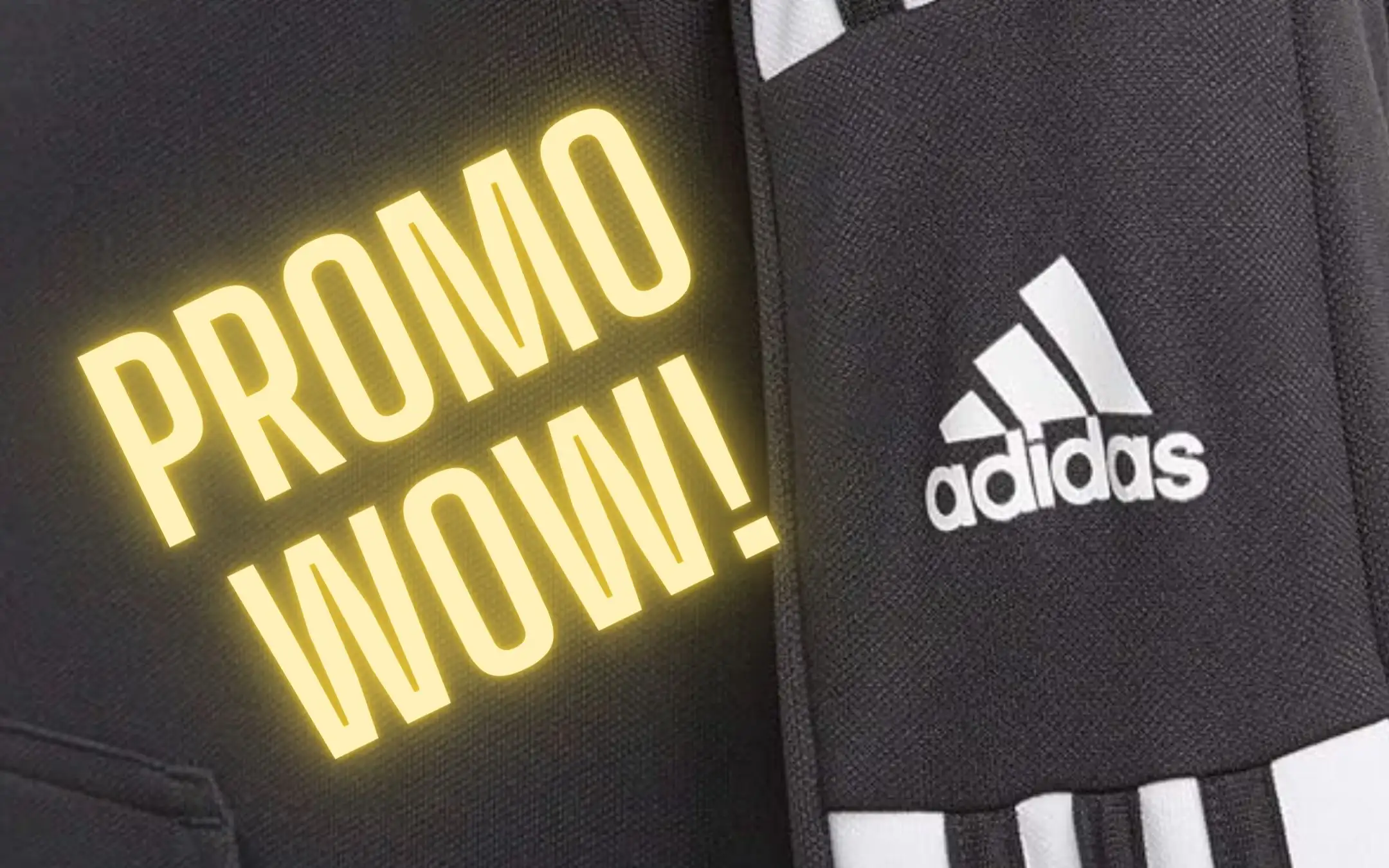

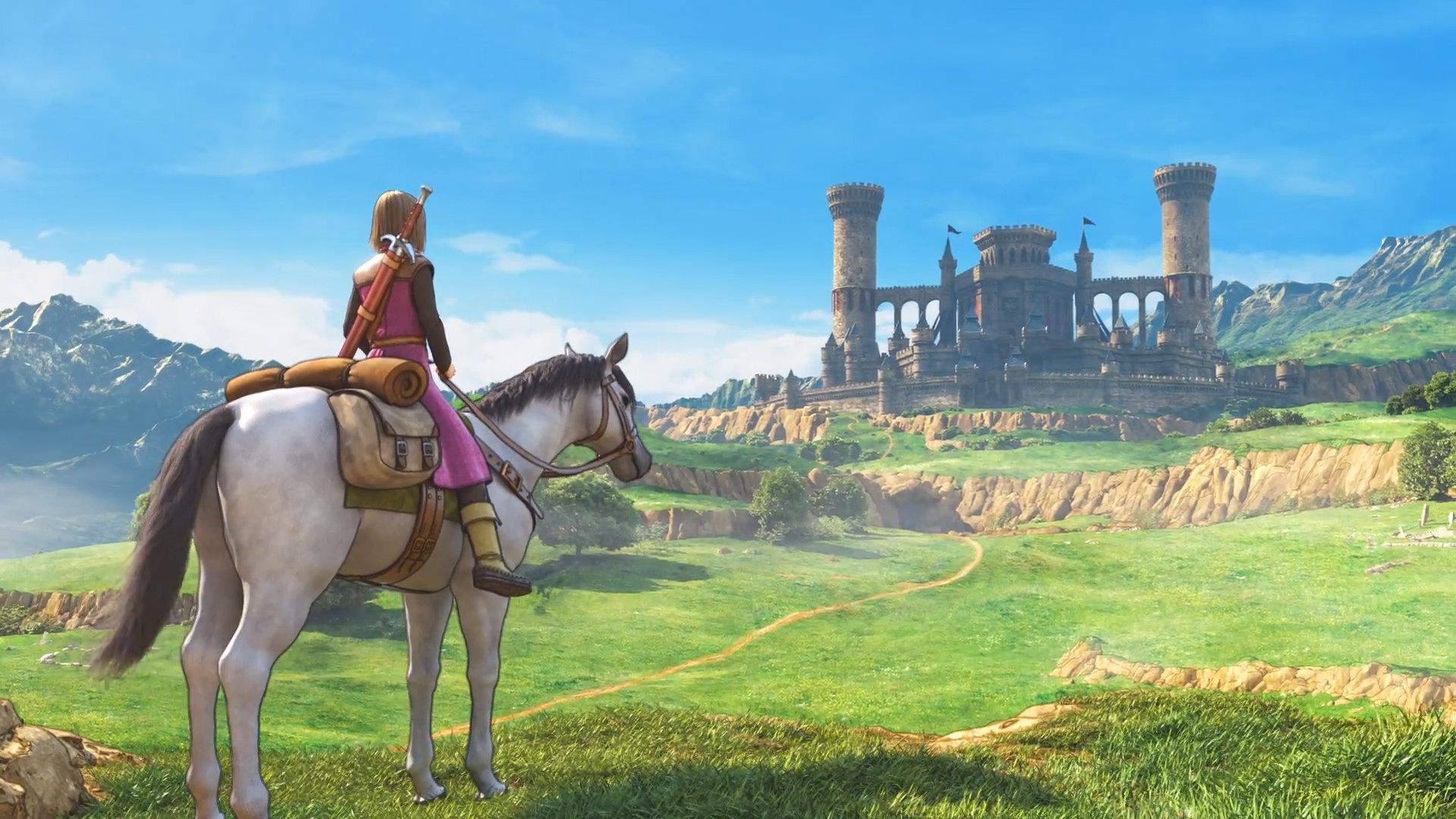



























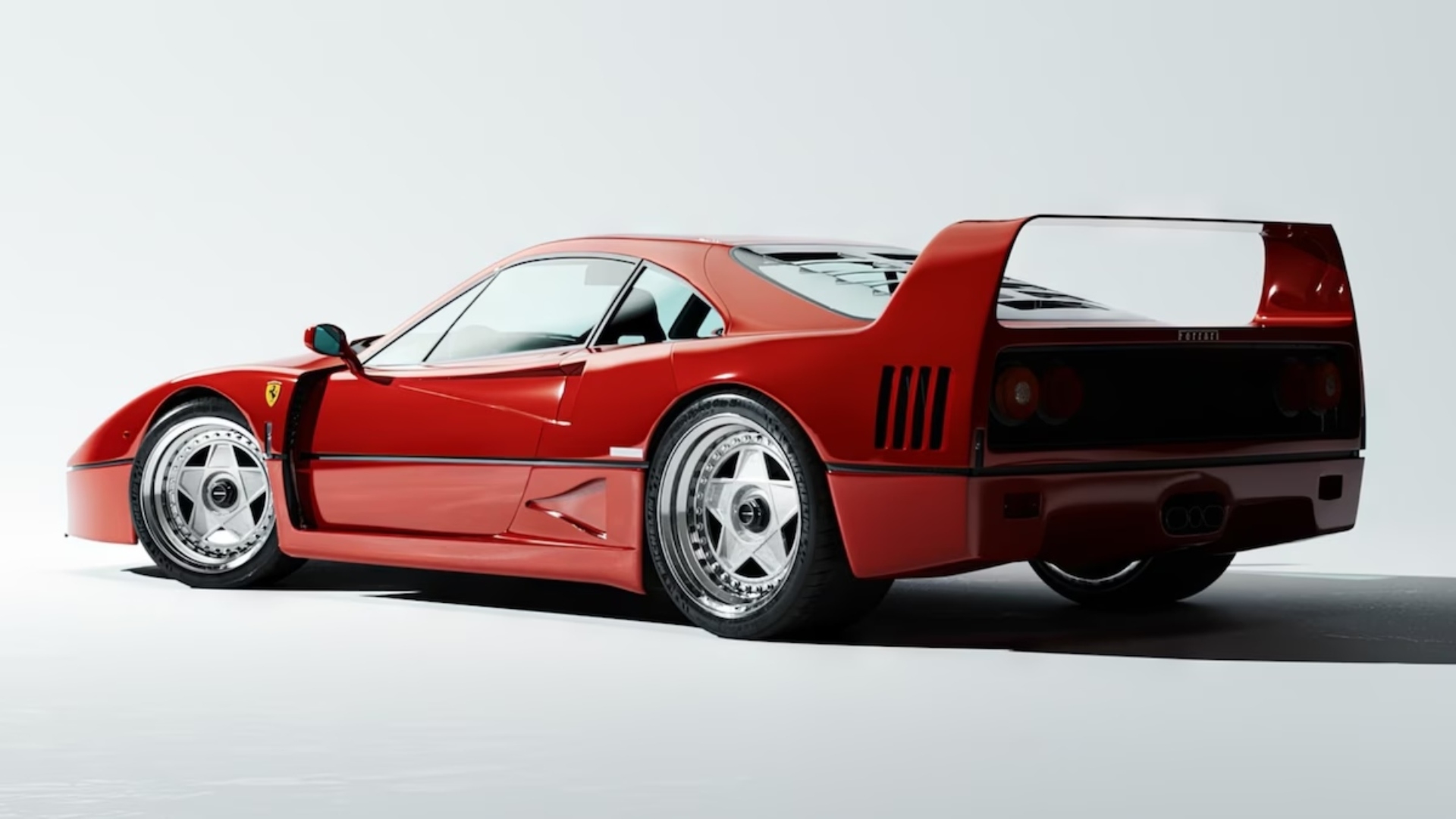




/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/02/4093425-83006164-310-310.jpg)
/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/02/4093468-83007024-310-310.jpg)
/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/02/4093504-83007744-310-310.jpg)




