Inauguration Day: oggi la fine della transizione e l’insediamento di Trump. Cosa aspettarsi dal suo primo discorso ufficiale da Presidente
Tutti gli occhi del mondo sull'Inauguration Day e il ritorno ufficiale di Donald Trump alla Casa Bianca. Il suo discorso farà capire come sarà Trump 2.0 L'articolo Inauguration Day: oggi la fine della transizione e l’insediamento di Trump. Cosa aspettarsi dal suo primo discorso ufficiale da Presidente proviene da FIRSTonline.


A mezzogiorno di oggi (le ore 18 in Italia), 20 gennaio (Inauguration Day), Donald Trump giurerà come quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti ed entrerà formalmente in carica. Inizierà così in modo ufficiale la sua amministrazione ed avrà fine quel periodo di transizione del potere, iniziato il 6 novembre scorso, che quest’anno ha determinato non pochi paradossi istituzionali.
La conclusione della transizione
In origine, la transizione era molto più lunga, perché il neopresidente si insediava il 4 marzo. Il periodo venne quasi dimezzato con il XX emendamento, approvato nel 1933 ed entrato in vigore nel 1937, in quanto l’aggravamento della crisi economica, che era iniziata nel 1929, nel corso dell’inverno del 1933 fu imputato al rifiuto del democratico Franklin D. Roosevelt, eletto nel 1932, di definire iniziative comuni per la ripresa con l’inquilino della Casa Bianca ormai a fine mandato, il repubblicano Herbert Hoover. Comunque, a prescindere dalla durata della transizione, in base alla Costituzione, il presidente uscente rimane il capo dell’esecutivo a tutti gli effetti e conserva la pienezza delle sue funzioni fino all’insediamento del suo successore.
Per esempio, in passato, in questa fase di interregno solo apparente tra un’amministrazione e l’altra, John Adams nominò John Marshall come presidente della Corte Suprema nel 1801; John Tyler promulgò il provvedimento di annessione del Texas nel 1845; Dwight D. Eisenhower ruppe le relazioni con Cuba nel 1961 e autorizzò la CIA ad addestrare forze anticastriste in Guatemala; George H.W. Bush dispiegò un contingente di 28.000 soldati in Somalia nel dicembre del 1992 nell’ambito dell’operazione Restore Hope delle Nazioni Unite per garantire l’arrivo degli aiuti umanitari della comunità internazionale alla popolazione civile e, una settimana prima della conclusione del suo mandato, il 13 gennaio 1993, dette il via a una rappresaglia militare contro il regime di Saddam Hussein in Iraq. Questa volta, però, le cose sono andate diversamente.
Nei giorni scorsi Joe Biden ha emanato alcuni decreti per ostacolare preventivamente alcune politiche promesse da Trump: ha vietato nuove trivellazioni petrolifere al largo di acque federali; ha esteso per diciotto mesi la sospensione della deportazione per circa 900.000 migranti originari di El Salvador, Sudan, Ucraina e Venezuela; ha cancellato Cuba dall’elenco degli “Stati sponsor del terrorismo”. Però, per tutti o quasi, è stato come se Trump fosse subentrato a Biden già il 6 novembre dello scorso anno. Pertanto, per esempio, ignorando il presidente ancora in carica, si sono recati nella magione di The Donald a Mar-a-Lago il primo ministro canadese Justin Trudeau, già alla fine di novembre, per discutere con Trump di politiche commerciali e dazi protezionistici e, più recentemente, la premier italiana Giorgia Meloni per affrontare con il tycoon il complesso intreccio tra il caso di Mohammad Abedini e quello di Cecilia Sala.
Inoltre, sia pure in sinergia con l’inviato di Biden, Brett McGurk, Trump ha condotto una trattativa con Benjamin Netanyahu su Gaza attraverso un proprio rappresentante per il Medio Oriente, Steve Witkoff, in parallelo a quella ufficiale del presidente democratico ancora in carica. Tant’è che, tra il serio e il faceto, un giornalista ha addirittura chiesto a Biden se l’accordo sul cessate il fuoco, annunciato mercoledì scorso, fosse merito suo oppure di Trump, sebbene il testo rispecchi in larga misura la proposta avanzata proprio dalla Casa Bianca la scorsa primavera.
Tra retorica e sostanza
Dopo aver giurato fedeltà alla Costituzione federale, Trump terrà un discorso, secondo una tradizione inaugurata dal primo presidente, George Washington, nel lontano 1789. Sarà l’occasione per esporre gli obiettivi della sua seconda presidenza e la sua visione dell’America, come vuole una prassi consolidata.
Per esempio, nel 1977, il democratico Jimmy Carter, che fece il suo ingresso alla Casa Bianca in una fase storica in cui gli Stati Uniti erano stati screditati dal coinvolgimento militare nel Vietnam e dallo scandalo Watergate, utilizzò il discorso per dichiarare che la sua amministrazione avrebbe incentrato la politica estera non più sull’anticomunismo bensì sulla difesa e sulla promozione dei diritti umani su scala planetaria.
Invece, nel 1981, il suo successore, il repubblicano Ronald Reagan, anticipò la volontà di procedere a un radicale ridimensionamento del welfare state. Però, l’intenzione di arrivare a un governo “minimo” venne arginata dalla sconfitta del partito repubblicano nelle successive elezioni di metà mandato del 1982 e soprattutto dalla consapevolezza che i tagli alla previdenza sociale e all’assistenza sanitaria per gli anziani avrebbero messo a rischio la rielezione dello stesso Reagan nel 1984. Pertanto, Reagan si limitò a decurtare l’entità degli stanziamenti per finanziare lo stato sociale, senza cancellarne la struttura portante. A posteriori, il passaggio più celebre di quanto aveva detto al momento di assumere la carica nel 1981 – “il governo non è la soluzione per i nostri problemi. Il governo è il problema” – sembrò suonare come una mera affermazione retorica. Quest’ultima dimensione è un altro aspetto comune ai discorsi di insediamento.
Per esempio, nel 1933 il democratico Franklin D. Roosevelt volle rassicurare gli statunitensi che erano terrorizzati di finire sul lastrico a causa della depressione economica con una ventata di ottimismo, più psicologica che di sostanza: “l’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa”. La presidenza del suo predecessore, durante la quale la società americana era stata travolta dal crollo della borsa di Wall Street nel 1929, era paradossalmente iniziata con l’asserzione, da parte di Hoover, di non avere “timori per i futuro del nostro Paese. Brilla di speranza”. Nel 1961 un altro democratico, John F. Kennedy, esaltò il senso civico degli statunitensi: “non chiedetevi che cosa il vostro Paese possa fare per voi, ma chiedetevi che cosa possiate fare voi per il vostro Paese”.
Superare i contrasti
In passato, il discorso di insediamento del presidente è stato anche l’occasione per rimarginare le lacerazioni della campagna elettorale precedente e ricompattare il Paese in nome degli interessi nazionali comuni. Fu così fin quasi dalla nascita degli Stati Uniti.
“Abbiamo chiamato con nomi diversi coloro che sono fratelli nello stesso principio. Siamo tutti repubblicani. Siamo tutti federalisti”. Così si espresse il democratico-repubblicano Thomas Jefferson, al momento di entrare in carica il 4 marzo 1801. Eppur il suo avversario federalista, il presidente uscente John Adams, si era rifiutato di partecipare alla cerimonia di insediamento e, nella campagna elettorale dalla quale era uscito sconfitto, lo aveva accusato di essere un ateo, un libertino e un meticcio, figlio di una nativa americana e di un mulatto afroamericano, quest’ultima un’imputazione particolarmente infamante in una società dove lo schiavismo era ancora legale.
Oltre mezzo secolo più tardi, nel 1865, il repubblicano Abraham Lincoln ribadì l’approccio di Jefferson, dopo che le contrapposizioni interne erano addirittura degenerate in una guerra civile in corso da quasi quattro anni, e si impegnò con i confederati, contro cui i combattimenti erano ancora in corso, a garantire una riconciliazione nazionale “con malanimo verso nessuno, con carità per tutti” in nome della necessità di “sanare le ferite del Paese”.
Ancora nel 1989, nonostante uno scontro elettorale senza esclusione di colpi, il repubblicano George H.W. Bush dichiarò di “tendere la mano” agli esponenti democratici per elevarsi al di sopra delle divisioni partitiche e “lavorare insieme” a ristabilire la collaborazione tra le forze politiche. Perfino il repubblicano Richard M. Nixon, che non aveva lesinato colpi bassi nella campagna elettorale del 1968 e occhieggiato al voto dei bianchi razzisti del Sud, nel 1969 si diffuse sull’imprescindibilità del rendere coesa la società americana, superando segregazione, discriminazione e ingiustizia sociale.
La rottura di Trump col passato
Questa tradizione è venuta meno con Trump. Nel 2017 The Donald si limitò a ringraziare il presidente uscente, il democratico Barack Obama, e sua moglie Michelle, per l’aiuto che gli avevano dato nel periodo della transizione tra le due amministrazioni, e a constatare che in tutti gli statunitensi scorreva il sangue rosso dei patrioti, a prescindere dalla regione in cui erano nati e dal colore della pelle. Nel complesso, però, le sue parole tracimarono in un’oratoria aggressiva che si addiceva più a un comizio che a un evento istituzionale. In particolare, Trump si scagliò contro la dirigenza di entrambi i partiti che, a suo dire, si era arroccata a Washington in difesa dei propri privilegi, mentre la popolazione versava nella disoccupazione e in condizioni di povertà e le città erano minacciate da gang criminali e dalla diffusione delle droghe con l’America ridotta a teatro di una “carneficina”.
The Donald, quindi, non svestì i panni del candidato per indossare l’abito dello statista e continuò a esprimersi con quel linguaggio incendiario che aveva connotato gli interventi ai raduni dei suoi sostenitori e che avrebbe caratterizzato anche la sua prima presidenza. Non a caso, il suo discorso si concluse con un richiamo esplicito allo slogan “Make America Great Again” della campagna elettorale conclusasi da poco: “insieme torneremo a rendere grande l’America”.
Una rivisitazione del discorso d’insediamento del 2017?
Nella scorsa campagna elettorale, dopo l’attentato subito a Butler, in Pennsylvania, il 13 luglio, Trump fece ricorso a toni più concilianti del passato nei suoi comizi, abbandonando gli attacchi personali contro Biden, che in precedenza era stato solito definire “il peggior presidente della storia”. Cambiò addirittura alcuni passi del discorso che pronunciò alla convenziona repubblicana di Milwaukee che, cinque giorni dopo, gli conferì la nomination per la Casa Bianca, in modo da smorzare gli accenti maggiormente polemici e apparire più inclusivo. Per esempio, inserì un’affermazione che si richiamava alla coesione: “come americani, siamo legati da un destino unico e comune. O ci solleviamo insieme oppure crolliamo”. Fu, però, un breve momento, favorito dall’inconsistenza della candidatura di Biden, precipitato nei sondaggi dopo l’imbarazzante dibattito televisivo con il tycoon del 27 giugno. Il ritiro del presidente dalla corsa per la Casa Bianca e la sua sostituzione con Kamala Harris quale candidata democratica fecero riemergere il linguaggio aggressivo a cui Trump ci ha abituato.
Nel 2028 Trump non potrà ricandidarsi alla presidenza per il limite costituzionale del XXII emendamento che, dal 1951, non permette a nessuno di ricoprire più di due mandati alla Casa Bianca, a prescindere dal fatto che siano consecutivi o meno. A differenza del 20 gennaio 2017, Trump non avrà da prepararsi il terreno per affrontare una ulteriore campagna elettorale per la quale gli attacchi verbali sono sempre stati uno strumento contro i propri avversari. Qualcuno potrebbe, quindi, aspettarsi un discorso più presidenziale e meno polemico rispetto a otto anni fa, anche alla luce della constatazione che il successo elettorale del 5 novembre 2024 è stato più netto grazie alla conquista della maggioranza relativa del voto popolare.
Atteggiarsi a presidente di tutti gli statunitensi e non soltanto a capopopolo dei propri sostenitori sarebbe quanto mai necessario in un momento storico in cui, nonostante il trionfalismo di Trump nella notte del 5 novembre, la società americana rimane divisa in due metà contrapposte, numericamente quasi equivalenti. Lo ha attestato il margine di vantaggio contenuto nel voto popolare riportato da Trump proprio nelle elezioni presidenziali: il 49,9% rispetto al 48,4% di Harris. Tuttavia, come dimostrano le audizione del Senato per la conferma della nomina di Pete Hegseth al Pentagono, sulla quale anche alcuni membri repubblicani hanno manifestato perplessità, la strada dell’amministrazione Trump è tutt’altro che in discesa.
Il rapporto del procuratore speciale Jack Smith sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ha riacceso la diatriba sul comportamento eversivo e le tendenze all’autoritarismo di Trump. Smith ha, infatti, sostenuto che ci sarebbero stati sufficienti elementi probatori per giudicare The Donald colpevole di aver sobillato i suoi sostenitori a irrompere nella sede del Congresso, anche se il caso è stato archiviato in seguito alla rielezione del tycoon. Non è, quindi, da escludere che Trump torni a sfruttare il discorso di insediamento per lanciare i propri strali contro il partito democratico, nonostante questa forza politica sia precipitata in una forte crisi di identità dopo la sconfitta di Harris, contro il cosiddetto deep state (gli alti burocrati federali che gli avrebbero impedito di realizzare il suo programma al tempo del primo mandato) e contro i RINO (l’acronimo di Republicans in name only, cioè repubblicani solo di nome). Ma non si può mai dire. Trump ha sempre stupito con la sua imprevedibilità. Il taglio del suo discorso sarà, comunque, indicativo dell’atteggiamento che The Donald vorrà adottare durante la sua seconda presidenza.
















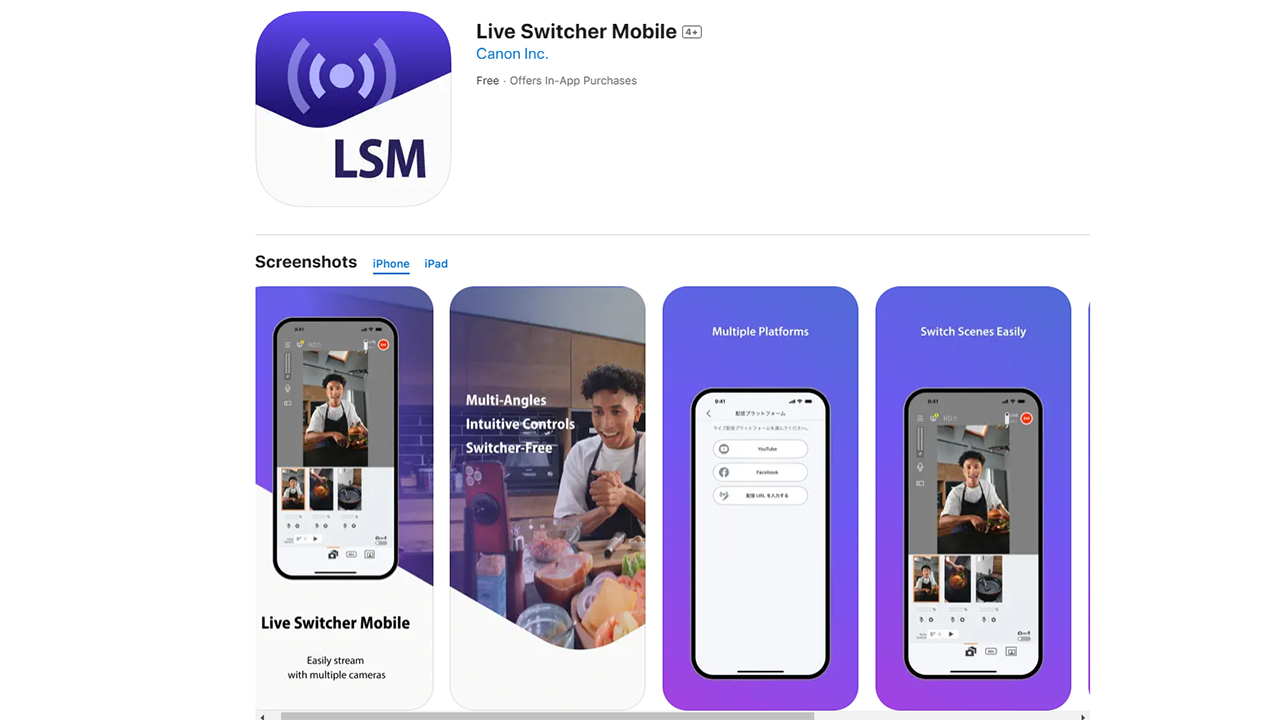

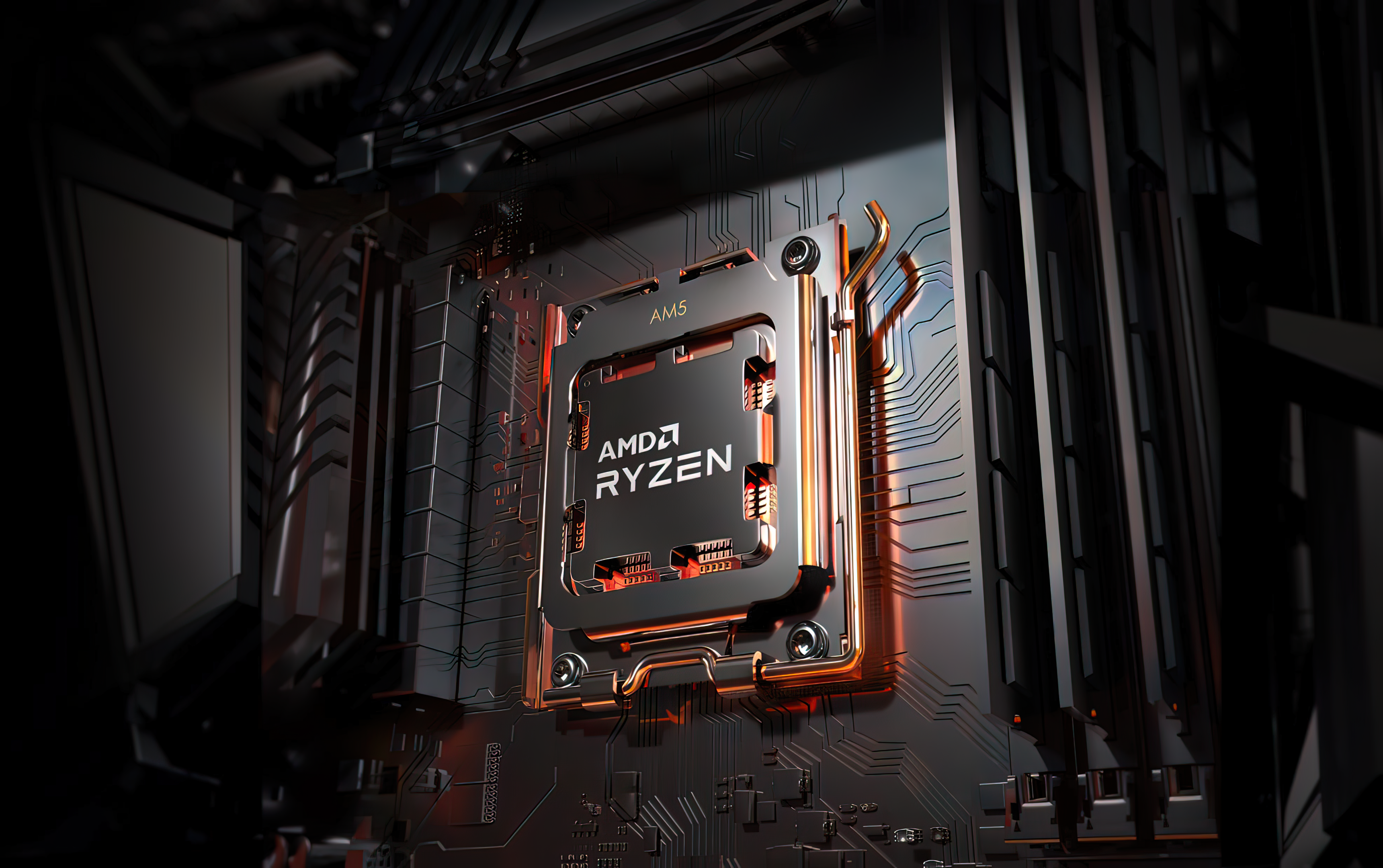




























.jpg?#)







