Pietro I, l’architetto della Russia imperiale
Pietro (Pëtr) il Grande, o Pietro I, zar della Russia per almeno una trentina d’anni dalla fine del XVII all’inizio del XVIII secolo, fu un innovatore ambizioso in grado di guardare oltre il suo tempo, e insieme uomo calato nella cultura del potere della sua epoca. La sua figura continua ancora oggi a suscitare intensi dibattiti e accese discussioni.La sua morte, trecento anni fa, segnò l’epilogo di un periodo tumultuoso di trasformazioni, lasciando nel libro della storia russa un capitolo ricco, complesso e contraddittorio. Lo storico inglese Roger Bartlett ha scritto che il regime di Pietro I prefigurò alcuni tratti del cosiddetto assolutismo illuminato, introducendo una variante statalista del primo illuminismo e spingendo con «metodi polizieschi» la società russa a mutare, attraverso una serie inedita di riforme di ampio respiro. Con lui la vecchia Russia cessò di esistere.Alla ricerca di un’identitàPietro nacque nel 1672 a Mosca, il fulcro urbano dello zarismo, in una fase di transizione anche culturale. La nobiltà russa, di fronte a molteplici difficoltà interne e internazionali, si trovava infatti in bilico tra due poli: quello del tradizionalismo intellettuale e dell’ortodossia religiosa e quello dello slancio verso nuove forme di governo. Suo padre Aleksej Romanov morì quando Pietro aveva quattro anni. Essendo Pietro il figlio di Natalya Kirillovna Naryshkina, la seconda moglie del defunto Aleksej, la carica di zar passò al fratellastro Fëdor (Fëdor III), sostenuto dai parenti della prima zarina Marija Il'inična: la fazione dei Miloslavskij. Quando tuttavia Fëdor morì senza eredi, nel 1682, iniziò un conflitto. I Miloslavskij volevano come zar l’altro figlio di Aleksej, Ivan, peraltro di salute precaria, i Naryškin appoggiavano invece Pietro, un bambino curioso e vivace. La crisi sfociò in forti tensioni e anche in una rivolta armata degli strelizzi, le guardie zariste. I Naryškin subirono molte perdite. Si giunse infine a un compromesso: Ivan e Pietro vennero proclamati zar congiunti (Ivan III e Pietro I), e Sofia (sorellastra di Pietro nonché prima donna a regnare) assunse la reggenza.Pietro visse con la madre a Preobraženskoe, nell’area moscovita, lontano dal palazzo. Questo isolamento lo espose a influenze inusuali: non ricevette un’istruzione classica, ma conobbe mercanti e viaggiatori stranieri ed entrò in contatto con usi e approcci europei, allora distinti dalle consuetudini russe. Alto quasi due metri, robusto e con tratti fisici peculiari, come il volto piuttosto allungato, il giovane Pietro si appassionò presto alle armi e alla navigazione. Le turbolenze dell’infanzia e l’educazione non convenzionale lasciarono in lui un’impronta duratura, spingendolo a diffidare della vecchia élite moscovita. Pur non potendo essere definito un outsider, per estrazione sociale e familiare, il percorso di formazione di Pietro fu comunque peculiare, con un’attenzione specifica verso correnti di pensiero tendenti al razionalismo e al pluralismo culturale. Quando gli si presentò l’occasione di consolidare la sua posizione sul trono, non esitò.Verso il potereNel 1689, temendo che Sofia stesse cospirando contro di lui, Pietro reagì. Si ritirò Il monastero della Trinità di San Sergio, a nord di Mosca, radunò truppe a lui fedeli e destituì la sorellastra. Ivan V rimase nominalmente zar, ma il governo reale passò nelle mani di Pietro e della madre, Natalya. Alla scomparsa di quest'ultima, nel 1694, Pietro divenne il protagonista assoluto. Dopo aver avviato progetti militari e navali su larga scala, condusse due campagne armate contro la fortezza ottomana di Azov per garantirsi uno sbocco sul mar Nero. Nel 1696, con la morte prematura del fratellastro, rimase l’unico sovrano in carica. Su questa scia, intraprese un lungo viaggio passando per la Prussia, l’Olanda, l’Inghilterra e l’Austria e celando inizialmente la sua identità. L’esperienza gli diede l'opportunità di scoprire e studiare i processi di modernizzazione diffusi in Europa: dalle tecniche militari alla tecnologia navale, fino alle prassi burocratiche e ai primi avanzamenti industriali.Il suo soggiorno fu interrotto nel 1698 da un nuovo sommovimento degli strelizzi, che lo costrinse a tornare precipitosamente a Mosca per prendere in mano le redini dello stato. Una volta scacciato il pericolo della sedizione, gli strelizzi furono decimati con una repressione feroce e Pietro pianificò e ordinò l’attuazione di una serie incisiva di riforme. La sua visione sulla Russia dell’avvenire generò subito resistenze e ritrosie, ma questo non lo bloccò. In quel periodo decise addirittura di allontanare dalla corte la moglie, la nobile Eudokia Lopukhina, contraria alla sua politica e ormai in rotta di collisione con lui. Approfondendo linee direttrici già tracciate, Pietro puntò dritto verso un rifacimento completo della struttura dello stato.Contro il passato per costruire il futuroGli ambasciatori di Pietro cominciarono a vestirsi con abiti europei, i suoi sudditi fu

Pietro (Pëtr) il Grande, o Pietro I, zar della Russia per almeno una trentina d’anni dalla fine del XVII all’inizio del XVIII secolo, fu un innovatore ambizioso in grado di guardare oltre il suo tempo, e insieme uomo calato nella cultura del potere della sua epoca. La sua figura continua ancora oggi a suscitare intensi dibattiti e accese discussioni.
La sua morte, trecento anni fa, segnò l’epilogo di un periodo tumultuoso di trasformazioni, lasciando nel libro della storia russa un capitolo ricco, complesso e contraddittorio. Lo storico inglese Roger Bartlett ha scritto che il regime di Pietro I prefigurò alcuni tratti del cosiddetto assolutismo illuminato, introducendo una variante statalista del primo illuminismo e spingendo con «metodi polizieschi» la società russa a mutare, attraverso una serie inedita di riforme di ampio respiro. Con lui la vecchia Russia cessò di esistere.
Alla ricerca di un’identità
Pietro nacque nel 1672 a Mosca, il fulcro urbano dello zarismo, in una fase di transizione anche culturale. La nobiltà russa, di fronte a molteplici difficoltà interne e internazionali, si trovava infatti in bilico tra due poli: quello del tradizionalismo intellettuale e dell’ortodossia religiosa e quello dello slancio verso nuove forme di governo. Suo padre Aleksej Romanov morì quando Pietro aveva quattro anni. Essendo Pietro il figlio di Natalya Kirillovna Naryshkina, la seconda moglie del defunto Aleksej, la carica di zar passò al fratellastro Fëdor (Fëdor III), sostenuto dai parenti della prima zarina Marija Il'inična: la fazione dei Miloslavskij. Quando tuttavia Fëdor morì senza eredi, nel 1682, iniziò un conflitto. I Miloslavskij volevano come zar l’altro figlio di Aleksej, Ivan, peraltro di salute precaria, i Naryškin appoggiavano invece Pietro, un bambino curioso e vivace. La crisi sfociò in forti tensioni e anche in una rivolta armata degli strelizzi, le guardie zariste. I Naryškin subirono molte perdite. Si giunse infine a un compromesso: Ivan e Pietro vennero proclamati zar congiunti (Ivan III e Pietro I), e Sofia (sorellastra di Pietro nonché prima donna a regnare) assunse la reggenza.
Pietro visse con la madre a Preobraženskoe, nell’area moscovita, lontano dal palazzo. Questo isolamento lo espose a influenze inusuali: non ricevette un’istruzione classica, ma conobbe mercanti e viaggiatori stranieri ed entrò in contatto con usi e approcci europei, allora distinti dalle consuetudini russe. Alto quasi due metri, robusto e con tratti fisici peculiari, come il volto piuttosto allungato, il giovane Pietro si appassionò presto alle armi e alla navigazione. Le turbolenze dell’infanzia e l’educazione non convenzionale lasciarono in lui un’impronta duratura, spingendolo a diffidare della vecchia élite moscovita. Pur non potendo essere definito un outsider, per estrazione sociale e familiare, il percorso di formazione di Pietro fu comunque peculiare, con un’attenzione specifica verso correnti di pensiero tendenti al razionalismo e al pluralismo culturale. Quando gli si presentò l’occasione di consolidare la sua posizione sul trono, non esitò.
Verso il potere
Nel 1689, temendo che Sofia stesse cospirando contro di lui, Pietro reagì. Si ritirò Il monastero della Trinità di San Sergio, a nord di Mosca, radunò truppe a lui fedeli e destituì la sorellastra. Ivan V rimase nominalmente zar, ma il governo reale passò nelle mani di Pietro e della madre, Natalya. Alla scomparsa di quest'ultima, nel 1694, Pietro divenne il protagonista assoluto. Dopo aver avviato progetti militari e navali su larga scala, condusse due campagne armate contro la fortezza ottomana di Azov per garantirsi uno sbocco sul mar Nero. Nel 1696, con la morte prematura del fratellastro, rimase l’unico sovrano in carica. Su questa scia, intraprese un lungo viaggio passando per la Prussia, l’Olanda, l’Inghilterra e l’Austria e celando inizialmente la sua identità. L’esperienza gli diede l'opportunità di scoprire e studiare i processi di modernizzazione diffusi in Europa: dalle tecniche militari alla tecnologia navale, fino alle prassi burocratiche e ai primi avanzamenti industriali.
Il suo soggiorno fu interrotto nel 1698 da un nuovo sommovimento degli strelizzi, che lo costrinse a tornare precipitosamente a Mosca per prendere in mano le redini dello stato. Una volta scacciato il pericolo della sedizione, gli strelizzi furono decimati con una repressione feroce e Pietro pianificò e ordinò l’attuazione di una serie incisiva di riforme. La sua visione sulla Russia dell’avvenire generò subito resistenze e ritrosie, ma questo non lo bloccò. In quel periodo decise addirittura di allontanare dalla corte la moglie, la nobile Eudokia Lopukhina, contraria alla sua politica e ormai in rotta di collisione con lui. Approfondendo linee direttrici già tracciate, Pietro puntò dritto verso un rifacimento completo della struttura dello stato.
Contro il passato per costruire il futuro
Gli ambasciatori di Pietro cominciarono a vestirsi con abiti europei, i suoi sudditi furono fortemente sollecitati o addirittura obbligati a tagliarsi la caratteristica barba russa, e tutta la società fu investita dalla volontà di Pietro di accelerare il cambiamento. Fu sotto di lui, per esempio, che venne introdotto il calendario giuliano (abbandonato solo duecento anni più tardi). Pietro lavorò per modificare il sistema fiscale e monetario, aggiornare i modelli d’istruzione e riorganizzare in modo metodico l’amministrazione centrale e locale. Venne avviato un piano di efficientamento dell’esercito e di potenziamento della flotta, così come massicci interventi economici sulla base delle dottrine mercantiliste, nel tentativo di accrescere la ricchezza russa. Dopo aver stretto alleanze e sodalizi, in particolare con i regni dell’Europa del nord, come Danimarca e Norvegia, Pietro dichiarò guerra alla Svezia nel 1700 per ottenere il controllo del mar Baltico, acquisendo infine, dopo repentine battute d’arresto, territori nel nord-est dell’Europa. Combatté poi contro l’impero ottomano e rafforzò il ruolo del Paese. La sua flotta divenne una delle più conosciute del mondo.
Fu sotto il dominio di Pietro che il concetto di progresso, già utilizzato altrove, si diffuse anche in Russia. La creazione di una nuova capitale, San Pietroburgo, su un terreno paludoso al confine con l’Europa, fu una delle sue più splendide e controverse realizzazioni. La città venne ufficialmente fondata nel 1703, per poi diventare capitale della Russia nel 1712, al posto di Mosca. Fu progressivamente costruita traendo ispirazione dall’architettura dei Paesi Bassi, con il supporto di un team di esperti non russi, tra cui alcuni di scuola italiana, e l’impiego di una grandissima quantità di servi della gleba e manovali specializzati. Negli anni, a causa dei problemi logistici, delle dure condizioni di lavoro e del clima rigido, ci furono migliaia di morti, anche se la città divenne ciò che Pietro aveva sperato che fosse: la rappresentazione plastica, e monumentale, della rottura con il passato. Il simbolo di una Russia proiettata verso il futuro.
Il dilemma di un potere senza confini
La spinta impressa al Paese portò a un’escalation di conflitti interni. Il desiderio dello zar di rendere la Russia una potenza in grado di confrontarsi con le grandi nazioni europee dell’Età moderna, allora in via di consolidamento, fu inedito e vigoroso, ma il suo regno fu segnato anche da scelte drastiche. Pietro non fu affatto un riformatore pacato, né un sovrano alla ricerca di qualcosa di simile al consenso. Gli apparati pubblici di sicurezza e repressione non lasciarono spazio alla libertà d’opinione. Per la sua personalità a volte irruenta, talvolta caratterizzata da un senso di focosa urgenza, moltissimi russi videro in lui ciò che avevano visto nei suoi predecessori: un oppressore. E anche la sua corte finì per tramutarsi in un meccanismo ben oliato che rispondeva a un’unica voce, la sua.
La relazione tra lo stato e la Chiesa ortodossa, da sempre assai delicata, fu poco meno di una lotta estenuante per concludere il processo di centralizzazione del potere, subordinando quello ecclesiastico a quello statuale. Pietro abolì il patriarcato per fondare, nel 1721, il Santo Sinodo, un concilio di dieci ecclesiastici. Nello stesso anno fu incoronato imperatore a fianco della seconda moglie, Caterina, completando la sua ascesa politica ma suscitando timori tra la nobiltà russa e sospetti tra i regnanti d’Europa.
Non perderti nessun articolo! Iscriviti alla newsletter settimanale di Storica!
Un’eredità secolare
Pietro – più tardi conosciuto come il Grande – morì nel 1725 a cinquantadue anni a causa da un’infezione, lasciando una Russia radicalmente evoluta. La sua eredità fu ambigua. Gli sopravvisse infatti una società segnata dalle divisioni e dalle disuguaglianze sociali, malgrado l’ulteriore impulso riformatore impresso più tardi da un’altra figura di spicco della storia russa, Caterina la Grande. Alla fine, la Russia pietrina si rivelò un organismo instabile, una grande mosaico che i successori di Pietro, pur cercando di proseguire nel suo solco, non riuscirono ad armonizzare.
Roger Bartlett, tracciando un bilancio, ha osservato: «Molte istituzioni e riforme petrine rimasero incomplete, imperfette o inefficaci, ma in quasi tutti i campi il sovrano pose le fondamenta per una struttura imperiale dello stato e della vita pubblica che, con ulteriori aggiustamenti, supportò lo status di grande potenza della Russia, durando fino al XIX secolo e, in alcuni casi, fino al 1917». L’anno in cui la secolare dinastia dei Romanov venne sommersa dal retaggio della guerra, dalla richiesta di nuove libertà e dall’inedita forza d’attrazione dell'esperimento bolscevico.
Se vuoi ricevere la nostra newsletter settimanale, iscriviti subito!



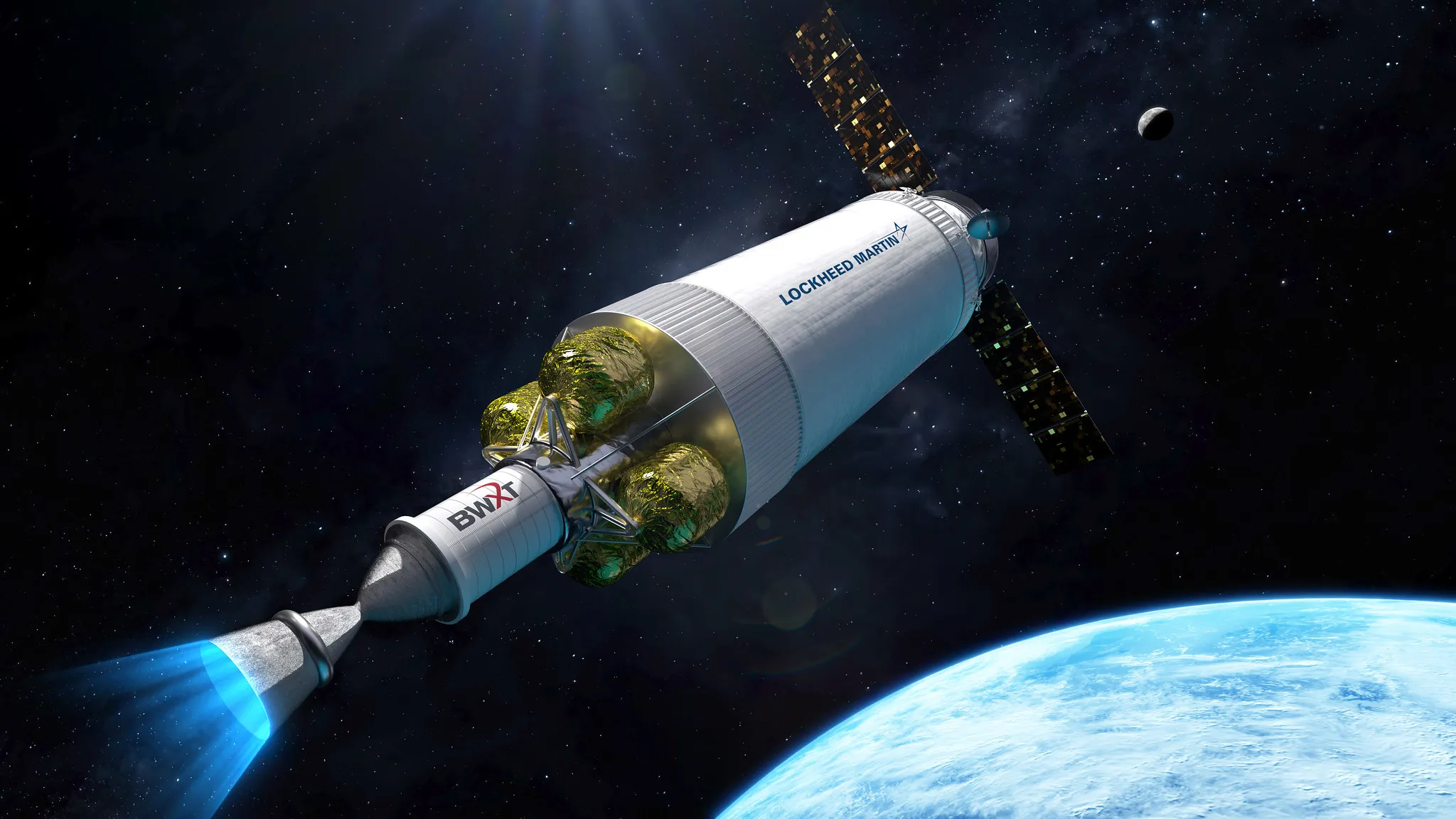
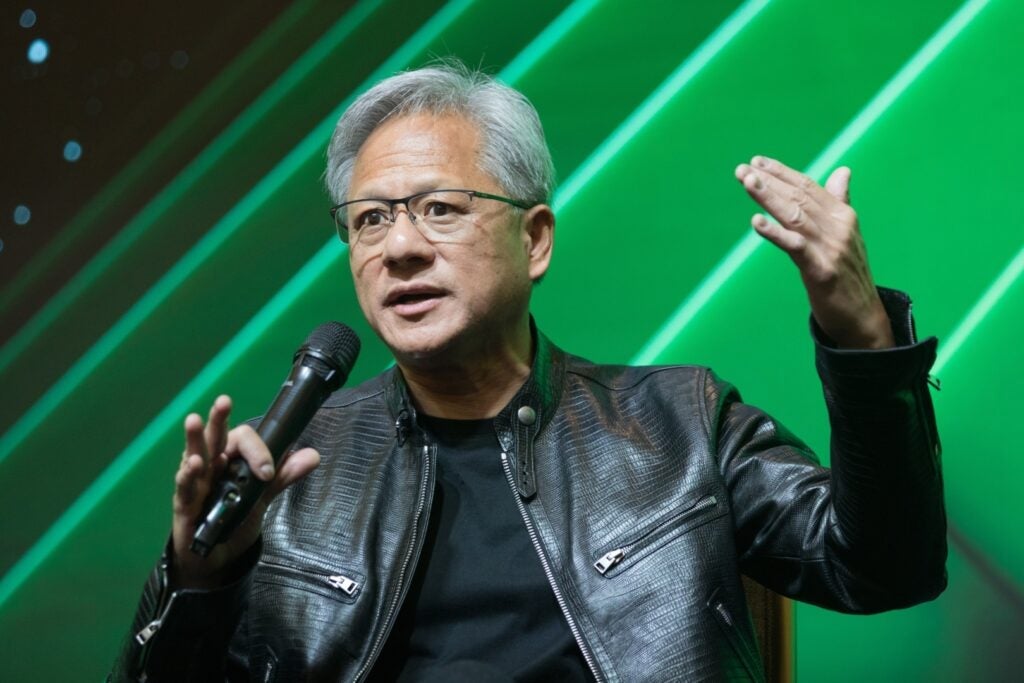








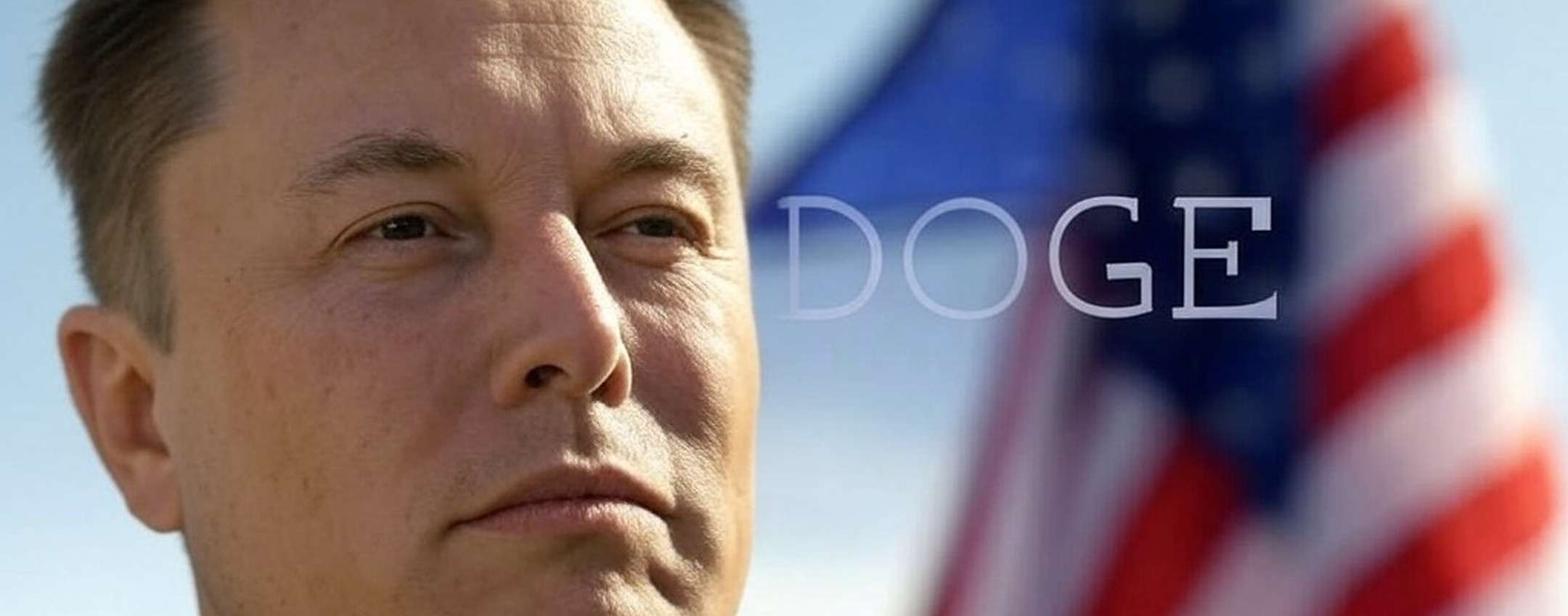































/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/08/4095630-83050264-310-310.jpg)







