Perché il Canada non sarà mai il 51° Stato americano
Trump intende (ri)creare un impero americano e vuole che il Canada ne faccia parte come 51esimo stato. Ecco perché non succederà. L'analisi di Gian Marco Litrico.

Trump intende (ri)creare un impero americano e vuole che il Canada ne faccia parte come 51esimo stato. Ecco perché non succederà. L’analisi di Gian Marco Litrico
“La geografia ci ha resi vicini, la storia ci ha resi amici, l’economia ci ha resi partner e la necessità ci ha resi alleati. Nessun uomo separi coloro che la Natura ha così unito insieme. Siamo alleati, questa è una partnership, non un impero. Siamo destinati ad avere differenze e delusioni, e siamo ugualmente tenuti a portarle allo scoperto, a risolverle quando possono essere risolte e a rispettare le reciproche opinioni quando non possono essere risolte. Ciò che ci unisce è molto più grande di ciò che ci divide.”
Era il 17 maggio del 1961 quando il 35esimo presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, in visita ufficiale in Canada, pronunciò queste parole davanti al Parlamento di Ottawa.
C’è un uomo, il 47esimo inquilino alla Casa Bianca, che ha stravolto questo messaggio. Donald Trump. Si è messo in testa di (ri)creare un impero americano e vuole che il Canada ne faccia parte come 51esimo stato. Per raggiungere questo obiettivo è pronto a usare la “forza economica” dell’America.
La cattiva notizia per il mondo è che l’approccio all-business di The Donald, dove tutto diventa un’opportunità per ottenere benefici immediati e tangibili per sé stesso, il movimento MAGA e gli Stati Uniti, approccio che le anime belle si sforzano di definire come “transazionale”, si è “evoluto” in una visione imperiale di lungo termine, brutalmente predatoria e sostenuta dalla potenza della tecnostruttura digitale americana.
Il comico John Mulaney, americano, al Saturday Night Show ha provato a scherzarci su, come hanno fatto in tanti sui due lati del confine: “Trump pensa che il Canada dovrebbe essere il 51° stato. È come dire che una biblioteca dovrebbe diventare parte di una discoteca”.
Certo è che la “discoteca” America mostra un dinamismo economico che la “libreria” Canada non può nemmeno avvicinare.
Un differenziale che non è solo nelle dimensioni delle due economie (quella di Washington cuba 13 volte quella di Ottawa), ma anche nel loro tasso di crescita (+1% il PIL canadese nel 2024, +3,2% quello americano) e nel rendimento dei mercati finanziari, con lo S&P500 che vale 32 trilioni di dollari e nell’ultimo decennio ha reso il 10,7% all’anno, mentre il Toronto Stock Exchange (TSX) Composite non arriva a 3 trilioni e ha prodotto un esangue ROI del 2,1%. Per non parlare delle due valute, con il dollaro di Ottawa sotto la soglia dei 70 centesimi rispetto al biglietto verde.
L’idea di una fusione fra USA e Canada, in realtà, precede Trump. Fu discussa brevemente e accantonata in fretta durante la Grande Depressione e la Seconda Guerra Mondiale. Qualcuno oggi prova a riproporla in termini di unione economica, sul modello della UE: libertà di movimento per merci, servizi e persone, welfare e fiscalità nazionale, con una moneta unica o un passaporto unico.
Claude Lavoie, ex-direttore dell’ufficio studi economici del Ministero delle Finanze a Ottawa, per esempio, ha sostenuto sul Globe and Mail che un’unione economica tra USA e Canada non sarebbe una cattiva idea, perché la perdita della sovranità monetaria verrebbe compensata da una crescita economica più spinta, citando a supporto il dato del +9% medio del PIL nazionale dei Paesi che hanno aderito alla Unione Europea.
Lavoie dimentica di spiegare come questa moneta unica potrebbe prendere vita, visto che gli Europei hanno aderito all’unione monetaria nel segno di una moneta nuova di zecca, l’Euro, mentre è chiaro che gli Americani non potrebbero mai rinunciare al loro dollaro. O accettare una nuova valuta chiamata Amero, come propose un economista canadese, Herber Grubel, più di 25 anni fa.
Nel frattempo, non passa giorno senza che Trump non provi a rifilare ai Canadesi le sue balle spaziali su quanto sarebbe bello per loro diventare il 51esimo Stato americano: niente dazi, una migliore sanità, meno tasse, niente preoccupazioni per la Difesa cui penserebbe Zio Sam. Secondo un sondaggio di Leger, “solo” il 13% dei canadesi è affascinato dall’idea, ma la percentuale sale al 30% tra gli under 40, a digiuno di storia e forse abbagliati dai numeri di una AmCan Fortress con 380 milioni di abitanti e un PIL superiore a 28 trilioni di USD.
Chi invece la storia l’ha studiata sa che le relazioni politiche tra gli Stati Uniti e il Canada sono state fisiologicamente ambivalenti. Improntate alla cooperazione, ma cariche anche di una tensione costante.
I discendenti dei commercianti in pelli della Nuova Francia e dei coloni britannici, numericamente rimpolpati dai lealisti inglesi scampati alla Rivoluzione Americana e dagli Irlandesi sfuggiti alla Grande Carestia, diedero vita al Canada anche per mettere un freno alle mire espansionistiche statunitensi, forgiando la loro identità nazionale per contrapposizione rispetto a quella americana.
Una differenza che si riflette nell’ordinamento giuridico di Ottawa, modellato su quello di Westminster: una democrazia parlamentare in cui il monarca britannico, rappresentato dal Governatore Generale, svolge la funzione di capo di stato cerimoniale (ancora oggi, il faccione di Carlo campeggia sui muri degli aeroporti e degli uffici pubblici).
Due distinti Paesi, dunque, uno nato dalla ribellione alla madrepatria inglese, l’altro governato a lungo da Londra. L’ultimo confronto armato risale al 1812, quando le scorribande americane a nord del confine furono respinte, e una controffensiva canadese portò all’incendio della Casa Bianca.
L’idea che il Canada potesse, anzi dovesse, diventare parte degli Stati Uniti è però rimasta come un pensiero inconfessabile che, di tanto in tanto, riaffiora, soprattutto tra i Repubblicani.
Nel 1845, in un articolo pubblicato sulla rivista The United States Magazine and Democratic Review, il giornalista John O’Sullivan sostenne che gli Stati Uniti avessero la missione storica di espandersi attraverso il Nord America, esportando la loro idea di democrazia e progresso.
L’America era nel pieno di questo processo di espansione, perseguito con le buone o con le cattive e cominciato con l’acquisto della Louisiana, che nel 1803 aveva raddoppiato la superficie federale. In tempi in cui il muro lo costruivano i Messicani per tener fuori i coloni americani, è con le armi che l’America realizzò l’annessione del Texas e l’acquisizione di gran parte del sud-ovest americano, inclusa la California, mentre alla definizione del confine di nord-ovest tra gli Stati Uniti e il Canada si arrivò con un trattato.
William Seward, il Segretario di Stato americano che comprò l’Alaska dai Russi, in un discorso del 1860 immaginò un futuro in cui gli Stati Uniti avrebbero potuto estendersi su tutto il continente, comprese le regioni a nord come il Canada.
Durante la Guerra di Secessione, però, Seward diede la priorità al mantenimento di relazioni cordiali con la Gran Bretagna, che governava i territori coloniali che sarebbero diventati il Canada, per evitare che Londra si schierasse con i Sudisti. Una posizione diplomatica che servì a mitigare le ambizioni espansionistiche di Washington verso nord.
L’ unificazione del Canada arrivò a compimento nel 1867. Inglesi e Americani si misero d’accordo per ritagliare il confine tra i due Paesi (la linea artificiale e arbitraria di cui parla Trump) seguendo il 49º parallelo parallelo fino alle Montagne Rocciose. A ovest, ci vollero 10 anni per trovare un compromesso: Londra mollò terre a sud della linea di demarcazione, mentre Washington rinunciò alle pretese a nord.
Come dominion autonomo dell’Impero britannico, il Canada fu automaticamente coinvolto nel primo conflitto mondiale quando la Gran Bretagna dichiarò guerra alla Germania nell’agosto del 1914. Un profondo senso di lealtà verso Londra alimentò l’ampio sostegno pubblico per lo sforzo bellico, visto come uno strumento per difendere i valori democratici e dimostrare le capacità del Canada sulla scena internazionale.
Durante la Grande Depressione, l’idea di una federazione economica tra Stati Uniti e Canada per favorire il commercio e la stabilità economica venne discussa da alcuni economisti e gruppi d’affari, mentre nel 1940 un articolo pubblicato sulla rivista americana Saturday Night suggerì una fusione tra Canada e Stati Uniti per rafforzare la difesa del continente nordamericano.
La seconda guerra mondiale rafforzò i legami economici, culturali e militari tra le due nazioni e l’ex-madrepatria inglese, legate da un patto di sangue dalle spiaggie della Normandia alla risalita lungo la penisola nella liberazione dell’Italia.
La partecipazione condivisa nella NATO nel 1949 e la creazione nel 1958 del NORAD, il sistema integrato di difesa dello spazio aereo nordamericano, cementarono ulteriormente le relazioni USA-Canada durante la Guerra Fredda.
Dopo il crollo del Muro, quello della difesa comune è un fattore che Canadesi ed Europei hanno troppo a lungo trascurato, e fornisce l’alibi più forte a Trump per mettere sotto pressione gli alleati.
“Ottawa – per Konrad Yakabuski sul Globe and Mail – sta pagando ora il prezzo di essere andata a scrocco dell’America in materia di Difesa. Se Trudeau avesse contribuito alle spese della NATO con quel 2% del PIL che Trump aveva chiesto durante il suo primo mandato, oggi il Canada non avrebbe davanti a sé una minaccia esistenziale per la sua economia, se non addirittura per la sua sovranità”. A Davos, peraltro, il pizzo per la protezione americana è salito al 5% del PIL, cioè ai livelli della Guerra Fredda.
Ma torniamo alla cronaca di queste settimane di preparazione alla guerra economica tra i due vicini.
Quando minaccia di applicare un dazio universale del 25% sulle importazioni dal Canada, Donald Trump mette le mani in un sistema di relazioni economiche da 2 miliardi di dollati al giorno, tra due dei Paesi più interdipendenti al mondo.
Nei meandri di quell’intreccio, Ottawa ha messo a punto il pacchetto di contromisure che servono a colpire l’economia americana dove fa più male.
A cominciare dall’energia: l’America paga una bolletta, superscontata, da 100 billion all’anno per comprare dal Canada il 60% del greggio pesante di cui ha bisogno, oltre all’energia elettrica per una mezza dozzina di Stati, incluso lo Stato di New York (ve li immaginate gli inquilini della Trump Tower costretti a usare le candele perché il Quebec ha tagliato la luce?).
Sono fortemente interdipendenti l’automotive (Crysler e Ford producono in Ontario da 100 anni e trovano in Canada un mercato vicino e generoso grazie ai sussidi provinciali e federali), l’agricoltura (i farmer americani prendono dal Canada il 80% del potassio solubile, uno dei 3 ingredienti indispensabili per coltivare) e i settori industriali dell’acciaio e dell’alluminio: il Canada li esporta negli USA, ma poi importa i pick-up della Ford o gli aerei della Boeing. Il turismo crea un surplus da 15 billion a beneficio degli USA grazie ai pensionati canadesi che svernano in Florida e in Arizona. L’edilizia USA si basa sull’importazione di legname canadese, mentre le aziende high-tech e della Difesa comprano minerali critici dal Canada per 40 billion all’anno, inclusi uranio, rame e litio.
Per non parlare dell’oro blu: California, Nevada e Arizona, ma anche diversi stati del Mid-West con crescenti problemi di siccità hanno espresso un interesse crescente per l’importazione di acqua dolce dal Canada, che detiene il 20% delle riserve mondiali.
Anche sul Digitale si può, o dovrà, negoziare: Ottawa tassa a volume, penalizzandoli, i colossi del web Made in USA, mentre mantiene quote a protezione dei contenuti nazionali, incluse le news. Ma è anche obbligata a cooperare con l’America nell’Intelligenza Artificiale, nonostante le competenze scientifiche di prim’ordine, come dimostra il Nobel 2024 al canadese Geoffrey Hinton.
Su questo sistema di relazioni, che alla fine creano un surplus commerciale per il Canada da 40 miliardi di dollari, il più piccolo per Washington dopo quello con la Francia (l’Italia, per intenderci, arriva a 44 miliardi), Trump vuole immergere non il bisturi, ma un martello pneumatico.
Trudeau, da primo ministro uscente, si è dichiarato pronto ad applicare dazi di ritorsione “dollar for dollar”. Sulla stessa lunghezza d’onda si trovano anche Pierre Poilievre, leader dei Conservatori, e Mark Carney, l’ex governatore della Banca del Canada e della Banca d’Inghilterra, in corsa per la guida del Partito Liberale in vista delle elezioni federali di marzo.
Nonostante l’integrazione le due economie sia fortissima (fino a Trump, c’erano più barriere doganali tra le province canadesi che tra il Canada e l’America) il rischio che i rapporti di buon vicinato possano subire danni generazionali è molto concreto. Con buona pace di Winston Churchill che considerava il confine che oggi Trump vorrebbe cancellare come un modello per il mondo, “sorvegliato solo dal rispetto del vicinato e dagli obblighi onorevoli”.
Questo, peraltro, è uno dei casi in cui la Scienza Triste deve cedere il passo alla Sovrastruttura. “Noi non siamo americani” è il mantra su cui il Paese della Foglia d’Acero ha costruito la sua identità nazionale. Un inno collettivo mormorato sommessamente dai comuni cittadini di qualsiasi orientamento politico. Dai politici. Dagli intellettuali. A casa, all’estero.
Canadesi e Americani sono vicini, ma anche irrimediabilmente diversi. “Parliamo la stessa lingua, guidiamo le stesse auto, abitiamo nelle stesse case e guardiamo la stessa TV”, ammettono, ma “siamo il vicino educato dell’America, non il suo 51° stato”, come ha riepilogato per tutti l’attore Ryan Reynolds.
“Condividiamo il continente, ma non l’anima”, rincara la dose lo storico canadese Michael Bliss. O le anime, visto che il Canada ne ha almeno due dalla nascita. Quella inglese e quella Francese. Due anime in un conflitto più o meno aperto, ma che si è diluito, a partire dagli anni ’70, nel modello multiculturale del “mosaico” e della comunità, contrapposto all’ethos americano dell’individualismo e del “melting pot”.
L’artefice principale di questa trasformazione fu Pierre Trudeau, il carismatico e controverso primo ministro canadese dal 1968 al 1984, padre dell’attuale premier Justin Trudeau. Il sospetto, fondato, è che Trudeau padre abbia abbracciato il multiculturalismo per opportunismo politico, con l’obiettivo di catalizzare i voti della popolazione “naturalizzata” come antidoto contro il nazionalismo e il predominio delle “due solitudini” del Paese.
La verità è che nella sua giovane storia il Canada è stato attraversato da una sequenza di ondate migratorie “a progetto”, attivate come strumento delle politiche economiche federali.
All’inizio si trattò di una sorta di “autocolonizzazione”, e quindi di un processo storico irripetibile. Così è stato, per esempio, durante l’infanzia della Nazione, per i 10mila immigrati cinesi che hanno costruito la ferrovia da est a ovest, per le centinaia di migliaia di immigrati tedeschi ed est-europei arrivati per dissodare le Grandi Praterie e per gli Italiani sbarcati a Toronto per costruire le sue infrastrutture civili.
L’ondata migratoria attualmente in corso, iniziata alla fine degli anni ’50, ha portato alla ribalta le “minoranze visibili” provenienti dall’India, dal sud-est asiatico e, di nuovo e più massicciamente, dalla Cina, ed è servita a stimolare la piccola impresa e l’industria informatica, ma anche a garantire la manodopera necessaria nell’agricoltura, nell’edilizia, nella Sanità in un Paese che ha di fronte una enorme crisi demografica.
Trudeau figlio ha fatto propria e potenziato la visione paterna, trasformandola, secondo i critici conservatori, in un wokeismo dogmatico che ha finito per creare un fenomeno di rigetto nell’opinione pubblica. Secondo iI National Post, anzi, “la visione post-nazionalista del primo ministro e la sua fede cieca nella diversity e nei valori condivisi, non è servita a fare del Canada una società più pacifica e pluralistica». Insomma, a forza di scusarsi per il passato, con i suoi ripetuti richiami al genocidio degli Aborigeni e alla loro “occidentalizzazione” forzata nelle vecchie residential schools cristiane, o al razzismo «sistemico» dei casi di arresti arbitrari operati dalla polizia federale, Trudeau è arrivato nei fatti, se non nelle intenzioni, a negare l’eccezionalismo canadese, ovvero la reputazione storica di una nazione aperta e multiculturale.
Che peraltro ha dimostrato spesso il suo impegno per un approccio multilaterale e indipendente dagli americani negli affari globali. Un gentile promemoria a Trump, da anziano ad anziano, come ha messo lui stesso in risalto, lo ha recapitato Jean Chrètien, primo ministro liberale tra il ’93 e il 2003, con una lettera aperta sul Globe and Mail. “Forse non sai che quando si è trattato di battersi per la libertà in due Guerre Mondiali, in entrambi i casi ci siamo arruolati anni prima di voi americani. E abbiamo avuto il fegato di dirvi di no quando avete cercato di coinvolgerci in una guerra ingiusta come quella in Iraq”.
Nel tempo il Canada si è inventato una soluzione pacifica per la crisi di Suez, dando vita alla prima missione di peace-keeping su larga scala delle Nazioni Unite, ha aperto alla Cina con anni di anticipo rispetto all’America di Nixon, ha ignorare l’embargo americano a Cuba, mantenendo relazioni diplomatiche e commerciali con L’Avana. Durante la guerra del Vietnam, migliaia di renitenti alla leva americani trovarono un rifugio a nord del confine.
Chrètien lo ha detto con grande lucidità: “Abbiamo già affrontato una minaccia esistenziale alla integrità territoriale del Canada col il separatismo del Quebec. E lo abbiamo fatto rendendo il Canada ancora più unito e sempre più fiero dei suoi valori”.
Nonostante i problemi del Paese, peraltro simili a quelli della maggior parte dei Paesi occidentali (su tutti, costo della vita, crisi della casa e disoccupazione) i Canadesi restano fieri delle loro reti di sicurezza sociale, del servizio sanitario universale, del loro sistema educativo, delle leggi restrittive sulle armi e, soprattutto, al di là degli errori commessi da Trudeau in materia di immigrazione, del loro modello di accoglienza.
Lo storico Pierre Berton ha detto che “un canadese è un tizio che sa come fare l’amore in canoa, senza ribaltarla”. In fondo, parte del gran parlare delle relazioni Canada-Stati Uniti di queste ultime settimane, è racchiuso in una boutade vecchia di 50 anni.
La canoa è l’icona romantica che sussurra di vita all’aria aperta e dei Primi Popoli che queste terre hanno abitato prima del Contatto con gli Europei, usandola su innumerevoli, incontaminate vie d’acqua per muoversi. Che la canoa-alcova non si ribalti, però, dipende dal bilanciamento, dall’equilibrio, dalla flemma che i Canadesi amano credere di aver ereditato dagli Inglesi.
Nella metafora c’è anche un riflesso dell’affettuoso, gentile anti-americanismo dei canadesi. Nel 1969, Trudeau padre rese bene l’idea: “Vivere accanto agli USA è come dormire con un elefante. Non importa quanto amichevole ed equilibrata sia la bestia, ogni minimo movimento, ogni grugnito finirà per colpirti”. Figuriamoci ora che la bestia non è certamente “amichevole ed equilibrata”.











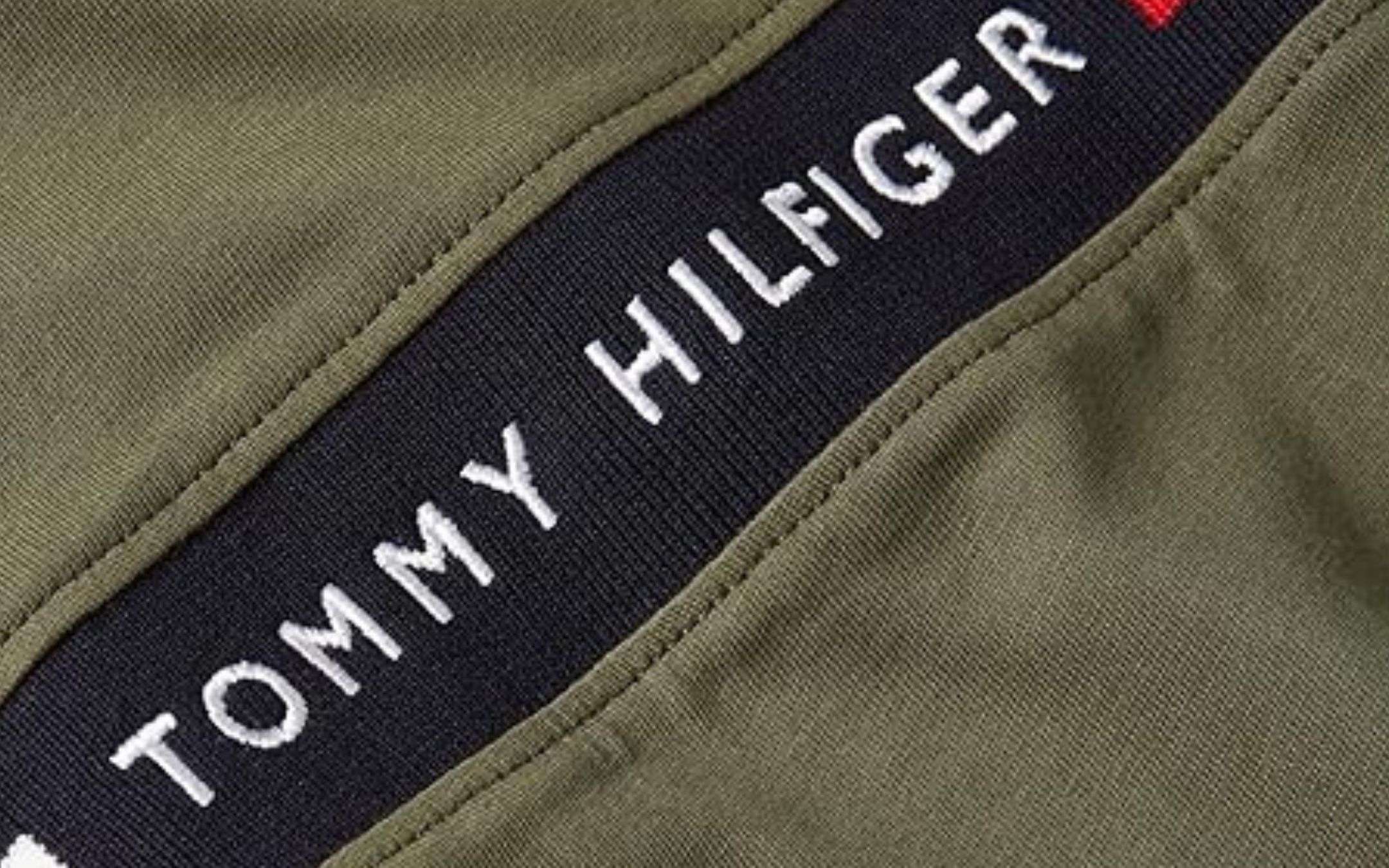





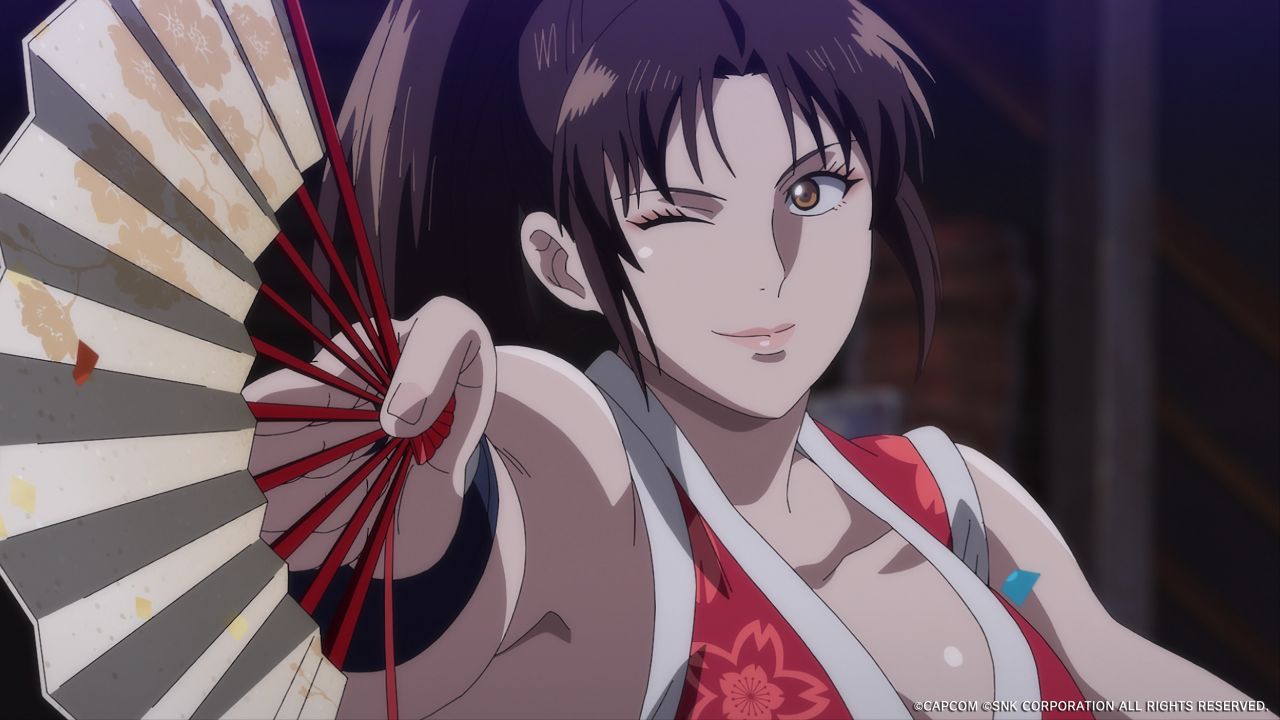






















![La guida allo sport in tv oggi [martedì 4 febbraio] | Il Teleco-Slalom](http://www.loslalom.it/wp-content/uploads/2024/04/teleco.jpg)


/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/03/4094084-83019344-310-310.jpg)




