Dazi: cosa sono, storia e effetti. Dalle guerre commerciali all’era Trump
I dazi doganali sono un’espressione che sembra rimandare a una geopolitica antica. Se è vero che la loro distribuzione è cambiata in modo radicale negli ultimi cinquant’anni, è anche vero che si tratta di strumenti più che mai attuali. Di norma, i dazi sono pagati da chi importa le merci. Spesso costituiscono un freno al commercio, proprio perché alzano i prezzi e rendono alcuni prodotti meno convenienti. Vengono però utilizzati anche per tutelare il mercato interno di un Paese (nel caso dell’Europa, quello comunitario) e per contrastare frodi o traffici illeciti. Sono tornati al centro del dibattito dopo l’elezione a presidente Usa di Donald Trump. Il tycoon, tornato alla Casa Bianca nel gennaio 2025, ha da subito spiegato che avrebbe imposto dazi a diversi Paesi. L’1 febbraio il presidente ha firmato l’ordine esecutivo per imporre dazi (dal 4 febbraio) del 25% contro Canada e Messico e del 10% contro la Cina. Colpiti “prodotti farmaceutici e acciaio” e, successivamente, anche “microchip, petrolio e gas”. Trump ha anche anticipato che presto toccherà all’Ue. L’Unione europea, del resto, a sua volta utilizza i dazi. Nel 2024, ad esempio, aveva deciso di alzare quelli sulle importazioni di auto elettriche cinesi, accusate di causare un danno economico ai produttori interni all’Ue. foto shutterstock Cosa sono i dazi doganali La definizione di dazi doganali è semplice, la loro applicazione spesso molto complessa. Si tratta infatti di imposte indirette applicate sulla quantità o sul valore di beni che attraversano un confine. In alcuni casi (minoritari) i dazi sono in uscita. Succede, ad esempio, nel caso di Stati poveri o in via di sviluppo ricchi di risorse naturali ambite dai Paesi più sviluppati: una sorta di sovrapprezzo con cui ammortizzare il costo di un sovrasfruttamento. Nella maggior parte dei casi, però, i dazi sono in entrata e si applicano cioè ai beni importati. L’effetto immediato è un potenziale incasso fiscale. Ma l’introduzione dei dazi e la loro entità rappresenta molto altro: sono un disincentivo ad acquistare oltreconfine, nel tentativo di favorire le imprese domestiche, penalizzare quelle di un altro Paese o arginare distorsioni commerciali. Sono imposte indirette sui consumi, di riscossione mediata, che colpiscono la circolazione dei beni da uno Stato all’altro. Vengono pagati normalmente alla dogana dall’importatore o dall’esportatore, tramite una dichiarazione doganale. Una volta compiuto il pagamento, la merce in questione può circolare liberamente in un determinato mercato. Breve storia delle dogane L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ripercorso la storia dei dazi in un saggio firmato da Antonio Nicali e curato da Giuseppe Favale. Il sistema doganale era già in auge ai tempi dei Romani, che lo avevano mutuato dai Greci. Il Medioevo e la sua frammentazione territoriale e politica si tradusse in frammentazione doganale. I dazi venivano imposti non solo tra “Stati e Staterelli” ma anche tra Comuni. Si praticavano, spiega il saggio, due tipologie di imposte: sugli scambi e sul transito. Le prime erano più vicine all’idea attuale dei dazi; le seconde, di entità più contenuta, non riguardavano, come dice la parola stessa, l’importazione ma il passaggio delle merci su un territorio. Con la proclamazione del Regno d’Italia, nel 1861, anche la dogana diventa unica, replicando le tariffe che fino a poco prima erano state in vigore nel Regno di Sardegna. Il passaggio dall’assetto nazionale a quello comunitario avviene nel 1968, con l’istituzione dell’Unione doganale dell’Unione europea. Gli Stati membri smettono di applicare dazi alla circolazione interna delle merci, varando una tariffa condivisa per i beni provenienti da Paesi terzi. Che effetto hanno i dazi sulle merci I dazi provocano aumenti anche molto elevati dei prezzi: per questa ragione vengono usati dai governi per ridurre l’utilizzo di una determinata merce all’interno del proprio Paese. In alcuni casi si mette in atto una politica protezionistica, che punta cioè a proteggere la produzione nazionale da fattori esterni. I dazi costituiscono infatti dei freni al commercio, proprio perché rendono le merci molto poco convenienti. Dai dazi alle guerre commerciali Non serve andare al tempo dei romani per scoprire che è tutto cambiato. Oggi le catene di approvvigionamento sono globalizzate e le filiere produttive si intrecciano. Ci sono Paesi che basano la propria economia sulle esportazioni e altri che sono costretti a importare materie prime o componenti. In parole povere: i dazi non sono solo un’imposta ma diventano il tassello di un domino. Va infatti ricordato che l’imposizione di un dazio può portare alla reazione del Paese che lo subisce, con conseguenze negative sulla bilancia commerciale. Nel caso le parti coinvolte si irrigidissero, infatti, potrebbe verificarsi un rallentamento complessivo degli scambi, che non è conveniente per nessuna delle parti coinvolte. Foto: Ansa Facciamo un esempio. Gli Stati Uniti, a partire dalla p

I dazi doganali sono un’espressione che sembra rimandare a una geopolitica antica. Se è vero che la loro distribuzione è cambiata in modo radicale negli ultimi cinquant’anni, è anche vero che si tratta di strumenti più che mai attuali. Di norma, i dazi sono pagati da chi importa le merci. Spesso costituiscono un freno al commercio, proprio perché alzano i prezzi e rendono alcuni prodotti meno convenienti.
Vengono però utilizzati anche per tutelare il mercato interno di un Paese (nel caso dell’Europa, quello comunitario) e per contrastare frodi o traffici illeciti. Sono tornati al centro del dibattito dopo l’elezione a presidente Usa di Donald Trump. Il tycoon, tornato alla Casa Bianca nel gennaio 2025, ha da subito spiegato che avrebbe imposto dazi a diversi Paesi.
L’1 febbraio il presidente ha firmato l’ordine esecutivo per imporre dazi (dal 4 febbraio) del 25% contro Canada e Messico e del 10% contro la Cina. Colpiti “prodotti farmaceutici e acciaio” e, successivamente, anche “microchip, petrolio e gas”. Trump ha anche anticipato che presto toccherà all’Ue.
L’Unione europea, del resto, a sua volta utilizza i dazi. Nel 2024, ad esempio, aveva deciso di alzare quelli sulle importazioni di auto elettriche cinesi, accusate di causare un danno economico ai produttori interni all’Ue.

foto shutterstock
Cosa sono i dazi doganali
La definizione di dazi doganali è semplice, la loro applicazione spesso molto complessa. Si tratta infatti di imposte indirette applicate sulla quantità o sul valore di beni che attraversano un confine.
In alcuni casi (minoritari) i dazi sono in uscita. Succede, ad esempio, nel caso di Stati poveri o in via di sviluppo ricchi di risorse naturali ambite dai Paesi più sviluppati: una sorta di sovrapprezzo con cui ammortizzare il costo di un sovrasfruttamento. Nella maggior parte dei casi, però, i dazi sono in entrata e si applicano cioè ai beni importati.
L’effetto immediato è un potenziale incasso fiscale. Ma l’introduzione dei dazi e la loro entità rappresenta molto altro: sono un disincentivo ad acquistare oltreconfine, nel tentativo di favorire le imprese domestiche, penalizzare quelle di un altro Paese o arginare distorsioni commerciali.
Sono imposte indirette sui consumi, di riscossione mediata, che colpiscono la circolazione dei beni da uno Stato all’altro.
Vengono pagati normalmente alla dogana dall’importatore o dall’esportatore, tramite una dichiarazione doganale. Una volta compiuto il pagamento, la merce in questione può circolare liberamente in un determinato mercato.
Breve storia delle dogane
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ripercorso la storia dei dazi in un saggio firmato da Antonio Nicali e curato da Giuseppe Favale. Il sistema doganale era già in auge ai tempi dei Romani, che lo avevano mutuato dai Greci.
Il Medioevo e la sua frammentazione territoriale e politica si tradusse in frammentazione doganale. I dazi venivano imposti non solo tra “Stati e Staterelli” ma anche tra Comuni. Si praticavano, spiega il saggio, due tipologie di imposte: sugli scambi e sul transito. Le prime erano più vicine all’idea attuale dei dazi; le seconde, di entità più contenuta, non riguardavano, come dice la parola stessa, l’importazione ma il passaggio delle merci su un territorio.
Con la proclamazione del Regno d’Italia, nel 1861, anche la dogana diventa unica, replicando le tariffe che fino a poco prima erano state in vigore nel Regno di Sardegna. Il passaggio dall’assetto nazionale a quello comunitario avviene nel 1968, con l’istituzione dell’Unione doganale dell’Unione europea. Gli Stati membri smettono di applicare dazi alla circolazione interna delle merci, varando una tariffa condivisa per i beni provenienti da Paesi terzi.
Che effetto hanno i dazi sulle merci
I dazi provocano aumenti anche molto elevati dei prezzi: per questa ragione vengono usati dai governi per ridurre l’utilizzo di una determinata merce all’interno del proprio Paese. In alcuni casi si mette in atto una politica protezionistica, che punta cioè a proteggere la produzione nazionale da fattori esterni. I dazi costituiscono infatti dei freni al commercio, proprio perché rendono le merci molto poco convenienti.
Dai dazi alle guerre commerciali
Non serve andare al tempo dei romani per scoprire che è tutto cambiato. Oggi le catene di approvvigionamento sono globalizzate e le filiere produttive si intrecciano. Ci sono Paesi che basano la propria economia sulle esportazioni e altri che sono costretti a importare materie prime o componenti. In parole povere: i dazi non sono solo un’imposta ma diventano il tassello di un domino. Va infatti ricordato che l’imposizione di un dazio può portare alla reazione del Paese che lo subisce, con conseguenze negative sulla bilancia commerciale. Nel caso le parti coinvolte si irrigidissero, infatti, potrebbe verificarsi un rallentamento complessivo degli scambi, che non è conveniente per nessuna delle parti coinvolte.

Foto: Ansa
Facciamo un esempio. Gli Stati Uniti, a partire dalla prima amministrazione Trump e poi con Biden, hanno spinto sui dazi contro la Cina, accusata (più o meno apertamente) di pratiche commerciali scorrette. L’obiettivo era incassare dalle importazioni e incentivare le aziende americane a rivalutare la possibilità di produrre in patria. Il prezzo dei beni cinesi, di fatto, si alza. Ma ci sono due controindicazioni:
- Se la Cina impone dazi in direzione contraria su alcune merci, le imprese statunitensi rischiano di perdere quote in un mercato importante come quello asiatico.
- Se il peso dei dazi è alto, le stesse imprese americane rischiano di dover pagare un costo eccessivo, con danni sulla produzione e sui margini. Basti pensare ai semiconduttori di dispositivi tecnologici, prodotti in Cina e necessari ai grandi brand statunitensi.
L’ultimo esempio di “guerra commerciale” basata sui dazi riguarda la contrapposizione tra Pechino e l’Europa. A ottobre la Commissione Europea (sulla scia di una proposta di legge USA) ha avanzato l’istituzione di dazi sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria dalla Cina. Il motivo: la prospettiva di produrre e vendere auto a costi estremamente bassi avrebbe penalizzato le case europee. La Cina ha però risposto con dazi su beni che i produttori europei ambiscono a vendere in Asia, come brandy, carne e auto di lusso. Una sorta di penalizzazione incrociata che ha portato all’apertura di un negoziato, ancora in corso.
I dazi sull’e-commerce
C’è poi un altro tipo di guerra commerciale. Nuova, com’è relativamente nuovo il settore coinvolto: l’e-commerce.
Per evitare di rallentare la crescita, le barriere doganali sono state piuttosto morbide sulle piattaforme online, anche perché esse sono per propria essenza sovranazionali. La forte crescita di alcuni e-commerce cinesi sta però facendo cambiare orientamento.
Oggi, infatti, l’Unione Europea applica dazi a beni acquistati online dall’estero solo se il loro prezzo supera i 150 euro.
Questo tetto si è trasformato in un indirizzo strategico: gli e-commerce di Pechino hanno puntato proprio su beni dai prezzi contenuti per evitare la tagliola dei dazi, un problema per le imprese europee e per le piattaforme online che operano in UE.
Si sta quindi pensando di abbassare la soglia dei 150 euro, ma con il rischio, come sempre, di innescare reazioni i cui effetti non sono mai del tutto prevedibili.
Dazi Ue sulle importazioni di auto elettriche
A ottobre 2024 la Commissione europea ha deciso di elevare i dazi sulle importazioni di auto elettriche cinesi che beneficiano di sussidi ingiusti e stanno causando una minaccia di danno economico ai produttori Ue.
Dall’inchiesta condotta dall’Ue è emerso che la catena del valore dei veicoli elettrici a batteria in Cina beneficia di sovvenzioni sleali, dalle quali deriva una minaccia di pregiudizio economico ai produttori Ue di veicoli elettrici a batteria.
I dazi Ue hanno una durata di 5 anni e i produttori esportatori cinesi isaranno soggetti ai seguenti dazi compensativi:
- BYD: 17,0%
- Geely: 18,8%
- SAIC: 35,3%.
La reazione della Germania
La Germania, da subito, si è detta non a favore di questa decisione: «I dazi punitivi della Commissione europea si ripercuotono sulle imprese tedesche e i loro prodotti di punta», aveva fatto sapere il ministro tedesco dei Trasporti Volker Wissing.
«I veicoli devono diventare più economici attraverso una maggiore concorrenza, mercati aperti e condizioni di localizzazione significativamente migliori nell’Ue, non attraverso guerre commerciali e preclusioni di mercato».
La reazione dell’Italia
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso aveva invece salutato «con soddisfazione l’annuncio, per tutelare la produzione europea nella piena consapevolezza che abbiamo anche noi: la possibilità di riaffermare in Italia l’industria automobilistica italiana, uno dei settori trainanti dello sviluppo industriale del nostro paese a cui non vogliano assolutamente rinunciare».
Risorse proprie tradizionali
Come si legge sul sito della Commissione europea, i dazi doganali sono definiti risorse proprie tradizionali (Rpt) in quanto sono sempre esistiti come fonte diretta di entrate per il bilancio dell’Ue, a differenza dell’imposta sul valore aggiunto e dei contributi nazionali, che sono messi a disposizione del bilancio dell’Ue dagli Stati membri.
I dazi doganali derivano dalle politiche commerciali. Vengono imposti sulle importazioni di prodotti da paesi non appartenenti all’Ue secondo aliquote determinate nella tariffa doganale comune
Responsabilità degli Stati
Gli Stati membri sono responsabili della riscossione dei dazi e devono disporre di un’adeguata infrastruttura di controllo per garantire che le loro amministrazioni, in particolare le loro autorità doganali, svolgano i loro compiti in modo adeguato
L’unione doganale
All’interno dell’Ue vige invece un’unione doganale, istituita nel 1968, che agevola gli scambi commerciali per le imprese, armonizza i dazi doganali sui beni provenienti dai paesi extra Ue e contribuisce a proteggere i cittadini, gli animali e l’ambiente europei. Le autorità doganali di tutti i Paesi dell’Ue collaborano come se fossero un’unica entità
I vari membri applicano perciò le stesse tariffe alle merci importate nel loro territorio dal resto del mondo, mentre non applicano tariffe fra di loro. Il dazio doganale proveniente dalle merci importate nell’Ue corrisponde a circa il 14% del bilancio totale dell’Unione
Prodotti nocivi
I controlli doganali alle frontiere esterne dell’Ue tutelano i consumatori dalle merci e dai prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute. Proteggono gli animali e l’ambiente contrastando il commercio illegale di specie a rischio di estinzione e prevenendo malattie vegetali e animali
Traffici illeciti
Le autorità doganali collaborano con servizi di politica e immigrazione nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo. Combattono i traffici di esseri umani, droga, armi e merci contraffatte e verificano che chi viaggia con ingenti somme in contanti non stia riciclando denaro, evadendo il fisco o finanziando organizzazioni criminali.
Le dogane dell’Ue lottano anche contro le frodi fiscali e sui dazi doganali da parte di imprese e privati cittadini, che privano i governi nazionali di risorse vitali per la spesa pubblica.
Ue e i dazi sulle auto elettriche cinesi
I balzelli, resi ufficiali e definitivi a ottobre da parte dell’Unione Europea nei confronti delle auto elettriche cinesi, si aggiungono a quelli già in vigore e pari al 10% del valore commerciale delle diverse vettura pulite, e che potranno essere riscossi retroattivamente fino a tre mesi dall’imposizione dei dazi provvisori, decretati il 4 luglio scorso.
La decisione della Commissione europea arriva dopo i tentativi andati a vuoto di una soluzione amichevole e concordata con la controparte cinese, con cui ora il rischio concreto è quello di una vera e propria guerra commerciale aperta.

Foto: Shutterstock
Il governo della Repubblica popolare ha già risposto alle mosse europee con restrizioni sugli alcolici importati dall’Ue, e prima ancora aveva annunciato l’avvio di indagini su presunte misure anti-concorrenziali per i prodotti lattiero-caseari a dodici stelle venduti nel Paese, inchiesta letta a Bruxelles come vera e propria ritorsione commerciale.
L’obiettivo dell’esecutivo comunitario è quello di evitare un’escalation. Se da una parte sulle auto elettriche delle e dalla Cina si impongono dazi che resteranno in vigore cinque anni con la possibilità di un’eventuale estensione, dall’altra parte si continua a negoziare per arrivare ad una fine della guerra dei dazi e congelare questi ultimi quanto prima.
I tecnici della Commissione sono pronti anche a rendersi a Pechino, quando e se le condizioni lo renderanno possibile e necessario, anche se al momento non è in calendario alcun viaggio né alcun incontro.
A Bruxelles regna comunque un senso di frustrazione per una decisione che si sarebbe voluta evitare. Ma siccome le verifiche dell’Ue hanno confermato chiara evidenza di violazione delle regole, alla luce di negoziati infruttuosi il team von der Leyen ha tenuto il punto.
«Adottando queste misure proporzionate e mirate dopo un’indagine rigorosa, stiamo difendendo pratiche di mercato eque e la base industriale europea», aveva sottolineato il commissario per il Commercio, Valdis Dombrovskis.
«Parallelamente, rimaniamo aperti a una possibile soluzione alternativa che sarebbe efficace nell’affrontare i problemi identificati e compatibile con l’Organizzazione mondiale per il commercio (Wto)».
Situazione Usa
Il primo febbraio il presidente Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo per imporre dal 4 febbraio dazi del 25% contro Canada e Messico e del 10% contro la Cina. L’energia canadese sarà tassata del 10%.
«Le misure di oggi sono necessarie per mettere Cina, Messico e Canada davanti alla loro responsabilità di non aver fermato l’ondata di farmaci velenosi negli Stati Uniti», ha affermato la Casa Bianca riferendosi al fentanyl, la droga più potente dell’eroina che ha ucciso milioni di persone negli Usa.

Foto: Ansa
Ha anche accusato il Messico di avere “un’alleanza con i cartelli della droga“.
Il Canada ha risposto imponendo tariffe sul succo d’arancia della Florida, sul whiskey e sul bourbon. Ottawa poi potrebbe sfoderare l’arma più pesante che ha nel suo arsenale: l’energia.
Molti Stati americani sono infatti dipendenti dall’energia canadese e imporre dazi sulle esportazioni negli Stati Uniti farebbe salire i prezzi dell’energia, che Trump ha più volte promesso sarebbero scesi durante la sua amministrazione.
La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha promesso una reazione proporzionata e il ministero del Commercio cinese ha dichiarato che presenterà una causa contro gli Stati Uniti presso l’Organizzazione mondiale del commercio nonché l’adozione di contromisure corrispondenti.

Foto: Ansa
I dazi di Trump alla Cina sono entrati in vigore
Alla mezzanotte di oggi (ora statunitense, le 6 del mattino italiane) sono entrati in vigore i nuovi dazi del 10% sulle importazioni dalla Cina annunciati sabato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
Mentre i dazi del 25% sulle importazioni da Messico e Canada, sono stati posticipati di un mese.
Canada, Messico e Cina sono i tre principali partner commerciali degli Stati Uniti. Molte merci cinesi erano già soggette a un dazio tra il 10 e il 25%; in tutto le importazioni statunitensi dalla Cina valgono ogni anno più di 400 miliardi di dollari (circa 390 miliardi di euro).
Era attesa a ore una telefonata tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, come quelle che ci sono state con Sheinbaum e Trudeau, ma un portavoce della Casa Bianca ha detto che avverrà più avanti questa settimana, senza dare tempistiche precise.
Tra le altre cose, una delle conseguenze dell’ordine esecutivo che conteneva i dazi alla Cina è stata impedire un espediente che aziende cinesi di e-commerce come Temu e Shein utilizzavano per non pagare sulle loro spedizioni i dazi imposti già nel 2018, durante il primo mandato di Trump.
Il governo cinese aveva promesso misure in ritorsione ai dazi, ma non le ha annunciate fino all’ultimo, salvo dire che si rivolgerà all’Organizzazione mondiale del commercio (WTO nella sigla inglese) accusando gli Stati Uniti di averne violato le regole.
Sempre nelle prime ore di oggi la Cina ha risposto dicendo che introdurrà dazi del 15% sulle importazioni dagli Stati Uniti di carbone e gas naturale liquefatto (GNL), e del 10% sul petrolio e i macchinari agricoli.
Questi dazi entreranno in vigore il 10 febbraio. Inoltre il governo cinese ha annunciato un’indagine nei confronti dell’azienda tecnologica statunitense Google: è una misura soprattutto simbolica, visto che i suoi servizi (su tutti il suo motore di ricerca) non sono attivi in Cina dal 2010, a parte nel ramo della pubblicità su internet.
I dazi ai tre paesi erano anche accomunati dall’accusa di Trump che non si stessero impegnando a sufficienza nell’impedire il traffico di droghe illegali verso gli Stati Uniti, e in particolare il fentanyl, un oppiaceo molto potente che negli Stati Uniti ogni anno uccide decine di migliaia di persone.
Sheinbaum e Trudeau hanno accontentato Trump proprio con un maggiore presidio di polizia e forze di sicurezza ai loro confini e con il contrasto al narcotraffico.
Anche l’Ue nel mirino del presidente Trump
Non solo, nel mirino di Trump, sul fronte dei dazi, come ha spiegato lui stesso ripetutamente, c’è anche l’Ue. Da Bruxelles, nelle ultime settimane, più volte è stato ribadito che l’Unione «resterà fedele ai suoi principi e, se necessario, sarà pronta a difendere i propri interessi legittimi».
Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha anche avvertito: «Se il presidente americano non farà marcia indietro, la ritorsione a misure ingiuste e arbitrarie sarà ferma. Anche a costo di mettere a rischio uno dei rapporti commerciali più importanti al mondo».
Controdazi sul made in Usa, nuove intese con altre potenze globali e taglio delle dipendenze strategiche sono le armi nella fondina di Bruxelles se la dottrina del dialogo dovesse rivelarsi fallimentare.
L'articolo Dazi: cosa sono, storia e effetti. Dalle guerre commerciali all’era Trump proviene da Business24tv.it.











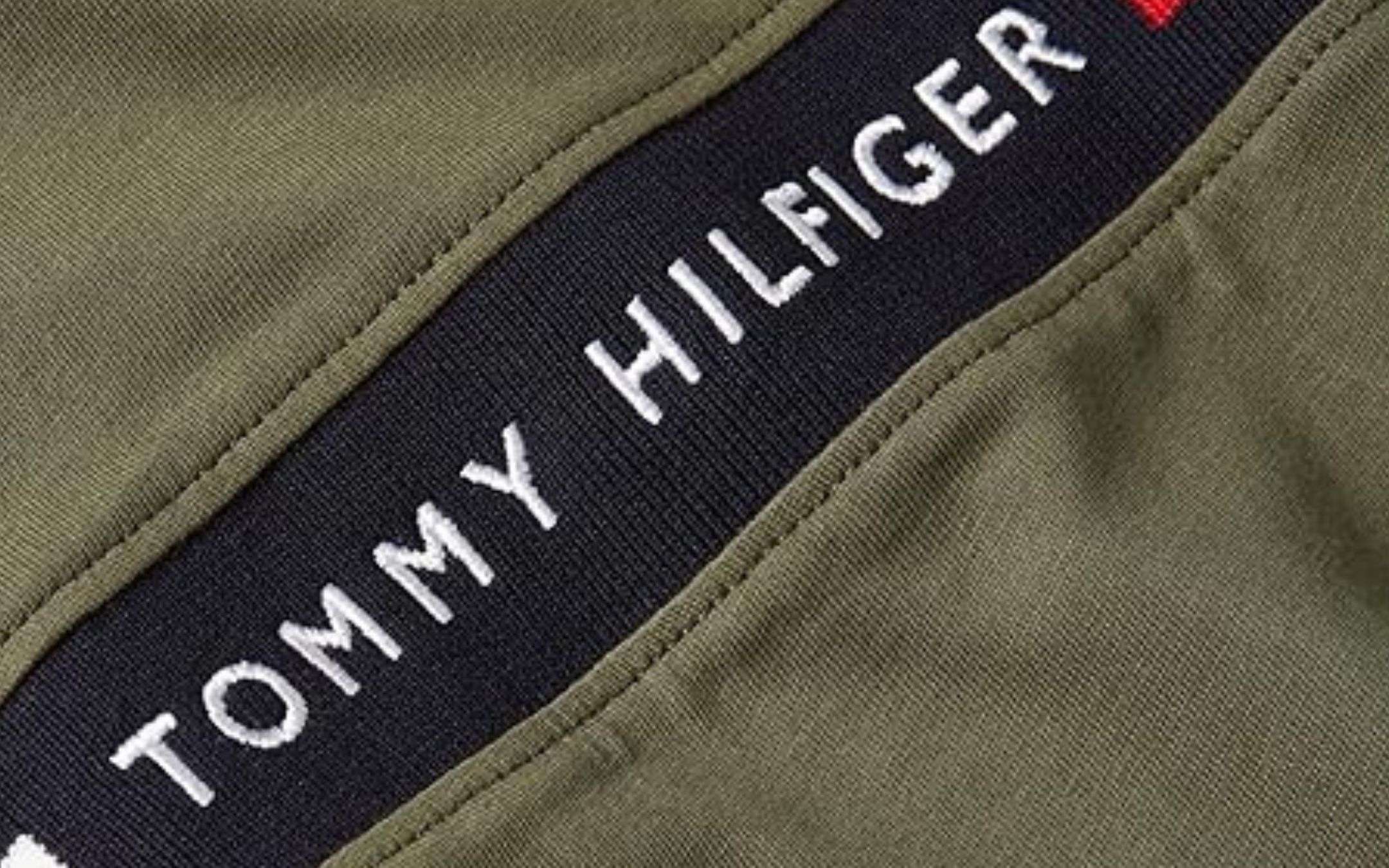





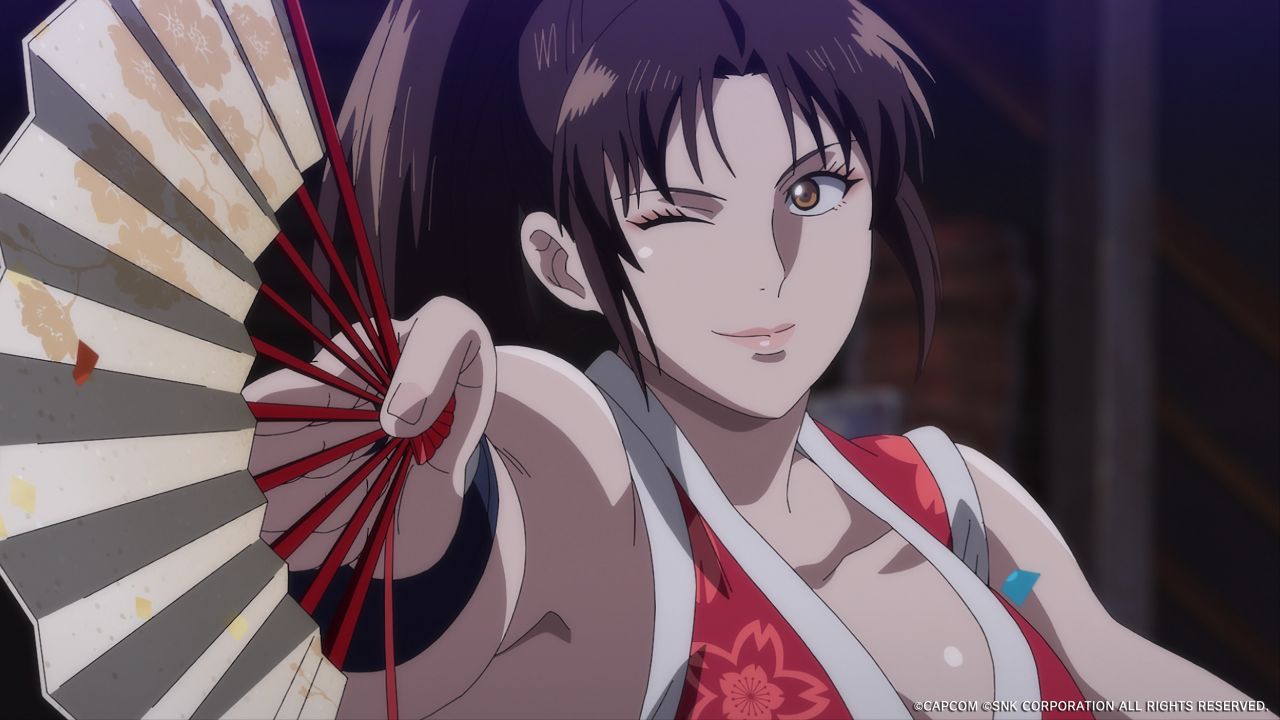






















![La guida allo sport in tv oggi [martedì 4 febbraio] | Il Teleco-Slalom](http://www.loslalom.it/wp-content/uploads/2024/04/teleco.jpg)


/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/03/4094084-83019344-310-310.jpg)













